Pour etre remplace
par un brevet en
notre arrive au
Quartier General.
Varsavia.

Mars 15.
Title: Ricordi di un garibaldino dal 1847-48 al 1900. vol. II
Author: Augusto Elia
Release date: March 30, 2011 [eBook #35716]
Language: Italian
Credits: Produced by Carlo Traverso, Leonardo Palladino, Carla and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
ROMA
TIPO-LITOGRAFIA DEL GENIO CIVILE
1904
Era il mese di aprile, e notizia giungeva che in Sicilia si combatteva per scuotere il giogo borbonico e per la libertà. Già Francesco Crispi, anima della parte più avanzata degli esuli siciliani, presi accordi con Mazzini e col dittatore Farini, che pure era sempre inclinato a tutti gli ardimenti per l'unificazione della patria, si era arrischiato a recarsi nascostamente in Sicilia per dare anima e forza all'insurrezione; i patrioti s'intesero e la sollevazione dell'isola, che le brutalità del governo borbonico avevano resa fremente di libertà, fu deliberata.—Si decise [4]di fare del Convento della Gancia la base di operazione della rivoluzione; e così fu. All'alba del 4 aprile, il suono delle campane a stormo chiamava all'armi la città di Palermo. Alla testa degli animosi, che dovevano cominciare il fuoco, era il popolano Francesco Riso, anima di patriota e di eroe.
Fatalmente, come avviene sempre nelle cospirazioni, vi fu il delatore, che informò il Maniscalco, il quale nella notte fatti occupare tutti gli sbocchi che portavano al Convento, si tenne preparato per soffocare nel sangue la sommossa popolare.
Al suono delle campane fu pronto il Riso ad uscire dal Convento, e furono pronte altre squadre per sostenerlo. Ma sopraffatti dalle soldatesche borboniche che sbucavano da ogni parte, furono ben presto accerchiati e risospinti nel Convento, ove i prodi difensori venderono cara la loro vita; assieme coi trucidati caddero da eroi il Riso ed il Padre Angelo di Monte Maggiore.
Anche le bande armate, che secondo gli accordi da ogni parte si erano accostate ai sobborghi ed alle porte della città, dovettero ritirarsi [5]ai monti non essendo più sostenute dalla insurrezione interna; ma la rivolta non era vinta perchè le squadre non si sgomentarono e non si sciolsero, ma si mantennero nelle alture resistendo agli attacchi.
Al generale Garibaldi furono resi noti questi fatti; ma in seguito le notizie giungevano troppo incerte: quali dicevano che anche gli insorti delle campagne erano stati domati; quali invece affermavano che essi mantenevano coraggiosamente vivo il fuoco dell'insurrezione, dando filo da torcere alle truppe borboniche.
Bisognava accertarsi del vero stato delle cose dell'Isola, e Rosolino Pilo e Corrao, cari patrioti siciliani, si presero l'impegno di sfidare il pericolo di recarsi in Sicilia per abboccarsi cogli insorti, infondere in essi nuova lena per la resistenza e mandare informazioni. A tale uopo Garibaldi consegnava loro una lettera con caldo appello ai patrioti siciliani.
Intanto anche Nicola Fabrizi, grande patriota, mandava da Malta a Crispi non liete novelle sull'insurrezione siciliana. Ma Crispi che voleva [6]far decidere risolutamente Garibaldi alla spedizione, faceva sapere a modo suo che le notizie erano buone.
I più decisi erano Crispi, Bertani, Bixio; Stefano Türr dichiarava che avrebbe seguito Garibaldi in qualsiasi spedizione. Sirtori faceva la stessa dichiarazione; Medici decideva di rimanere per seguire il generale con altre spedizioni.
Le insistenze di Crispi, di Bertani, di Bixio, la vinsero. Il 1o di maggio dalla bocca di Garibaldi usciva la fatidica parola "Partiremo!" Elia, che si teneva sempre presso al generale e che ebbe l'incarico di preparare gli equipaggi, avrebbe voluto chiamare i marinari che aveva avuto sotto i suoi ordini nei legni armati a Rimini, ma Garibaldi non credette di accordargli tale consenso, perchè non voleva si propagasse troppo la notizia della spedizione. A Genova vi erano buoni marinari, fra i quali i nostromi Lorenzo Carbonari, Demetrio Conti e Fabi Eugenio; li arruolò e mandò il Capitano della Marina Mercantile Carlo Burattini, per arruolarne altri a Livorno. Bixio ebbe l'incarico di provvedere al resto, e fu aiutato dal patriota garibaldino Francesco Carbone. Occorrevano vapori e fissò col Rubattino la presa di possesso, a momento opportuno,[7] dei due vapori "Piemonte" e "Lombardo". Tutto fu in breve pronto. Nella notte del 4 al 5 maggio chiamato in casa sua Andrea Rossi (uno dei comandanti dei legni armati a Rimini) ed Elia, Bixio dispose che Rossi prendesse possesso senza rumore del "Piemonte" con metà dell'equipaggio e con Schiaffino ed Elia, con l'altra metà dell'equipaggio e con Menotti Garibaldi, s'impossessasse del "Lombardo".
La presa di possesso dei vapori fu eseguita col massimo ordine e silenzio. Quando Bixio arrivò col rimorchiatore, gli ormeggi erano già stati abbandonati, e tutto era pronto. Accodato al rimorchiatore il "Piemonte", e dietro al "Piemonte" il "Lombardo", alle 5 del mattino del 5 maggio i vapori erano già fuori di Quarto, per ricevere a bordo il generale Garibaldi ed i mille suoi seguaci.
Prima d'imbarcarsi il generale Garibaldi aveva raccomandato al suo grande amico Medici di preparare altre legioni che, da lui comandate, lo avessero raggiunto in Sicilia se la sorte gli fosse stata propizia—e il Medici, ossequiente ai desideri di Garibaldi, scriveva al Panizzi a Londra così:[8]
Genova, 6 maggio 1860.
Caro Panizzi,
"Garibaldi con 1000 uomini corre il mare in due battelli a vapore da ieri mattina alla volta della Sicilia. L'impresa è generosa; Dio la proteggerà, e proteggerà la fortuna dell'eroico condottiero.
"Io sono rimasto per appoggiare l'ardita iniziativa con una seconda spedizione, o meglio con una potente diversione altrove; ma i mezzi ci mancano. Bertani ha fatto miracoli di attività che molto hanno prodotto, ma che la prima spedizione ha completamente esauriti.
Caro Panizzi, non lasciarci soli, non lasciamo solo il nostro Garibaldi e i suoi generosi compagni".
Tuo affmo
Medici
Effettuatosi l'imbarco nel più breve tempo possibile, si fece rotta per la riviera di Levante a piccola velocità attenti tutti se si vedevano le barche che ci dovevano portare a bordo le carabine inglesi, i revolvers e le munizioni.
Appena montato sul ponte di comando del[9] "Piemonte" Garibaldi aveva domandato al Castiglia ed al Rossi se si erano imbarcate queste armi. Avuta risposta negativa, sorse nella sua mente un terribile dubbio: egli fece tosto segnalare al "Lombardo" di accostarsi e arrivato a portata, con voce tonante, gridò:
—Bixio, quanti fucili e munizioni avete caricati?
—Mille fucili—rispose Bixio.
—E i revolvers, le carabine e le cartucce? ribatté Garibaldi.
—Null'altro, replicò Bixio.
Fu un brutto colpo—e si pensò ad un basso tradimento—Anche da Livorno ci dovevano venire armi e munizioni, ma anche quelle mancarono.
Il "Piemonte", comandato da Garibaldi in persona, procedeva avanti. Aveva per ufficiali, sotto gli ordini suoi, Castiglia comandante in seconda, Rossi, Schiaffino e Gastaldi; con Garibaldi erano Crispi, Türr, Sirtori, Missori, e Nuvolari.
Seguiva il "Lombardo" comandante Bixio, secondo comandante Elia, ufficiali Dezza, Menotti Garibaldi, e Carlo Burattini, capo macchinista Orlando Giuseppe.[10]
Per quanto costeggiando, si cercassero per ogni dove, le barche con le armi e munizioni non si presentavano in vista; e perduta ormai la speranza, il generale ordinò rotta a tutta forza pel canale di Piombino.
Il "Piemonte" ed il "Lombardo" portavano sul loro bordo l'Italia e la sua fortuna; se la spedizione riusciva, l'unità della patria era assicurata; se falliva, i Mille sarebbero sempre rimasti immortali!
La spedizione del resto non si nascondeva al nemico: la pubblicità data alla lettera lasciata da Garibaldi a Bertani prima della partenza, la rendeva nota al mondo. Eccola:
Genova, 5 maggio 1860
Mio caro Bertani,
"Spinto nuovamente sulla scena degli avvenimenti patrii, io lascio a voi il seguente incarico.
"Raccogliere quanti mezzi sono possibili per coadiuvarci nella nostra impresa.
"Procurare di far capire agli Italiani, che se saremo aiutati devotamente, sarà fatta l'Italia in poco tempo e con poca spesa; ma che[11] non avranno fatto il dovere, quando si limiteranno a qualche sterile sottoscrizione.
"Che l'Italia libera, d'oggi in luogo di 20,000 soldati deve armarne 500,000, numero non certamente sproporzionato alla popolazione, poichè tale proporzione di soldati l'hanno gli Stati vicini, che non hanno indipendenza da conquistare.
"Con tale esercito l'Italia non avrà più bisogno di padroni stranieri, che se la mangiano a poco a poco col pretesto di liberarla.
"Che ovunque sono italiani che combattono oppressori, fa bisogno spingere gli animosi e provvederli del necessario per il viaggio.
"Che l'insurrezione siciliana non solo in Sicilia bisogna aiutare, ma dovunque sono nemici da combattere.
"Io non consigliai il moto della Sicilia, ma venuti alle mani quei fratelli nostri, io ho creduto obbligo di aiutarli.
"Il nostro grido di guerra sarà Italia e Vittorio Emanuele e spero, che anche questa volta, la bandiera italiana non riceverà sfregio.
Vostro con affetto
G. Garibaldi"
Altra lettera aveva già diretta il giorno innanzi al Re Vittorio Emanuele:
Genova, 4 maggio 1860
Sire,
"Il grido d'affanno, che dalla Sicilia arrivò alle mie orecchie ha commosso il mio cuore e quello di alcune centinaia dei miei vecchi compagni d'armi. Io non ho consigliato il movimento insurrezionale dei miei fratelli di Sicilia, ma dal momento che essi si sono sollevati a nome dell'unità italiana, di cui Vostra Maestà è la personificazione, contro la più infame tirannia dell'epoca nostra, non ho esitato di mettermi alla testa della spedizione. So bene, che m'imbarco per un'impresa pericolosa, ma pongo confidenza in Dio, nel coraggio e nella devozione dei miei compagni.
"Il nostro grido di guerra sarà sempre "Viva l'Unità Italiana!" "Viva Vittorio Emanuele, suo primo e più bravo soldato!"
"Se noi falliremo, spero che l'Italia e l'Europa liberale, non dimenticheranno che questa impresa è stata decisa per motivi, puri affatto da egoismo, ed interamente patriottici.[13]
"Se riusciremo, sarò superbo di ornare la Corona di Vostra Maestà di questo nuovo e brillantissimo gioiello, a condizione tuttavia, che Vostra Maestà si opponga a ciò che i di Lei consiglieri cedano questa Provincia allo straniero, come hanno fatto della mia terra natale.
"Io non ho partecipato il mio progetto a Vostra Maestà; temevo infatti, che per la reverenza che Le professo, Vostra Maestà non riuscisse a persuadermi d'abbandonarla.
"Di V. Maestà, Sire, il più devoto suddito
G. Garibaldi"
Ed all'esercito scriveva così:
Soldati Italiani,
"Per alcuni secoli la discordia e l'indisciplina furono sorgenti di grande sciagure pel nostro paese. Oggi è mirabile la concordia che anima le popolazioni tutte dalla Sicilia alle Alpi. Però di disciplina difetta ancora, e su di voi, che sì mirabile esempio ne deste e di valore, essa conta per riordinarsi e compatta presentarsi al cospetto di chi vuole manometterla. Non vi sbandate dunque, o giovani, resto delle patrie battaglie; sovvenitevi che anche nel settentrione[14] abbiamo nemici e fratelli schiavi—e che le popolazioni del mezzogiorno, sbarazzate dai mercenari del Papa e del Borbone, abbisogneranno dell'ordinato vostro marziale insegnamento, per presentarsi a maggiori conflitti.—
"Io raccomando dunque, in nome della patria rinascente, alla gioventù che fregia le file del prode esercito di non abbandonarle, ma di stringersi vieppiù ai loro valorosi ufficiali ed a Vittorio Emanuele, la di cui bravura può essere rallentata un momento dai pusillanimi consiglieri, ma che non tarderà molto a condurci tutti a definitiva vittoria.
G. Garibaldi"
La mattina del 7 maggio i due piroscafi andarono ad ancorare a Talamone, a breve tratto dal porto S. Stefano e della fortezza di Orbetello. Garibaldi, sceso a terra, vestito da generale del 1859, ottenne dal comandante del luogo tutto quello che gli occorreva, limitatamente alla possibilità sua; così si ebbe un piccolo numero di fucili arrugginiti ed una vecchia colubrina. Saputo dal comandante di Talamone, che nel forte di Orbetello sì trovava altro armamento, il generale[15] vi spediva il colonnello Türr con una sua lettera chiedente al colonnello Giorgini, comandante del forte, armi e munizioni. Verso sera giungeva col Türr, lo stesso comandante di Orbetello, il quale fatto persuaso dal Türr che la spedizione di Garibaldi era fatta sotto gli auspici del Re, aveva messo a disposizione del generale tutto quello che di armamento si trovava nel forte, e cioè quattro cannoni da sei con 1200 cariche, alcuni fucili, cartucce ecc. Dei quattro cannoni due erano col fusto, due senza.
Una parte dello scopo era raggiunto, ma il generale approdando a Talamone aveva in animo un disegno molto più alto. Il pensiero, vagheggiato nel 1859 di una invasione nello Stato Pontificio per la Cattolica non era mai stato da lui dimenticato. Egli sperava che, data la spinta, sapendosi la Sicilia sollevata, una vasta sommossa avrebbe messo in fiamme la Penisola tutta; per cui, fatto chiamare a se il colonnello Zambianchi, gli affidava l'incarico d'invadere lo Stato Pontificio dalla parte di Orvieto, per promuovervi la rivoluzione. A tal uopo staccò dagli imbarcati una schiera di 60 prodi armati e consegnato al Zambianchi un manifesto pei Romani[16] ed un foglio d'istruzioni, gli ordinò dì prepararsi alla partenza. Fra i tanti bravi che ebbero ordine di accompagnare il Zambianchi eranvi pure i cari compagni Guerzoni, Pittaluga e Galliano.
Il manifesto diceva così:
Romani,
"Domani voi udirete dai preti di Lamoricière, che alcuni mussulmani hanno invaso il vostro terreno. Ebbene questi mussulmani sono gli stessi che si batterono per l'Italia a Montevideo, a Roma, in Lombardia! Quelli stessi che voi ricorderete ai vostri figli con orgoglio, quando giunga il giorno che la doppia tirannia dello straniero e del prete vi lasci la libertà del ricordo! Quelli stessi che piegarono per un momento davanti ai soldati agguerriti e numerosi di Bonaparte, ma piegarono colla fronte rivolta al nemico, ma col giuramento di tornare alla pugna, e con quello di non lasciare ai loro figli altro legato, altra eredità, che quella dell'odio all'oppressore ed ai vili!
"Sì, questi miei compagni combatterono fuori delle vostre mura accanto a Manara, Melara,[17] Masina, Daverio, Peralta, Panizzi, Ramorino, Mameli, Montaldi, e tanti vostri prodi che dormono presso alle vostre catacombe, ed ai quali voi stessi deste sepoltura perchè feriti per davanti.
"I vostri nemici sono astuti e potenti, ma noi marciamo sulla terra degli Scevola, degli Orazi e dei Ferrucci; la nostra causa è la causa di tutti gli Italiani: il nostro grido di guerra è lo stesso che risuonò a Varese ed a Como "Italia e Vittorio Emanuele" e voi sapete che con noi, caduti o viventi, sarà illeso l'onore italiano.
G. Garibaldi
generale Romano, nominato da un governo
eletto dal suffragio universale".
Prima di partire da Talamone scriveva a Bertani così:
Caro Bertani,
"Nella notte della nostra partenza si smarrirono due barche che portavano le munizioni, i capellozzi, tutte le carabine e revolvers, 230 fucili ecc. Nel giorno seguente cercammo indarno tali barche per molte ore, e poi proseguimmo.[18]
"Qui abbiamo rimediato alle principali urgenze, grazie alla buona volontà delle autorità di Orbetello e di queste.
"Fra poco avrete altre notizie di noi.
"Frattanto fate ritirare tutti gli oggetti suddetti.
"Con affetto.
"Talamone, 8 maggio
Vostro: G. Garibaldi
Poi perchè nessuno dovesse aver danno in causa della presa di possesso dei due vapori "Piemonte" e "Lombardo" mandava a Genova la seguente lettera:
Ai Signori Direttori dei Vapori Nazionali
Signori,
"Dovendo imprendere un'operazione in favore d'italiani militanti per la causa della patria, di cui il governo non può occuparsi per diplomatiche considerazioni, ho dovuto impadronirmi di due vapori dell'amministrazione dalle LL. SS. diretta e farlo all'insaputa del governo stesso e di tutti.
"Io attuai un atto di violenza: ma comunque vadano le cose io spero che il mio procedimento[19] sarà giustificato dalla santa causa da noi servita e che il paese intero vorrà riconoscere come debito suo da soddisfare, i danni da me recati all'amministrazione.
"Quandochè non si verificassero le mie previsioni sull'interessamento della Nazione per indennizzarli, io impegno tutto quanto esiste in denaro e materiale, appartenente alla sottoscrizione pel milione di fucili, acciocchè con questo si paghi qualunque danno, avaria, o perdita a LL. SS. cagionata. Con tutta considerazione
G. Garibaldi
Genova, 5 maggio 1860.
Alla mattina dell'8 maggio, salpati da Talamone, ancorarono nel porto vicino di S. Stefano per prendervi il resto delle provvigioni, ed alla sera si misero in rotta per ponente libeccio colla prua verso l'Africa. Fra le istruzioni date dal generale Garibaldi a Bixio, principali erano le seguenti: Seguire il "Piemonte", e se si fosse incontrata qualche nave da guerra nemica, correre addosso all'arrembaggio.
Prima di lasciare Talamone venne affisso sull'albero di maestro dei due vapori il seguente[20]
ORDINE DEL GIORNO:
Maggio 7, di bordo del Piemonte.
"Cacciatori delle Alpi!
"La missione di questo Corpo è basata sull'abnegazione la più completa davanti alla rigenerazione della patria. I prodi cacciatori servirono e serviranno il loro paese colla devozione e disciplina dei migliori corpi militari, senz'altra speranza che quella della loro incontaminata coscienza. Non gradi, non onori, non ricompense allettarono questi bravi.
"Essi si rannicchiarono nella modestia della loro vita privata allorchè scomparve il pericolo; ma, suonando di nuovo l'ora della pugna, l'Italia li rivede ancora in prima fila, volenterosi e pronti a versare il loro sangue per essa.
"Il grido di guerra dei Cacciatori delle Alpi è lo stesso che rimbombò sulle sponde del Ticino, or son dodici mesi: "Italia e Vittorio Emanuele" e questo grido, pronunciato da eroi, susciterà spavento ai nemici d'Italia.—-
G. Garibaldi"
L'organizzazione del corpo era la seguente:
Stato Maggiore
Sirtori Giuseppe, capo di stato maggiore. Türr, primo aiutante del generale Garibaldi. Crispi, segretario di stato. Manin, Salvino, Maiocchi, Grazziotti, Borchetta, Bruzzesi, Cenni, Montanari, Bandi, Stagnetti, ufficiali d'ordinanza.
Basso Giovanni, segretario generale.
Comandanti delle Compagnie
| Nino Bixio, | comandante la | 1a | Compagnia |
| Orsini | " | 2a | " |
| Stocco | " | 3a | " |
| La Masa | " | 4a | " |
| Anfossi | " | 5a | " |
| Carini | " | 6a | " |
| Cairoli | " | 7a | " |
Intendenza
Acerbi, Bovi, Maestro, Rodi
Corpo Medico
Ripari, Giulini, Boldrini
Un ordine di Garibaldi diceva:
"L'organizzazione è la stessa dell'Esercito italiano a cui apparteniamo, ed i gradi, più che[22] al privilegio, al merito, sono gli stessi già coperti su altri campi di battaglia.
G. Garibaldi"
Prima di lasciare S. Stefano Garibaldi fece formare un'ottava compagnia, comandante Bassini; della 2a fu dato il comando a Dezza e l'Orsini ebbe il comando dell'artiglieria.
In due giorni di viaggio nulla di notevole accadde.
La sera del 10 all'11 maggio il "Piemonte" fatto forza di macchina, cominciò a lasciarsi indietro il "Lombardo" che camminava due nodi all'ora di meno, fino a scomparire totalmente dalla vista dei comandanti, per quanto si fosse fatto attivare maggior combustibile per mantenersi vicini.
Era certo intenzione del generale Garibaldi di spingersi quanto più avanti poteva, per scoprire il Marittimo, prima del cadere della notte: però, se per il "Piemonte", che portava con sè il comandante della spedizione tutto andava bene, non era così del "Lombardo" che, perduto di vista il "Piemonte", aveva perduta la sua guida, e non sapeva quale direzione tenere. Intanto la notte era scesa oscura, e Bixio sul[23] ponte di guardia, con l'ansietà di chi sente una gravissima responsabilità pesare sopra di sè, stava assieme con Elia, spiando se da prua si scoprisse una traccia del "Piemonte". Si era giunti in vista del Marittimo ed il "Piemonte" non si vedeva. Ad un tratto dal timoniere si dà l'avviso, che un vapore era in vista dalla parte di poppa; ed infatti dal lato opposto a quello ove il "Piemonte" era scomparso se ne scopriva uno, che si avanzava su noi guadagnando rapidamente sul nostro cammino. Esso aveva, i fanali spenti; questa precauzione (che se era necessaria per noi, che volevamo passare inosservati, non poteva esserlo per un pacchetto postale od altro ordinario vapore) fece credere a Bixio che avessimo a che fare con un naviglio borbonico in crociera; ordinò quindi che si desse la maggiore velocità alla macchina e che tutto si approntasse per un arrembaggio, se non fosse stato possibile evitare il combattimento.
La nave che si supponeva nemica intanto si avanzava sempre più, il che rendeva impossibile ogni sforzo per non essere raggiunti. Bixio, raccomandando il silenzio, tutto dispose per l'arrembaggio e per una pronta ed energica azione[24] pregando Elia di prendere egli stesso il timone per meglio dirigere l'abbordaggio. Era il vapore giunto a breve distanza, quando il suono della campana colla quale il generale Garibaldi era uso comandare le manovre del naviglio, ed al quale Elia si era abituato nei passati giorni di continua sorveglianza, venne a colpire le sue orecchie. Lasciò Elia subito il timone ad un marinaio corse sul ponte di guardia per avvisare Bixio che il vapore che faceva forza di macchina per raggiungere il "Lombardo" era il "Piemonte", e tale fu la convinzione che Elia mise in questa asserzione, e tanta era la fiducia che Bixio aveva nel suo secondo, che ordinò alla macchina di fermare per attendere l'arrivo del generale; e difatti poco appresso la voce di Garibaldi si faceva sentire nelle tenebre, ordinando di dirigere su Marsala!
Verso le nove del mattino il "Piemonte" ed il "Lombardo" erano in prossimità di Marsala, quando dalla punta di Mazzara si scoprirono tre legni da guerra borbonici, che si avanzavano rapidamente per tagliare il cammino alla spedizione ed impedirle l'arrivo in quel porto. A costo di far saltare le caldaie bisognava[25] fare sforzi di macchina supremi, per arrivare primi; ed a ciò si riuscì. Il "Piemonte" arrivato avanti il "Lombardo" sia perchè pescava meno, sia perchè potè rasentare più il molo, passò liberamente e si accostò al molo stesso, al riparo dell'antimurale del porto.
Il "Lombardo" invece per il suo maggiore pescaggio rimase in secco a pochi passi dalla bocca del porto. Messe a mare le imbarcazioni, Bixio scese tosto a terra per raggiungere il generale, lasciando ad Elia gli ordini per lo sbarco dei volontari, delle armi e munizioni.
Elia ordinò tosto a Burattini di requisire quante imbarcazioni si trovavano nel porto, e giunte queste in numero sufficiente, si effettuò lo sbarco con ordine e prontezza ammirabile. Presa terra la parte dei Mille che erano sul "Lombardo", scaricate le munizioni e le armi, il generale Garibaldi mandò ordine ad Elia di uscire dal porto, e procurare di raggiungere Genova per mettersi a disposizione del Comitato presieduto da Bertani. Dovevasi ubbidire! ma mentre Elia provava di trarre dal secco il vapore, obbedendo con dolore agli ordini del generale, i legni borbonici presero a lanciare delle[26] bordate: sicchè poco appresso, vedendo che i legni napolitani avevano messe a mare le imbarcazioni armate e s'avanzavano per impossessarsi dei nostri vapori, ordinò ai marinari di entrare nelle imbarcazioni, e fatte aprire le valvole della macchina, perchè penetrasse l'acqua nella stiva, e si impedisse che il "Lombardo" cadesse preda del nemico, come avvenne poi del "Piemonte", scesero tutti a terra.
È bello, è doveroso il dire che fu ammirevole l'accoglienza fatta agli sbarcati dalla patriottica cittadinanza marsalese. Essa accolse i Mille con esultanza. Vecchi e giovani, uomini e donne—persone civili e popolani fecero a gara per usare loro ogni sorta di gentilezze—facendo echeggiare grida di "evviva Garibaldi".
Il generale dispose che Missori occupasse con forza la porta Trapani.
Bruzzesi, vestito da ufficiale dei bersaglieri, con una pattuglia di camicie rosse, ebbe ordine di occupare l'ufficio postale e telegrafico.
Mosto, coi bravi carabinieri genovesi, fu appiattato nella scogliera che forma il porto per respingere le imbarcazioni armate distaccate[27] dalle navi da guerra borboniche e difatti pochi tiri delle brave carabine bastarono a metterle in ritirata. Le truppe rimasero scaglionate durante la notte, a destra e a sinistra della città.
Ecco il proclama che il generale Garibaldi indirizzava al popolo Siciliano appena sbarcato a Marsala:
Siciliani,
"Io vi ho guidato una schiera di prodi, accorsi all'eroico grido della Sicilia. Resto delle battaglie lombarde, noi siamo con voi e non chiediamo altro che la liberazione della vostra terra. Tutti uniti, l'opera sarà facile e breve. All'armi dunque; chi non impugna un'arma è un codardo o un traditore della patria. Non vale il pretesto della mancanza delle armi. Noi avremo fucili, ma per ora un'arma qualunque ci basta, impugnata dalla destra di un valoroso.
"I Municipi provvederanno ai bimbi, alle donne ed ai vecchi derelitti. All'armi tutti! La Sicilia insegnerà ancora una volta, come si liberi un paese dagli oppressori, colla potente volontà di un popolo unito.
G. Garibaldi"
Occorreva però non perdere tempo, e marciare avanti al più presto. Garibaldi comandò quindi che all'alba dell'indomani tutta la colonna fosse pronta alla partenza, ed infatti la mattina si metteva per la via di Salemi. A Rampagallo, feudo del Barone Mistretta, fu ordinato il grand'alto per pernottarvi. Fu in questa prima tappa, che si ebbero i primi segni dell'insurrezione siciliana, perchè vedemmo con gioia arrivare le bande comandate dai Baroni di S. Anna, e quelle del Barone Mocarta. Saranno stati un'ottantina, armati di schioppetti.
Intanto fu riordinata la Legione, già ripartita in otto compagnie; si formarono con esse due battaglioni ai comandi di Bixio e Carini, e si organizzò coi marinai del "Piemonte" e del "Lombardo" una compagnia di cannonieri.
Alla mattina seguente la colonna si rimetteva in via per Salemi, dove, dopo una marcia alquanto faticosa, arrivava accolta da grande festa di popolo, e al suono delle campane e di musica. Un vero delirio! A Salemi, il generale pubblicò il Decreto col quale per volontà dei liberi comuni di Sicilia, ed in nome di Vittorio Emanuele, Re d'Italia, assumeva la Dittatura.[29]
Italia e Vittorio Emanuele.
"Giuseppe Garibaldi, comandante in capo l'armata nazionale in Sicilia, invitato dai principali cittadini e sulla deliberazione dei Comuni liberi dell'Isola, considerando che in tempo di guerra è necessario che i poteri civili e militari sieno concentrati nelle medesime mani, decreta di prendere la dittatura di Sicilia in nome di Vittorio Emanuele.
Salemi, 14 maggio.
G. Garibaldi
Altre bande intanto arrivavano, comandate da Giuseppe Coppola e dal frate Pantaleo, che davano notizia che Rosolino Pilo e Corrao tenevano sempre la campagna e con una mano di prodi erano nelle alture di S. Martino, dominanti Monreale; si sapeva pure che verso Missilmeri mantenevansi, asserragliati sulla montagna, il La Porta, il Firmatari, il Piediscalzi, il Paternostro, e, cosa significantissima e per noi sorprendente, il clero faceva parte della rivoluzione e ne era il principale istigatore.
Ma il Borbone non stava inoperoso. Ordini erano stati dati al comando delle truppe di Sicilia,[30] per arrestare la marcia dei garibaldini e distruggerli.
Infatti nella notte del 14 al 15 maggio Garibaldi aveva notizia che il generale Landi con un corpo di 3000 uomini ed artiglieria marciava su Calatafimi, e che a quella volta si era pure avviato il presidio di Trapani.
Le bande dei Picciotti non erano ancora giunte nel numero che il generale avrebbe desiderato. Era dunque da pensare bene se con lo scarso numero di volontari male armati, fosse prudente attaccare posizioni fortissime, coperte ai fianchi ed alle spalle e difese da truppe regolari armate da buone carabine e da artiglieria.
Non sarebbe forse stato più prudente consiglio trincerarsi in Salemi, occupare coi Picciotti le alture circostanti ed attendervi l'attacco?
Sì sarebbe potuto ricevere il nemico con una energica controffensiva e costringerlo alla ritirata; le bande avrebbero avuto tempo di formarsi numerose ed accorrere in aiuto, attaccando il nemico alle spalle.
Ma Garibaldi era impaziente di misurarsi col nemico; sentiva nell'animo che una vittoria gli era necessaria; senza di che tutto sarebbe stato compromesso e, forse, tutto perduto.[31]
Non era dunque il caso di attendere il nemico a Salemi; bisognava andargli incontro audacemente, romperlo e sloggiarlo ad ogni costo da Calatafimi.
E così fu deciso.
La posizione nella quale eransi accampati i napolitani, chiamata fin dall'epoca romana "il Monte del Pianto" era forte per se stessa, perchè mentre impediva un rapido attacco, offriva validissimo riparo alla difesa.
Da Vita, villaggio che si erge su di un poggio a cinque chilometri circa da Salemi, Garibaldi dispose che le bande Siciliane che sopraggiungevano e si andavano raccogliendo, si distendessero il più diffusamente possibile sul dorso delle colline a destra e a sinistra della strada, mostrandosi sempre pronte alla pugna. Dopo questo spiegamento Garibaldi ordinava la marcia in avanti della colonna, con la sinistra in testa.
Precedeva Carini con l'ottava compagnia cui tenevano dietro la settima, la sesta e la quinta; al centro marciava l'artiglieria i cui avantreni consistevano in carri comuni a due ruote; poi alcuni volontari del genio, e i marinari del Piemonte[32] e del Lombardo. Seguiva il battaglione Bixio con le altre quattro compagnie.
Durante la marcia Garibaldi si spingeva in avanti con alcune sue guide, avendo al fianco il capitano Menotti suo figlio, il capitano Schiaffino ed il maggiore Elia, i quali non avendo voluto accettare comandi, formavano la guardia del corpo del generale. Osservata la posizione del nemico, che, colla sua linea di cacciatori coronava l'altura del "Pianto", senza indugio inviava ai suoi l'ordine di schierarsi sulle pendici di Monte Pietralunga e sulla strada.
Egli aveva appena le forza di un battaglione sul piede di guerra, e dovette disporlo secondo esigeva il terreno, lo scarso numero dei suoi e la posizione formidabile del nemico.
Stabilì quindi un ordinamento profondo e rado in linee successive; i Carabinieri Genovesi in prima linea dietro ripari naturali; poi stese l'ottava e la settima compagnia in cacciatori colle squadriglie a brevi intervalli sul versante dell'avvallamento che separava la sua posizione da quella nemica e le teneva nascoste nel grano già alto; in seconda linea stavano le altre due compagnie 6a e 5a, pure in ordine rado, quasi sul[33] ciglio; ed a rovescio del ciglio aspettava il battaglione di Bixio in riserva.
Questo schieramento si fece in ordine mirabile.
Da una parte e dall'altra delle alture apparivano secondo l'ordine di Garibaldi, sui verdi dossi gli insorti siciliani, che per entusiasmo sparavano i loro fucili e mandavano alte grida di guerra, che si ripercuotevano minacciose per le lontane campagne.
Questa apparizione, nel momento in cui si stava per venire alle mani, dovette certo, come aveva preveduto il generale, produrre sgomento e depressione nell'animo delle truppe napoletane, mal disponendole alla battaglia.
Verso il mezzogiorno parve che il nemico accennasse ad un serio attacco. I suoi sostegni si avvicinarono alla linea dei cacciatori, la quale cominciò a spiegarsi, scendendo per la costa del monte del Pianto. Per giungere fino a noi, doveva toccare il fondo del Monte, passare la convalle e rimontare la china verso l'altura di Pietralunga. Garibaldi avrebbe avuto grande vantaggio nell'attirare il nemico in basso, attendendolo a piè fermo nella posizione occupata dai suoi;[34] egli veniva a paralizzare così la superiorità delle sue armi da fuoco e al momento opportuno, che egli avrebbe saputo ben cogliere, avrebbe potuto rovesciare addosso ai Napoletani le forze garibaldine coll'impeto irresistibile dell'attacco alla baionetta. A questo intento Garibaldi ordinò ai suoi di star tranquilli, distesi a terra e di non sparare alcun colpo.
Ma l'offensiva dei napoletani fu un lampo passeggiero e si arrestò poco dopo iniziata; invece di un attacco a fondo, essi si limitarono a mandare qualche colpo di fucile, le cui palle fischiarono alle orecchie dei garibaldini come un eccitamento del quale essi non avevano davvero bisogno. Ma non si doveva rispondere, bisognava mordere ancora il freno!
Intanto Bixio, di cui è da immaginarsi l'impazienza di venire alle mani, venne a spiegarsi a sinistra di Carini col suo battaglione su due linee, completando l'ordine di battaglia con dinanzi i Carabinieri Genovesi, all'ala destra, Bixio alla sinistra; Orsini sulla strada colla sua microscopica artiglieria. Garibaldi intanto con a fianco Turr suo aiutante di campo e Sirtori capo di Stato Maggiore, stava spiando il più fuggevole[35] dei momenti tattici; quello che decide sempre della vittoria.
Vedendo che il nemico non si spingeva all'attacco desiderato, ma rimaneva immobile, egli ordinò si suonasse la sveglia, sperando che questo segnale servisse a scuoterlo. L'effetto prodotto da quel suono di tromba fu affatto contrario; quei napoletani che si erano spinti avanti in catena batterono tosto in ritirata; e fu quello il momento in cui Menotti Garibaldi, Schiaffino con la bandiera in pugno (una bandiera da lui improvvisata a bordo del Piemonte, e non già quella che la città di Montevideo donava alla Legione comandata dal generale Garibaldi) e l'Elia si lanciarono dietro ai fuggenti, seguiti dai Carabinieri Genovesi che formavano la prima linea. Fra i cacciatori del Landi fuggenti, i tre garibaldini erano con essi montati sulla banchina, fortissima posizione del nemico: Schiaffino colla bandiera, Menotti Garibaldi, Elia. Quello che accadde fu cosa di brevissimi istanti. L'eroico Schiaffino veniva crivellato di ferite; Menotti Garibaldi, che lo vide vacillare e sul punto di cadere, afferrava tosto la bandiera, ma veniva colpito alla mano; Elia che era già stato sfiorato al[36] petto da una puntata di baionetta, con pensiero rapido e più rapidamente eseguito, afferrava il suo caro amico Menotti e la bandiera che egli teneva stretta nella mano sanguinante, e con lui abbracciato si lasciava cadere al di sotto della banchina; disgraziatamente l'asta impugnata da Menotti venne giù dalla banchina, ma il drappo della bandiera restava sul campo nemico.
A ridosso della banchina stavano i carabinieri genovesi che prendevano flato, per poi riprendere l'assalto.
Caduti dall'alto i due si trovarono vicini a Froscianti, il carissimo, fidato amico del generale Garibaldi, che appena veduto Elia, gli domandava cartucce avendo egli finito le sue. Nel voltarsi verso di lui, Elia vide il generale Garibaldi che col solito sangue freddo camminava verso la formidabile posizione nemica vomitante fuoco e dalla quale poteva essere distante non più di cinquanta metri. Il pericolo che il generale correva fece correre un brivido per le ossa ai presenti; ed Elia si slanciava rapidamente verso lui, gridandogli con disperazione "Generale, se una palla vi colga tutto è perduto e con Voi la unità della patria nostra;" ma egli, calmissimo,[37] procedeva in avanti. Con la fronte rivolta al nemico. Elia, che gli camminava a fianco, stava in indicibile angoscia pronto ad ogni evento, quando infatti vide un cacciatore borbonico abbassare l'arma e puntarla alla direzione del generale. Elia non ebbe che il tempo di fare un passo avanti alla persona di Garibaldi; un terribile colpo alla bocca lo rovesciava ed egli cadde a terra supino; coll'aiuto del generale che si era chinato su lui per dirgli un'affettuosa parola "Coraggio, mio Elia di queste ferite non si muore" egli potè volgersi bocca a terra e scampare l'imminente pericolo di essere soffocato dal sangue.
Intanto i napoletani fulminavano i nostri; in quel momento arrivava Bixio a spron battuto; parlò a Garibaldi brevi parole: e fu inteso il generale rispondere "No, Nino, qui si vince o si muore" e puntata la sua spada alla direzione della sempre formidabile posizione nemica, con tonante parola gridò: "Avanti ancora questo assalto o figlioli e la vittoria è nostra" e ordinata la carica si slancia per primo sull'erta, seguito da tutti i compagni che non erano caduti; e quel pugno d'uomini, trafelati, pesti, insanguinati, sfiniti da tre ore di corsa e di lotta,[38] con nuova lena riprende la sua ascesa micidiale rigando ancora ogni palmo dell'erta terribile di altro nobile sangue, risoluti all'estremo cimento.
Come l'eroe aveva preveduto, la vittoria fu nostra. Incalzati di fronte da quello stuolo di indemoniati che parevano uscissero dalla terra, sgomenti dall'improvviso rombo dei nostri cannoni che il bravo Orsini era riuscito a portare in linea, turbati dal clamore crescente delle squadre siciliane sui loro fianchi, disperando ormai di poter vincere, voltarono le spalle, abbandonando il monte tanto fieramente contrastato e non si arrestarono che dentro Calatafimi.
Il miracolo era compiuto—la giornata era vinta!—La vittoria di Calatafimi fu incontestabilmente decisiva per la campagna del 1860 e per l'unità della patria—decisiva sopratutto indiscutibilmente, nel senso morale—perchè dalla giornata di Calatafimi la superiorità della Camicia rossa sulle truppe borboniche fu immensamente stabilita.—-"Aiuto e pronto aiuto" telegrafava a Palermo la stessa sera del 15 il generale Lanza: ma poi credette miglior partito una precipitosa ritirata anche da Calatafimi.[39]
Ecco come un eroe dei mille Giuseppe Cesare Abba, descrive nel suo aureo libro "da Quarto al Volturno" la gloriosa giornata di Calatafimi:
"Già tutta l'erta era ingombra di caduti, ma non si udiva un lamento. Vicino a me il Missori, comandante delle guide, coll'occhio sinistro tutto pesto e insanguinato, pareva porgesse orecchio ai rumori che venivano dalla vetta, d'onde si udivano i battaglioni muoversi pesanti, e mille voci, come flotti di mare in tempesta, urlare a tratti: "Viva lo Re".
"Frattanto i nostri arrivavano a ingrossarsi, rinascevano le forze. I capitani si aggiravano fra noi confortandoci. Sirtori e Bixio erano venuti a cavallo fin lassù.
"Sirtori, impassibile, colla frusta in mano, pareva non si sentisse presente a quello sbaraglio; eppure sulla sua faccia pallida e smunta io lessi qualcosa, come la volontà di morire fra tutti noi.
"Bixio compariva da ogni parte, come si fosse fatto in cento; braccio di ferro del generale. Lassù, lo rividi vicino a lui un altro istante.
"—Riposate, figliuoli, riposate un poco, diceva il generale—ancora uno sforzo e sarà finita! E Bixio lo seguiva fra le file.[40]
"In quello il sottotenente Bandi veniva a salutarlo lì, per cadere sfinito. Non ne poteva più. Aveva toccate parecchie ferite, ma un'ultima palla gli si era ficcata sopra la mammella sinistra, e il sangue gli colava giù a rivi. Prima che passi mezz'ora sarà morto, pensai; ma quando le compagnie si lanciarono all'ultimo assalto, contro quella siepe di baionette che abbagliavano, stridevano, sì che pareva di averle già tutte nel petto, tornai a vedere quell'ufficiale fra i primi. "Quante anime hai?" gli gridò uno che deve essergli amico.
"Egli sorrise beato.
"In quel momento i regi tiravano l'ultima cannonata, fracellando a bruciapelo un Sacchi pavese; e fu da quella parte un grido di gioia perchè il cannone era preso. Poi corre voce che il generale era morto, e Menotti, ferito nella destra, correva gridando e chiedendo di lui. Elia giaceva ferito a morte; Schiaffino, il Dante da Castiglione di questa guerra, era morto, e copriva colla sua grande persona la terra sanguinosa.
"Quando, i nemici cominciarono a ritirarsi, protetti dai loro cacciatori, rividi il generale che li guardava e gioiva.[41]
"Gli inseguimmo un tratto; disparvero. Dal campo stemmo a vedere la lunga colonna salire a Calatafimi, grigia lassù a mezza costa del monte grigio, e perdersi nella città. Ci pareva miracolo aver vinto.
"O gran giorno, o immortali quelle tre ore del combattimento! Ma se fosse stato perduto? Si accapriccia il cuore, immaginando Garibaldi vinto, i suoi a squadre, a gruppi, rotti, messi in caccia, uccisi per tutta quella terra da Calatafimi a Salemi, lontano, lontano; gli ultimi ad uno ad uno, chi qua chi là, scannati come fiere, fin sulle rive del mare; e la testa del generale mandata a Napoli; che la potesse vedere e finire di tremare quel Re! Si raccapriccia. E forse l'Italia non si sarebbe fatta mai più.
"Felici allora, ben felici i morti combattendo, che almeno non avrebbero visto la grande tragedia.
"Ma per fortuna d'Italia la vittoria fu nostra".
Sgominato il nemico, conquistata Calatafimi, chiave della posizione, ormai si era padroni delle tre vie conducenti a Trapani, a Castellammare, a Palermo. Ulteriore resistenza non era pel momento[42] da prevedersi, ed inutile era anche l'inseguimento da parte dei garibaldini, perchè ad infastidire i fuggiaschi vi avrebbero pensato i bravi insorti siciliani.
Garibaldi pensò di dare un po' di riposo ai suoi, e volle che si passasse la notte sul conquistato campo di battaglia.
Le perdite nostre furono gravi rispetto al numero esiguo che rendeva prezioso ogni individuo; bisognava quindi aver cura dei feriti.
Trentadue dei mille rimasero sul terreno, fra i quali Schiaffino, Montanari, Pedotti, Sartori, D'Amicis; centottantadue i feriti fra i quali, Menotti Garibaldi, Elia, Maiocchi, Sirtori, Manin, Nullo, Missori, Cariolato, Bandi, Martignoni, Perducca, Palizzolo, Sprovieri, Bedischini, Carbonari, Pasquinelli, Della Torre, Della Casa, molti dei quali gravemente.
La mattina del 16 i garibaldini entrarono a Calatafimi fra gli evviva e le acclamazioni del popolo.
Posto il quartier generale al palazzo del Comune, Garibaldi emanava il seguente ordine del giorno:[43]
ORDINE DEL GIORNO
DOPO LA BATTAGLIA DI CALATAFIMI:
"Con compagni come voi io posso tentare ogni cosa, e ve l'ho provato ieri portandovi ad una impresa ben ardua, pel numero dei nemici e per le loro forti posizioni.
"Io contavo sulle fatali vostre baionette, e vedeste che non mi ero ingannato.
"Deplorando la dura necessità di dover combattere soldati italiani, noi dobbiamo confessare che trovammo una resistenza degna di uomini appartenenti ad una causa migliore, e ciò conferma quanto sarem capaci di fare nel giorno in cui l'italiana famiglia sarà serrata tutta intorno al vessillo di redenzione.
"Domani il continente italiano sarà parato a festa per la vittoria dei suoi liberi figli e dei nostri prodi siciliani; le vostre madri, le vostre amanti, superbe di voi, usciranno nelle vie colla fronte alta e ridente.
"Il combattimento ci costò la vita di cari fratelli morti nelle prime file; quei martiri della santa causa d'Italia saranno ricordati nei fasti della gloria italiana.[44]
"Io segnalerò al nostro paese il nome de' prodi che sì valorosamente condussero alla pugna i più giovani ed inesperti militi, e che conduranno domani alla vittoria, nel campo maggiore di battaglia, i militi che devono rompere gli ultimi anelli delle catene, con cui fu avvinta la nostra Italia carissima.
Calatafimi, 16 maggio.
Scrisse poi a Bertani la seguente lettera:
Caro Bertani,
Ieri abbiamo combattuto e vinto. La pugna fu tra italiani. Solita sciagura—ma che mi provò quanto si possa fare con questa famiglia—nel giorno che la vedremo unita.
Il nemico cedette all'impeto delle baionette de' miei vecchi Cacciatori delle Alpi vestiti in borghese; ma combattè valorosamente—e non cedette le sue posizioni che dopo accanita mischia corpo a corpo.
I combattimenti da noi sostenuti in Lombardia furono certamente assai meno disputati che non fu il combattimento di ieri; i soldati napolitani, avendo esaurite le loro cartucce, vibravan sassi contro di noi, da disperati.[45]
Domani seguiremo per Alcamo; lo spirito della popolazione si è fatto frenetico, ed io ne auguro molto bene per la causa del nostro paese.
Vi daremo presto altre notizie. Vostro:
Calatafimi, 16 maggio.
P.S. Questa serve per Medici pure.
Della battaglia di Calatafimi Garibaldi con parola commossa così ne parlava:
"Calatafimi! Io avanzo di tante pugne—se nell'ultimo mio respiro i miei, vedranmi sorridere, l'ultimo sorriso d'orgoglio—esso sarà ricordandoti!"
"Tu fosti il combattimento più glorioso di popolo! L'Italia non deve dimenticarlo".
Disfatte le truppe napolitane a Calatafimi, in quell'eroico combattimento nel quale si decise dell'unità della patria, Garibaldi comprese che bisognava battere il ferro finchè caldo, e marciare su Palermo. Era assai arduo affare, ma che cosa tratteneva più Garibaldi? Si trattava ne più ne meno di questo; mettere assieme strategia[46] ed audacia per assalire con circa 4000 armati, tra i rimasti dei mille ed i picciotti, ed impadronirsi d'una città che conteneva trentamila difensori, appoggiati ad una fortezza e sorretti da una squadra regia. Garibaldi tentò il colpo.
Il 17 marciava su Alcamo, il 18 per Partinico; nel medesimo giorno ordinava una conversione e giungeva al passo di Reune; fiancheggiavano Garibaldi a ponente le bande di Rosolino Pilo, a levante quelle del La Masa, un quattromila picciotti, male armati ma arditi e ben condotti. Per sopperire alla tenuità delle forze Garibaldi giuocò di astuzia; ordì un tranello nel quale il nemico cadde.
Il giorno 20, comandò e diresse egli stesso, una ricognizione su Monreale per attirarvi il nemico, e manovrò in modo da far credere che quello era il suo obbiettivo. Impegnato un combattimento d'avamposti, ad un tratto faceva sospendere l'attacco e si ritraeva indietro.
Nella notte, imperversando una violenta tempesta, prendeva sentieri di montagna battuti solo da capre e volgeva a levante, lasciando Orsini con le salmerie ed i cannoni a farsi inseguire[47] dalle truppe borboniche. Egli, di sorpresa, scendeva al Parco e batteva una colonna nemica che lo aveva assalito di fronte; colà il generale Orsini coll'artiglieria lo raggiungeva. Il 24 le truppe borboniche, fiancheggiate da forti colonne di cacciatori attaccavano i nostri. Garibaldi batteva in ritirata su Piana de Greci mentre era già sera. Nella notte ordinava ad Orsini di prendere la strada di Corleone per attrarre le forze nemiche; egli marciava silenzioso su Marineo, quindi lasciava Marineo per Missilmeri e, mentre le truppe napolitane inseguivano quelle che credevano le forze garibaldine condotte in ritirata dall'Orsini, Garibaldi, spalleggiato dalla parte di levante dai picciotti del La Masa, si preparava a dare l'assalto a Palermo.
La mattina del 26, alle 4, accompagnato da Turr, Bixio e Missori, andò a visitare il campo di Gibilrossa, occupato dalle squadre siciliane comandate da La Masa, Fuxa e fratelli Mastricchi, formanti un corpo di oltre 4000 uomini.
Garibaldi per avvicinarsi a Palermo aveva due grandi strade, ad una delle quali si poteva giungere per stretti sentieri e La Masa, pratico dei luoghi informò il Generale che da Gibilrossa[48] poteva discendere benissimo calando per quei sentieri praticabili sino a Mezzagno, da dove con altro poco cammino faticoso si poteva trovar presto sulla strada di Porta Termini. Garibaldi, dopo brevi riflessioni, decideva di battere questa via e dava ordine a Turr di fissare la marcia per l'indomani di primo mattino e che veniva ordinata così:
1o l'Avanguardia comandata dal maggiore Tuköry, composta di guide e di 60 volontari dei Mille, scelti da ciascuna compagnia.
2o Il battaglione Bixio coi carabinieri genovesi.
3o Il battaglione Carini, cacciatori delle Alpi.
4o Il corpo delle squadre siciliane, comandate da La Masa.
Disposta in tal modo la colonna Garibaldi, fatti chiamare i suoi ufficiali superiori, i comandanti le compagnie, e i capi delle squadriglie parlò loro così: "Compagni! Due vie abbiamo avanti a noi: una è di ritirarci nell'interno dell'Isola facendo la piccola guerra per organizzarci; l'altra è di piombare su Palermo, entrarvi, accendervi la rivolta: sicuri che quest'ultima impresa darà per risultato la liberazione dell'intera[49] Sicilia. "Decidete!"—A "Palermo", tutti gridarono.—"Ebbene, che ognuno faccia il suo dovere e domattina vi saremo!"
Alle 3 antimeridiane del 27 maggio—data memoranda—Garibaldi col resto dei suoi Mille comandati da Bixio, da Carini, da Cairoli, da Tuköry, da Menotti, da Mosto, da Nullo, da Canzio, da Dezza, da Cucchi sui quali sapeva di poter contare fino alla morte, spalleggiato fortemente dai Picciotti del La Masa e del Fuxa, come aveva predetto, si preparava ad assalire Porta Termini e da quella entrare in Palermo.
Era intendimento del generale di sorprendere la posizione del Ponte dell'Ammiraglio senza colpo ferire, ed in tal guisa piombare su Porta Termini, e di là spingersi al palazzo Reale dove trovavasi il Lanza, comandante in capo delle forze borboniche, col suo quartier generale. Tuköry colla sua avanguardia procedeva in silenzio per precipitarsi d'improvviso sul nemico, ma i Picciotti, tosto che videro le prime case del sobborgo, quasi avessero già in mano la città, non seppero frenarsi e presero a gridare Viva Garibaldi: Viva l'Italia; sparando delle schioppettate: così il piano di sorpresa andava fallito. I regi fortemente[50] protetti da barricate, che difendevano e impedivano il passaggio del Ponte dell'Ammiraglio, spazzavano con un turbine di mitraglia e di moschetteria la via che vi conduceva e i campi d'intorno:—i Picciotti non ancora abituati al fuoco ed ai cimenti corpo a corpo, balenano per un momento, ma all'esempio dei mille che nulla paventano, serrati, concordi, disprezzanti della morte si slanciano, sperdono in men che si dica le truppe borboniche e, come un torrente impetuoso si avventano su Porta di Termini scacciandone i nemici, vincendone la resistenza: primi fra tutti Bixio, Carini, Sirtori, Turr, Fuxa, La Masa; già erano caduti fulminati, i prodi fra i prodi, Tuchöry, Rocco, La Russa, Pietro Inserillo e Giuseppe lo Squiglio assieme a tanti e tanti altri che ebbero la fortuna di fare la bella morte dei prodi; ebbero ferite più o meno gravi Turr, Benedetto Cairoli, Enrico Piccinini, Raffaello Di Benedetto, Leonardo Caccioppo; Bixio alla testa del suo bravo battaglione, coi carabinieri genovesi, con a fianco, Dezza, Menotti, Mosto, Missori, Canzio, Nullo, Carbone, Cucchi, Cavalli, Venzo ed altri bravi, a passo di corsa, con impeto furioso, attaccano ed espugnano la barricata di Porta[51] Termini. Il Carbone, dei carabinieri genovesi, sale coraggiosamente per primo sulla barricata con la bandiera italiana in pugno e ne riporta ferita che non gli impedisce di continuare a combattere; per questo fatto il Carbone venne encomiato dal generale Garibaldi e promosso sottotenente.
Nell'assalto della barricata Bixio, Dezza, Menotti, Bezzi, Canzio, Cucchi, Carbone, Damiani, Mosto, Venzo, Manci fecero prodigi di valore; Bixio sopra tutti; come una furia si precipitava dove era più forte la resistenza, tempestando di colpi i nemici, finchè cadde gravemente ferito.
Forzata l'entrata in città, i Carabinieri Genovesi ed il resto di Mille seguiti dai bravi picciotti, si lanciarono sui borbonici forzandoli a cedere ed a ritirarsi; nel combattimento dei Quattro Cantoni fino a Piazza del Duomo ed a Porta Maqueda Cucchi, Miceli, Venzo, Mosto, ed altri bravi caddero feriti; ma i nostri, non ostante le preziose perdite, procedevano dovunque vittoriosi. Turr, Sirtori benchè feriti insieme agli altri ufficiali di Stato Maggiore si moltiplicavano, ed erano all'attacco del Palazzo Reale, erano a quello di Porta Maqueda, tagliavano le comunicazioni tra il mare e il Castello, mentre Dezza[52] e Missori con un pugno dei Mille battevano il nemico all'Albergaria.
La Loggia, e molti altri signori siciliani componenti il Comitato insurrezionale, con alcuni dei Mille fra i quali il Venzo, si cacciano fino alla Fiera-Vecchia, penetrano nelle Chiese, salgono sui campanili, ed il terribile tocco delle campane a stormo chiama in armi tutti i cittadini. La Città dei Vespri si ridesta, si erigono dovunque barricate, e i soldati napoletani, incalzati da ogni parte, sono costretti a ritirarsi nelle caserme e nel forte di Castellammare.
Garibaldi si spinge fino in piazza Bologna, insedia il suo quartier generale nel palazzo Municipale e di là emana il primo suo atto dittatoriale in nome di Vittorio Emanuele, col seguente proclama:
Siciliani!
"Il generale Garibaldi, dittatore in Sicilia a nome di S. M. Vittorio Emanuele Re d'Italia, essendo entrato in Palermo stamattina 27 maggio, ed avendo occupata tutta la Città, rimanendo le truppe Napoletane chiuse nelle caserme e nel forte di Castellammare, chiama alle armi tutti i[53] Comuni dell'Isola, perchè corrano nella metropoli al compimento della vittoria.
Dato in Palermo, oggi 27 maggio 1860
G. Garibaldi.
Il 28 fu giornata nella quale la città di Palermo sofferse orribilmente. La mitraglia fece vittime numerosissime, le bombe rovinavano, incendiavano, distruggevano tutto; ma mentre il bombardamento infieriva con tutti i suoi orrori, Garibaldi pensava anche all'organizzazione civile. Nominava Crispi segretario di Stato; il Duca della Verdura sindaco; istituiva un Comitato di difesa, presidente lo stesso della Verdura e componenti i signori Michele Mangiano, Tommaso Lo Cascio, barone Michele Capuzzo, barone di Paternò, Rubino Emanuele e Benedetto Scidita, Pietro Messineo, marchese Pilo, Patriola, Girolamo Mondino, ed altri patrioti, e segretario Vincenzo Scimecca.
La mattina del 29 maggio, i garibaldini ebbero un rinforzo di siciliani condotti da Fardella.
Per tutto quel giorno il combattimento continuò accanito, specialmente a Montalto ove il[54] Laporta, il marchese Firmaturi, il Sant'Anna, sostenuti dai Carabinieri genovesi, fecero colle squadre dei Picciotti, con fermezza e valore, il loro dovere.
Il generale Lanza, che fin dal mattino aveva fatto inutili sforzi per riprendere le posizioni perdute, e vedeva falliti tutti i tentativi per aprirsi le comunicazioni con Castellammare, fece cessare il bombardamento, durato tre giorni e tre notti senza intervallo.
I Consoli esteri e l'Ammiraglio inglese, commossi per le tante rovine e gli eccidi che da tre giorni sterminavano la bella città, fecero dei passi presso il generale Lanza perchè si desse tregua con un armistizio a tanta effusione di sangue cittadino; il generale borbonico acconsentiva, e la mattina del 30 spediva al Dittatore Garibaldi la lettera seguente:
Generale!
"L'ammiraglio britannico mi fa conoscere che riceverebbe con piacere al suo bordo due miei generali, per aprire con lei una conferenza, nella quale egli servirà da intermediario.
"La prego farmi conoscere se acconsente, e nel caso affermativo, permettere che i due miei[55] generali passino la sua linea, facendoli Ella accompagnare dal palazzo reale, ove potrebbe mandarli a prendere, fino alla Sanità per imbarcarsi.
"In attesa di una sua risposta, ho l'onore di essere
"29 maggio 1860.
"Lanza".
Garibaldi acconsentì e ordinò la cessazione del fuoco, disponendo che l'intervista avesse luogo all'una pomeridiana. Il maggiore Cenni fu inviato alle undici e mezzo con due guide al palazzo Reale.
Erano scorsi pochi istanti dalla partenza del Cenni, quando veniva dato un allarme a Porta Termini; poco dopo incominciavano le fucilate: Erano Von-Mechel e Bosco, i quali ritornavano da Corleone, col dispetto di essere stati giuocati per la terza volta, e di avere inseguito non Garibaldi coi suoi volontari, ma un treno di cassoni e carriaggi inservibili.
I garibaldini non risposero al fuoco; Carini e Sirtori si presentarono per dare la notizia dell'armistizio nel momento in cui il fuoco dei napoletani era più vivo; Carini ne riportò grave[56] ferita, Sirtori fu ferito leggermente. Turr, raccolti quanti uomini potè sul momento, corse in appoggio dei nostri a Porta Termini.
In quel momento il generale borbonico Letizia accompagnato dal Cenni traversava Toledo; saputo quanto accadeva, si offerse di recarsi egli stesso sul luogo del combattimento per portare ai suoi la notizia dell'armistizio, e per fare cessare il fuoco onde non si sospettasse un tradimento. Arrivato sul luogo, impose a Von-Mechel e a Bosco di cessare da ogni azione ostile, essendo che la tregua doveva essere rispettata da tutti. Garibaldi all'una si recò a bordo dell'"Annibal" nave da guerra Inglese, nella cui sala di consiglio ebbe luogo la conferenza e fu stipulata una tregua di 24 ore; ma, prima che questa venisse a scadenza, il generale borbonico richiese la sospensione delle ostilità per altri tre giorni, prodromo evidente della resa finale. E Garibaldi accondiscese ancora.
Infatti il 6 giugno, i negoziati furono ripresi e senza difficoltà condussero ad una convenzione, per la quale le truppe napolitane sgombravano Palermo e il forte di Castellammare per la via di mare.[57]
Intanto tutte le principali città dell'Isola si erano affrancate a libertà, e di tutta la Sicilia, il 7 giugno, non restava in mano del Borbone che Messina, la cittadella di Milazzo, Augusta e Siracusa.
Garibaldi s'insediava, col suo quartier generale e col suo governo, al Palazzo Reale.
Dopo la presa di Palermo Garibaldi avuta notizia che Elia curato con cure fraterne dai bravi medici chirurgi, Ripari, Lampiasi, Cipolla, Maltese, era vivente a Vita, accolto amorevolmente in casa del patriota Salvatore Romano, mandò Menotti con incarico di portarlo possibilmente a Palermo, e ivi giunto il generale volle che fosse curato sotto ai suoi occhi e lo fece condurre al palazzo Reale.
Occorreva provvedere ora al necessario per non perdere il frutto delle riuscite imprese. Faceva mestieri organizzare i corpi militari in forza dell'entusiasmo dei cittadini per poter far fronte ai pericoli delle rappresaglie d'un governo che, prossimo a cadere, voleva segnalare i suoi ultimi[58] giorni con atti disperati e col sovvertimento delle turbe e di ogni ordine civile.
Questi pensieri pesavano orribilmente sull'animo del dittatore, il quale trovava più difficile mettere riparo a queste difficoltà civili che il combattere formidabili eserciti borbonici. Per riparare a questi mali erano necessarie delle spedizioni nell'interno dell'Isola, affidate ai suoi fidi compagni; ma l'esecuzione di tale progetto gli riusciva nel momento assolutamente impossibile. Da Genova non arrivavano rinforzi. Anzi si avevano notizie che due navi cariche di volontari condotti dal maggiore Corte "L'Utile" e il "Charles Georgy" erano state catturate dalla crociera napoletana e condotte a Gaeta.
Era un vero disastro che impensieriva il Dittatore, tanto più che si sapeva che trovavasi in viaggio la forte spedizione Medici. Per fortuna questo esperto condottiero, che aveva ereditato da Garibaldi tutte le astuzie e tutte le audacie, seppe deludere la vigilanza della crociera napoletana, approdando inaspettato a Cagliari e di là, per rotta impensata dai nemici, arrivare alla desiderata destinazione.
Nella mattina del 19 giugno Medici sbarcava[59] sulla vicina costa di Partinico con forte aiuto di uomini e di armi, e tutte le preoccupazioni del Dittatore erano dissipate—Medici aveva con sè il bravo colonnello Malenchini coi suoi toscani—e annunziava l'arrivo di Cosenz. L'arrivo di Medici pose Garibaldi in condizione di compiere i suoi piani riguardo alla Sicilia, quelli cioè di scacciare quanto rimaneva dell'esercito borbonico nella parte orientale dell'Isola.
Divise le forze in tre colonne: la prima formante la sinistra agli ordini di Medici doveva marciare per il litorale fino a Milazzo, ultimo obbiettivo Messina; la seconda, al centro, condotta dal Turr per Missilmeri, Villafrati, Alia, Caltanisetta, sopra Catania, scopo ultimo Messina; la terza, all'estrema destra, comandante Bixio, per Corleone, Girgenti, Catania scopo finale Messina; così che, tutte le forze non avevano che un solo obbiettivo la punta del Faro.
La marcia di queste brigate contribuì moltissimo a sistemare il nuovo ordine di cose, a sollevare l'elemento liberale e por freno agli insani tentativi di disordini.
Ma questo consolidamento incontrava ostacoli per il fatto che armi borboniche occupavano dei[60] punti importanti dell'Isola e tenevano in soggezione tutta la regione orientale, appoggiandosi su Milazzo e alla cittadella di Messina.
Il Dittatore riserbava a Medici la parte splendida di liberare questa regione dalle truppe borboniche, e Medici, ricevuti gli ordini, a marcia forzata occupava Barcellona, quivi giunto, temendo che i regi fortificati in Milazzo tentassero un colpo per sloggiarlo, avvisava a tutti i mezzi per fortificarvisi; occupava l'interessante posizione del fiume Meri; muniva il ponte con due cannoni; distendeva le sue ali di difesa fino all'altura del villaggio Meri; e tutto preparava alla difesa della sua posizione per dare tempo all'arrivo di altri rinforzi.
Le truppe borboniche così composte: un corpo di 3500 uomini proveniente da Messina, altro di 1500 stanziato a Milazzo, altri 2500 che si aggiunsero provenienti da altre parti dell'isola, erano comandate dal colonnello Bosco, il quale si trovava in grado di dare aspra battaglia.
Il giorno 17 ebbe luogo un primo fatto d'armi, ostinato e sanguinoso.
Medici si era fortificato presso Carriola al[61] fiume Nocito, ed aveva occupata la strada di Meri e Milazzo, erigendovi barricate. Bosco pensò di sloggiarlo, e con forze preponderanti pervenne a passare oltre Carriola il Nocito; ma ivi s'impegnò un vivissimo combattimento con la destra di Medici, gagliardemente tenuta dal reggimento Malenchini; tanta resistenza da questa parte poneva i regi in pericolo di essere tagliati fuori della loro linea, per cui Bosco spinse altri battaglioni verso le barricate; il combattimento fu accanito, ma Medici per venirne a capo, lanciava contro le truppe borboniche un battaglione della riserva e i nostri alla punta della baionetta ricacciavano i regi dentro Milazzo. Le truppe comandate dal Malenchini combatterono sotto gli occhi di Medici assai valorosamente.
Il generale Garibaldi avvisato a Palermo della resistenza che incontrava Medici s'imbarcava con un buon rinforzo. Sbarcato a Patti corse innanzi solo, al quartiere generale di Medici. Vi arrivò il 19 e vi trovò anche il Cosenz.
Calcolando il generale che i rinforzi sbarcati a Patti sarebbero arrivati il 20 sul luogo del combattimento, decise di dare battaglia e d'investire Milazzo.[62]
La mattina del 20 alle 5 il generale Medici divideva le sue truppe in due colonne, ciascuna di quattro battaglioni, una sotto il comando di Simonetta, l'altra sotto quello di Malenchini.
Deciso il combattimento Garibaldi ordina che il Malenchini per la strada di Santa Marina si porti ad assalire senz'altro la sinistra del nemico; dà incarico al Medici di avanzare col reggimento Simonetta e il battaglione Gaeta per la strada di San Pietro spingendosi col centro e colla destra contro la città; affida a Nicola Fabrizi d'occupare con una legione di siciliani la strada di Spadafora per antivenire ogni sorpresa di un'eventuale sortita del presidio di Messina; delibera infine che la colonna Cosenz, già partita fin dall'alba da Patti e rinforzata dal battaglione Dunn e da quello del Guerzoni, lasciati a guardia di Meri, formino la riserva.
Alle 5 del mattino tutti erano in moto; il Malenchini alle 7 aveva già aperto il fuoco presso San Papino; anche il Medici attaccava il nemico al di là di San Pietro e il combattimento si accese, accanito su tutta la linea. I garibaldini si spingono verso Milazzo, ma la loro sinistra appoggiata al mare, trovò tale resistenza nei regi[63] nella strada di San Pepino e tale fuoco d'artiglieria dal forte e dalla batteria portata dietro i canneti, che furono obbligati a ripiegare.
Ad accrescere lo scompiglio nelle giovani schiere dei volontari, concorse la cavalleria nemica che irruppe furiosamente sui nostri, sbaragliandoli. Comandava questa colonna il colonnello Malenchini che, potentemente coadiuvato dai suoi bravi ufficiali, faceva sforzi eroici per riordinare i suoi e ricondurli alla pugna; chi si distinse per ardire insuperabile fu il Tommasi, che venne promosso tenente sul campo di battaglia.
Mentre questo avveniva sull'ala sinistra, Medici spingeva tre dei suoi battaglioni ed uno di Carabinieri genovesi verso il fiume Nocito; investiva i molini dove i regi eransi fortificati e tentava d'impadronirsi della lingua di terra che congiunge Milazzo con l'interno, e così girare alle spalle del corpo napoletano e tagliar fuori di Milazzo il Bosco; ma anche questo tentativo incontrò un'energica resistenza, perchè il Bosco da quel lato aveva spinto il maggior nerbo delle sue forze; si combatteva uno contro tre, senza[64] contare la mitraglia che, da dietro grandi siepi di fichi d'India, faceva strage dei nostri.
Medici riconosce la gravità della posizione e, da quell'eroe che era, decide d'avventarsi contro il cannone che faceva strage dei suoi e d'impossessarsene. "Meglio perire nell'arrischiata impresa, che vedere così sacrificati i miei soldati". Con questo pensiero raduna quanti più può dei suoi e si lancia in mezzo al fuoco nemico, ma nei primi passi gli cade morto il cavallo e al fianco suo è colpito da palla fredda il Cosenz, tanto da rimanerne tramortito; riavutosi tosto e circondato dai suoi valorosi compagni, riprende impavido il combattimento.
Garibaldi, accortosi del pericolo che correvano i suoi cari compagni, riunisce intorno a sè Missori, Statella e quanti trova sotto mano e si lancia al soccorso; il cavallo di Garibaldi è ferito e non sente più il freno; il tacco di un suo stivale è portato via da una scheggia; è obbligato a smontare dal cavallo; accanto a lui in quel momento cadeva mortalmente ferito il maggiore Breda; a Missori è pure ucciso il cavallo; anche Garibaldi vede che per spuntarla bisognava ad ogni costo impadronirsi del cannone[65] che faceva strage, e dà gli ordini necessari; si lancia alla testa dei suoi e il cannone è preso e trascinato nelle proprie linee.
Allora la fanteria napolitana, che in quella giornata combattè valorosamente, apre i suoi ranghi e dà il passo ad una furiosa carica di cavalleria che s'avventa sui nostri come un turbine per riprendere il pezzo; le squadriglie siciliane giunte allora da Patti entrano in combattimento e con una formidabile scarica fermano l'impeto dei cavalieri; l'ufficiale che comandava la cavalleria è esso pure obbligato ad arrestarsi da Garibaldi che aveva preso la briglia del cavallo; l'ufficiale mena un fendente, ma Garibaldi para il colpo e con una pronta risposta gli taglia la gola; i napoletani assalgono Garibaldi; si combatte corpo a corpo; Missori scarica quanti colpi ha nel suo revolver ed uccide quanti tentano appressarsi al generale; Statella lo difende a colpi di sciabola, dando così tempo ai garibaldini di accorrere al soccorso.
Ma gli ostacoli sono insuperabili; gl'immensi canneti e le boscaglie di fichi d'India sparsi su quella riva impedivano ai garibaldini di far uso delle baionette, terribile arma loro prediletta, e[66] favorivano i tiri dell'artiglieria borbonica. Per fortuna in quel momento apparve nella rada un vapore con bandiera italiana. Era la corvetta napoletana "La Veloce" che il comandante Anguissola, dando primo l'esempio della rivolta, aveva consegnata a Garibaldi, il quale la battezzava col nome di "Tuckery" in memoria del prode maggiore ungherese morto alla presa di Palermo. Il generale, senza perdita di tempo, si fa portare a bordo, e salito sulla coffa dell'albero di trinchetto domina tutto il teatro della battaglia; ordina al comandante d'accostarsi a tiro di mitraglia ed al momento opportuno fa fulminare di fianco le truppe borboniche, e ne fa strage tale che il nemico è sgominato in brev'ora.
Questo felice diversivo dà tempo al Medici ed al Cosenz di riordinare i loro battaglioni e prepararsi ad un decisivo assalto.
Garibaldi scende a terra dal Tukery con un manipolo di marinari armati, si mette alla testa dei suoi e si riprende l'assalto; tutte le riserve sono impegnate: il maggiore Guerzoni arriva esso pure coi suoi a passo di corsa; un'ultimo disperato assalto è ordinato, i canneti a sinistra, il ponte di Curiolo di fronte, le case di destra,[67] terribili strette, sono tutte superate con indicibile valore; i cacciatori del Bosco rispondono con un fuoco infernale e recano ai nostri danni non lievi; il capitano Leardi, dopo aver veduto cadere attorno a sè non pochi dei suoi valorosi è ferito a morte; il Costa, lo Statella, il Martini, il Cosenz feriti; ma il nemico è in fuga e dopo del nemico i garibaldini entrano in Milazzo e i borbonici si rinchiudono nel forte.
La battaglia di Milazzo fu la più sanguinosa tra quelle combattute delle armi garibaldine nel 1860.
Su quattromila combattenti garibaldini, più di settecento restarono sul campo fra morti e feriti.
La giornata del 21 passò in entrambi i campi tranquilla, le nostre truppe riposarono, e quelle borboniche il 22 s'imbarcarono su tre navigli francesi per essere trasportate a Napoli.
Il 23 arrivavano nelle acque di Milazzo quattro navi da guerra napolitane; ma visto che i garibaldini erano padroni della piazza si limitarono ad imbarcare il presidio del Castello; sicchè il Castello, con cannoni, munizioni ed ogni attrezzo di guerra, rimaneva in potere di Garibaldi, che vi faceva inalberare la bandiera tricolore.[68]
Dopo la presa di Milazzo anche le truppe che occupavano la cittadella di Messina si arresero.—Tutta la Sicilia era liberata!
Occorreva pensare al passaggio dello stretto ed alla continuazione della marcia gloriosa per le Calabrie alla capitale del Reame di Napoli, e primo pensiero del Duce fu quello di nominare comandante militare e civile di Messina l'illustre patriota Nicola Fabrizi, con suo Capo di Stato Maggiore il valoroso Abele Damiani.
Questo venerando patriota aveva organizzato a Malta un corpo d'italiani volontari del quale faceva parte il Pittaluga, che dopo lo scontro infelice di Grotte, sostenuto dal Zambianchi contro forze superiori papaline, aveva preso passaggio in un vapore delle Messaggeries per raggiungere Garibaldi in Sicilia; col Pittaluga erano il Civinini, il Pedani livornese, ed altri.
Sbarcato il Fabrizi in Sicilia ebbe ordine da Garibaldi di recarsi a Barcellona per organizzare e prendere il comando dei battaglioni dell'Etna composti di patriotti siciliani. Il governo civile e militare di Messina era quindi affidato a buone mani.[69]
Il passaggio sul continente non era cosa delle più facili; bisognava vincere le difficoltà che venivano dal Ministero in seguito alle pressioni dell'imperatore dei francesi; bisognava inoltre deludere la vigilanza della flotta nemica che giorno e notte batteva il mare e sorvegliava lo stretto senza contare che il Borbone, nonostante le defezioni, poteva sempre mettere a fronte di Garibaldi un Esercito organizzato di 100 mila uomini. Era necessario quindi fare uso di quegli audaci colpi di mano, nei quali Garibaldi era maestro.
Infatti la sera dell'8 agosto egli ordinava al Mussolino, calabrese, di tentare con un limitato numero di volontari scelti fra i più audaci, come Missori, Alberto Mario, Vincenzo Cattabeni ed altri valorosi, la sorpresa del forte Cavallo e la insurrezione della Calabria. La sera dopo ordinava a Salvatore Castiglia di sbarcare nell'Alta Fiumana con arditi garibaldini.
Persuaso Garibaldi, dopo quindici giorni di vani tentativi, della difficoltà del passaggio dello stretto di Messina, causa l'esiguità delle sue forze, ed avute notizie dal Bertani che in Sardegna stavasi organizzando una legione di circa 8 mila[70] bene armati sotto la direzione del colonnello Pianciani, col proposito d'invadere lo Stato Pontificio, convinto che su Roma si poteva marciare con più sicurezza per la via di Napoli, deliberava di portarsi egli stesso al Golfo degli Aranci per assicurarsi il concorso degli ottomila uomini coi quali avrebbe raddoppiato il numero delle sue forze. Non tardò a mettersi in viaggio ed appena arrivato si presentò d'improvviso a quella gioventù che anelava al combattimento; vinse col fascino delle sue parole gli scrupoli di qualcuno e, preso il comando di quelle truppe, se le trasse seco in Sicilia.
Date le disposizioni opportune per il governo dell'Isola—nominò Depretis Prodittatore e partì per Messina.
Prima di lasciare Palermo il Generale emanava l'ordine del giorno seguente:
Alle Squadre Cittadine!
"A Voi robusti e coraggiosi figli dei campi, io dico una parola di gratitudine in nome della patria italiana, a Voi che tanto contribuiste alla liberazione di questa terra, a Voi che conservaste il fuoco sacro della libertà sulle vette dei[71] vostri monti, affrontando, in pochi e male armati, le numerose ed agguerrite falangi dei dominatori.
"Voi potete tornare oggi alle vostre capanne colla fronte alta, colla coscienza d'aver adempiuto ad opera grande! Come sarà affettuoso l'amplesso delle vostre donne inorgoglite di Voi, accogliendovi festose nei vostri focolari! e Voi racconterete superbi ai vostri figli i perigli trascorsi nelle battaglie per la santa causa dell'Italia.
I vostri campi, non più calpestati dal mercenario, vi sembreranno più belli, più ridenti. Io vi seguirò col cuore nel tripudio delle vostre messi, delle vostre vendemmie, e nel giorno in cui la fortuna mi porgerà l'occasione di stringere ancora le vostre destre incallite, sia per narrare delle nostre vittorie o per debellare nuovi nemici della patria, Voi avrete stretto la mano di un fratello.
Palermo, 3 giugno.
G. Garibaldi.
Il generale Sirtori aveva già assicurati due vapori, il "Torino" ed il "Franklin", che faceva trovar pronti nel porto di Taormina. Senza perdita di tempo, appena arrivato a Messina, Garibaldi ordina a Bixio, che tanto aveva sospirato[72] quel comando, di mandare tutta la sua gente a Taormina (circa 4000 uomini) e d'imbarcarla sui due piroscafi. Bixio, che tutto aveva approntato per il passaggio dello Stretto, imbarcate le sue truppe, monta sul "Torino"; Garibaldi, arrivato in carozza da Messina, sale sul "Franklin" e nella notte del 19 di agosto, levate le ancore partono per la Calabria, ed allo spuntar dell'alba del 20 i due vapori si accostano a Melito tra Capo dell'Armi e Spartivento. Disgraziatamente nel prendere terra il "Torino" rimaneva arenato, ma non per questo venne ritardato lo sbarco a terra delle truppe garibaldine che fu effettuato senza contrasto; solo più tardi le navi da guerra napolitane in crociera se ne accorsero e presero a bombardare il "Torino" vuoto.
Bisognava impadronirsi con un colpo di mano di Reggio; e senza esitare il generale Garibaldi ordina di muovere all'assalto, e la sera del 20 i garibaldini ripresero la marcia. Ad una certa distanza dalla città il Generale faceva obbliquare a destra e per sentieri remoti, evitando gli avamposti nemici appostati sullo stradale, e guidato dal colonnello Plutino si avvicinava alla piazza. Fatti riposare i volontari e disposto che la divisione[73] Bixio dovesse assalire dalla parte di destra e quella di Eberhardt da sinistra, dopo forte resistenza i nostri s'impadroniscono della città ed obbligano i Regi a rinchiudersi nel Castello.
A Garibaldi importava d'impossessarsi del Castello, perchè aveva avuto notizia che una forte colonna nemica, comandata dal generale Briganti, marciava su Reggio. Fortunatamente la comparsa di Missori, coi suoi reduci dall'impresa del Forte Cavallo, fece credere ai Napoletani che erano rinchiusi, di essere accerchiati, per cui alle prime fucilate piovute dall'alto domandarono d'arrendersi.
Questo è l'ordine del giorno che il generale Garibaldi aveva mandato alle sue truppe prima che si accingessero al passaggio del Faro.
Messina, 9 agosto 1860.
"Il maggior Casalta d'Ornano, della divisione Cosenz si dirigerà da questo porto di Torre di Faro per sbarcare sulla costa di Calabria tra Ragnore e Scilla.
"Egli comanda il suo battaglione e più un distaccamento del battaglione Fazioli. La sua[74] missione è di propagare l'insurrezione contro il Borbone di Napoli ed il suo programma è quello dell'Italia e Vittorio Emanuele.
"Chiederà del colonnello Mussolino, lo cercherà e procurerà di coadiuvarlo in qualunque emergenza, siccome lo stesso Colonnello coadiuverà lui.
"Si manterrà possibilmente vicino al quartiere Generale, che terrà informato di qualunque cosa utile alla causa nazionale ed al servizio.
"Procurerà di tagliare le comunicazioni del nemico sullo stradale di Reggio e Napoli, impossessandosi dei suoi convogli, dispacci ecc.
"Occuperà il nemico instancabilmente mediante distaccamenti, in varie direzioni, per ingannarlo sulla sua vera situazione.
"Ubbidirà ai Colonnelli Mussolino e Missori soltanto nel caso che questi colonnelli dovendo operare sul nemico lo richiedessero del suo concorso; egli parteciperà queste istesse istruzioni ai Colonnelli suddetti.
"Sopratutto egli farà ogni sforzo per cattivarsi l'amicizia delle popolazioni ed impedire qualunque prepotenza delle sue truppe contro le stesse.[75]
"Infine l'Esercito Meridionale confida che l'onore delle armi italiane riceverà nuovo lustro dal coraggio, capacità e patriottismo del maggiore Casalta.
G. Garibaldi.
I risultati della presa di Reggio furono di grandissima importanza; Garibaldi si rendeva padrone di buon materiale da guerra e acquistava per base d'operazione sul continente una piazza di grande rilievo.
La vittoria di Reggio era ben presto coronata da altra pure importantissima e decisiva. Nella notte dal 21 al 22 il generale Cosenz, imbarcata sopra la flottiglia del Faro la sua divisione, i Carabinieri Genovesi, e la Legione estera, riusciva ad approdare su la spiaggia calabrese nelle vicinanze di Scilla, mettendosi così alle spalle della forte brigala Briganti, accampata presso San Giovanni.
Avuta notizia del fortunato sbarco di Cosenz a Scilla, il generale Garibaldi si mosse senza indugio con tutti i suoi da Reggio, ove lasciava il colonnello Plutino con una colonna di patriotti calabresi, per prendere fra due fuochi i Borbonici, comandati dal Briganti e dal Melendez. Le[76] mosse dei garibaldini furono così ben combinate che riuscirono a circuire le forze regie, tantochè Garibaldi, serrandole d'appresso e sicuro del fatto suo, intimava la resa. Allora si videro novemila uomini d'ogni arma, ricchi d'artiglieria e d'ogni attrezzo di guerra, abbassare le armi, dopo debole resistenza, innanzi a seimila garibaldini quasi sprovvisti di tutto. Però nel breve combattimento sostenuto dal Cosenz nel prendere terra nelle vicinanze di Scilla, dopo di essere sfuggito miracolosamente alla flotta borbonica in crociera, si ebbe a deplorare una preziosissima perdita, quella di Paul De Flotte, deputato all'Assemblea repubblicana francese, il quale erasi unito ai Mille col Locroix, col Dumas e con altri fratelli di Francia, venuti a combattere per la libertà ed unità d'Italia; perdita dolorosissima per tutti, ma particolarmente per Garibaldi, che così ne scrisse al Bertani, in forma d'ordine del giorno del 24 agosto:
"Abbiamo perduto De Flotte! gli epiteti di bravo, di onesto, di vero democratico sono impotenti per esprimere tutto l'eroismo di quest'anima incomparabile!
"De Flotte, nobile figlio della Francia, era[77] uno di quegli esseri privilegiati che un sol paese non ha diritto di appropriarsi; no, De Flotte appartenne all'umanità intera; giacchè per lui la patria era ovunque un popolo sofferente e curvo si rialzava per la libertà.
"De Flotte morto per l'Italia, ha combattuto per essa come avrebbe combattuto per la Francia.
"Quest'uomo illustre è un legame prezioso per la fratellanza dei popoli che attende l'avvenire dell'Umanità. Morto nei ranghi dei Cacciatori delle Alpi, egli era, come molti dei suoi bravi concittadini, il rappresentante della generosa Nazione, che si può arrestare un momento, ma che è destinata a marciare in avanguardia dell'emancipazione dei popoli e della civiltà del mondo.
24 agosto.
G. Garibaldi.
Da quel giorno lo sfacelo dell'esercito borbonico delle Calabrie seguì con rapidità crescente. Tutte le provincie si sollevavano precedendo le forze della rivoluzione, guidate da Garibaldi. La città di Potenza cacciava le truppe che la custodivano, e la Basilicata rivendicava la sua libertà. Cosenza costringeva le forze borboniche[78] a capitolare ed a ritirarsi a Salerno, con impegno di non più combattere contro Garibaldi. A Foggia, a Bari le truppe fraternizzarono col popolo. Il Generale Viale, che stava a guardia delle Termopoli di Monteleone con 12000 uomini, minacciato dall'insurrezione del popolo e dalla sedizione delle truppe, batteva in ritirata, abbandonando ai garibaldini una delle più forti posizioni, chiave strategica delle Calabrie. Delle truppe in ritirata prese il comando il generale Chio che si arrestava a Saveria-Manelli, tra Tiriolo e Cosenza, per attendere di piè fermo il sopraggiungere dei Garibaldini. Prima però che egli arrivasse a Saveria, le alture che la dominano, erano occupate dalle bande calabresi di Stocco, parte delle quali erano dirette e comandate dal valoroso patriota Antonio Taglieri, che nominato tenente passò poi nel 2o reggimento della divisione Cosenz; cosicchè il Chio si trovò prima di combattere, accerchiato. Garibaldi ordinò tosto a tutte le truppe che lo seguivano di convergere a marcia forzata su Tiriolo, e, appena potè avere sottomano l'avanguardia della divisione Cosenz, la lanciò sulla strada di Saveria-Manelli, fece calare dalle alture le bande dello Stocco, ed intimò al generale Chio la resa.[79]
Questi tentò di guadagnare tempo, ma dopo un'ora altri 12000 uomini andavano dispersi e disciolti come quelli del generale Briganti, lasciando libere nelle mani del Dittatore tutte le Calabrie. Garibaldi intanto proseguiva la marcia trionfale per Napoli.
Tra Salerno ed Avellino circa ventimila uomini, la più parte mercenarii stranieri, stavano aspettando Garibaldi, risoluti a combattere. Ma corsa la notizia che la rivoluzione si era propagata ad Avellino e nel Principato Ulteriore, saputo che il generale Calderelli, che aveva capitolato a Cosenza, era passato con Garibaldi, anche le truppe di quel campo cominciarono a dar segni di ammutinamento; il che tolse ai comandanti la speranza di tentare un attacco con probabilità di successo.
L'arrivo di queste notizie a Napoli indusse il Re a ritirarsi a Gaeta; il che fece il 6 del mese di Settembre, lasciando Napoli in tutela della Guardia Nazionale. All'udire la lieta notizia Garibaldi presa a Vietri la ferrovia, arrivò a mezzogiorno alla stazione di Napoli ove Liborio Romano lo ricevette, felicitandolo a nome della cittadinanza. Al tocco, in carrozza, accompagnato[80] da Cosenz, da Bertani, da Missori, da Nullo e da pochi altri ufficiali entrava in Napoli, passando sotto i forti ancora occupati dalle truppe borboniche, in mezzo a soldati nemici sparsi per la città e fra l'entusiasmo di un popolo delirante, scendeva alla Foresteria, palazzo del Governo, e ne prendeva possesso.
Primo suo atto fu quello di emanare il seguente Decreto:
Napoli, 7 settembre 1860.
Il Dittatore Decreta:
"Tutti i bastimenti da guerra e mercantili appartenenti allo Stato delle due Sicilie, Arsenali e materiali di Marina, sono aggregati alla Squadra del Re Vittorio Emanuele, comandata dall'Amiraglio Persano".
G. Garibaldi.
Istituiva tosto il governo dittatoriale, nominando Crispi ministro degli Esteri, Bertani ministro dell'Interno, Cosenz ministro della Guerra, ed al general Turr dava il comando di tutte le truppe stanziate a Caserta ed al Volturno.
Il 18 settembre il generale Turr, comandante le forze al Volturno chiamava a sè il suo capo di Stato Maggiore e tutti i comandanti delle brigate[81] ai suoi ordini; esponeva ad essi il progetto di una ricognizione offensiva su Capua, onde antivenire una battaglia che, secondo notizie ricevute, i regi si apprestavano a dare appunto nel giorno 19 dedicato a S. Gennaro, dal quale speravano protezione e vittoria. Si doveva simulare un attacco sul fronte di Capua, per attirarvi le forze borboniche ed impedire alle medesime di portare soccorso alla loro sinistra dove dovevano operare le colonne di Csudafii e di Cattabeni; dava ad ognuno dei comandanti di brigata verbali istruzioni, determinando ad ognuno la parte che doveva prendervi; raccomandava infine ai comandanti di non esporre le truppe oltre il limite richiesto dallo scopo cui tendeva l'azione, cioè la simulazione di un attacco.
Ordinava quindi che l'azione dovesse effettuarsi nelle prime ore del giorno seguente, 19 settembre.
In seguito a tale ordine i colonnelli brigadieri Spangaro, Puppi e di Giorgis si mossero sul fare del giorno del 19 al simulato attacco di Capua.
L'attacco contro il fronte di questa fortezza fu sostenuto con grande valore; colla punta della[82] baionetta furono snidati i borbonici che occupavano due cascine sulla strada conducente agli approcci del forte e quelli appostati fra l'argine della ferrovia e la strada postale.
I bersaglieri milanesi, comandati dal capitano Pedotti, compirono atti di grande valore; il capitano, cacciatosi coi suoi fra le fitte schiere nemiche, corse pericolo di essere soprafatto; vi fu un momento in cui fu creduto perduto, ma il destino lo volle conservato alla patria.
La mitraglia, senza interruzione vomitata dai bastioni e dai forti di Capua, cagionava perdite enormi; lo stesso brigadiere Puppi, mentre con temerario ardimento si esponeva alla testa dei suoi, cadeva mortalmente ferito. Ormai lo scopo che il comandante superiore erasi prefisso poteva ritenersi pienamente ottenuto; per cui venne ordinato di retrocedere ordinatamente, per riprendere ciascun corpo le proprie posizioni. Al capitano Pedotti coi suoi bersaglieri milanesi, coadiuvato dal luogotenente Zancarini, comandante la compagnia Genio, fu dato l'arduo incarico di sostenere e proteggere la ritirata del grosso delle truppe garibaldine e di trarre in salvo l'artiglieria, specialmente i pezzi che il fuoco nemico aveva smontati.[83]
Il nemico, appena visto che i nostri muovevano in ritirata, baldanzosamente usciva in buon numero dal forte per inseguirli e molestarli; ma venne arrestato dalle punte delle baionette dei bravi bersaglieri che, guidati dal loro comandante capitano Pedotti e assecondati dal 3o battaglione comandato dal capitano De Caroli, lo misero in fuga, inseguendolo fin sotto ai bastioni di Capua, al grido di "viva Garibaldi".
Il capitano Pedotti per la sua eroica condotta veniva proposto per la promozione e per la croce dell'Ordine Militare di Savoia.
Altri ufficiali per la loro bella condotta ebbero pure meritate onorificienze.
Il maggiore Cattabeni, partito secondo l'ordine ricevuto da Caserta alle 3 pom. del giorno 18, arrivava a Limatola a mezzanotte e mandava il seguente rapporto:
Al generale Turr.
"Mi trovo ad un terzo di miglio dalle sponde del fiume. Mi è riuscito ottenere tre pescatori che mi serviranno di guida. Da qui a Caiazzo vi sono circa 4 miglia. I soldati riposano, e alle 2 e mezza riprenderò la marcia. Ho ordinato ai soldati di mettere le giberne all'estremità del[84] fucile, perchè troveremo un mezz'uomo d'acqua abbondante.
"Dai rinsegnamenti avuti, in Caiazzo ci sono 600 regi, con due pezzi d'artiglieria.
"Al giungere di questo rapporto, son sicuro Caiazzo sarà in nostro potere. Non potevamo scegliere un miglior punto di questo per passare il fiume. Alle 4 e mezza darò l'assalto a Caiazzo, e vedrà che i cacciatori di Bologna son degni di essere sotto i suoi comandi".
firmato G. B. Cattabeni.
E, come aveva promesso, le truppe comandate dal Cattabeni alle 5 e mezza entravano a Caiazzo.
Ottenuto lo scopo della ricognizione e di esplorare le forze del nemico, il Turr esponeva al generale Garibaldi la necessità di ordinare al Cattabeni di sgombrare Caiazzo; ma Garibaldi mostrava ripugnanza di abbandonare una così bella posizione; e allora Turr fatta comprendere la difficoltà di sostenere con un battaglione una posizione così lontana, al di là di un fiume, raccomandò a Garibaldi di farla occupare fortemente, e il generale dava ordini al Medici di mandarvi una brigata della sua divisione; disgraziatamente era però già troppo tardi.[85]
Il generale Garibaldi, visto che il Turr aveva bisogno di riposo, per migliorare la sua salute il 20 gli telegrafava così:
Al generale Turr, Caserta.
"Subito giunto Medici a Caserta incaricato del Comando, venite qui a passare qualche giorno Napoli 20, ore 6,50" G. Garibaldi.
Intanto il generale Garibaldi avendo constatato colle ricognizioni del 19, opportunamente ordinate dal Turr, di avere da fare con un nemico che disponeva di molte forze, si preparava per affrontarlo.
Ma, mentre questo avveniva nel campo garibaldino, i borbonici preoccupati della perdita di Caiazzo, determinavano di riprenderlo immediatamente e ad ogni costo.
La mattina del 21 settembre cinque battaglioni di cacciatori regi, due squadroni di cavalleria ed una batteria da campagna, sotto il comando del generale Colonna uscivano da Capua per investire Caiazzo.
Il comandante dell'11o battaglione garibaldino che occupava la posizione avanzata di Monte S. Nicola, avvisava il brigadiere Spangaro di questo movimento; ma era troppo tardi! I rinforzi[86] non potevano arrivare in tempo, solo il colonnello Vacchieri con 600 uomini potè giungere in sussidio dal Cattabeni.
Ma che potevano fare i comandanti garibaldini contro l'enorme superiorità delle forze nemiche? Essi occuparono un bosco di olivi, barricarono le strade di Caiazzo ed attesero di piè fermo il nemico. Si cominciò a combattere fuori le città ma, incalzati da ogni parte, i garibaldini mancanti di artiglieria, oppressi dal numero, abbandonarono la campagna e si ritirarono nella città dietro le barricate, per resistere fino all'estremo. Avveniva allora un fatto atroce; mentre i nostri combattevano alla difesa delle barricate, i reazionari li fucilavano alle spalle dalle case e dai tetti. Ogni resistenza diveniva impossibile, inutile; le barricate erano demolite dal cannone borbonico, i garibaldini assaliti di fronte e alle spalle; il Cattabeni cadeva ferito gravemente mentre incoraggiava alla resistenza; molti altri ufficiali feriti caddero prigionieri; i garibaldini cercarono di salvarsi ritirandosi, ma, incalzati dalla cavalleria, molti rimasero sul terreno, altri si gettarono nel fiume, ove non pochi perdettero la vita, sicchè del battaglione Cattabeni ben pochi rientrarono in Caserta.[87]
Verso la fine di settembre Garibaldi, presentendo che i napoletani, forti di oltre quarantamila uomini, rinchiusi a Capua avrebbero fatto un supremo sforzo per riconquistare Napoli al loro Re, aveva mandato fuori un caldo proclama chiamando i commilitoni a raccolta e chiedendo all'Italia nuovo aiuto d'uomini, pel compimento dei suoi voti di libertà e d'indipendenza.
Alla chiamata di Garibaldi volle rispondere anche l'Elia, che il Prodittatore Depretis aveva mandato a Bologna alle cure del professore Rizzoli; sebbene assai sofferente e impedito di parlare, pur'egli sentì il dovere di non mancare allo appello, tanto più che il tenente Lanari, superstite del battaglione Cattabeni, si offriva di accompagnarlo.
Quando il generale lo vide a Caserta lo accolse con gioia ed amore, rallegrandosi di vedere avverata la sua profezia del 15 maggio a Calatafimi "Coraggio, mio Elia, di queste ferite non si muore" che egli si compiacque di rammentare ai presenti del quartiere generale.
Come Garibaldi aveva previsto i borbonici si preparavano ad una fiera, disperata riscossa.[88]
Ma il generale dal canto suo non si faceva cogliere sprovvisto.—Egli si approntava a ricevere il nemico come si conveniva, e prendeva il partito il fronteggiarlo in tutti i punti, pei quali avrebbe potuto sfondare e marciare su Napoli.
A questo scopo dava le sue disposizioni.
Le posizioni dell'esercito garibaldino, cominciando dalla sua estrema destra, cioè da Maddaloni, descrivendo un semicerchio erano le seguenti:
Monte Longone, Monte Caro, Castelmorone, posto di prolungamento della linea tra Maddaloni e S. Leucio; S. Leucio, Sant'Angelo, Santa Maria e San Tommaso, le quali erano occupate così:
Sopra Maddaloni Bixio colla sua divisione, che componevasi delle brigate Dezza e Spinazzi, più la brigata Eberhardt della Divisione Medici, con la colonna Fabrizi, in tutto 5500 uomini circa, con 8 pezzi di artiglieria.
A Castelmorone, passo da Caserta a Limatola, il battaglione Bronzetti di soli 270 uomini.
A S. Leucio il generale Sacchi colla sua brigata (divisione Turr) di 2000 uomini circa.[89]
A Sant'Angelo il generale Medici con la sua divisione (meno la brigata Eberhardt) e colla brigata Spangaro (divisione Turr) in tutto 4500 uomini circa, con 9 pezzi da campagna e il reggimento Brocchi del genio con 300 uomini.
A San Tommaso, estrema sinistra, della divisione Cosenz, il reggimento Fardella esteso fino alla ferrovia di S. Maria e a Capua, ove eravi pure una mezza batteria, i reggimenti Malenchini e Laugè della divisione Cosenz, sulla strada ruotabile a destra di S. Maria, ed a sinistra verso la ferrovia la brigata La Masa con una compagnia del genio, distesa verso lo stradale Santa Maria-Sant'Angelo; la batteria della divisione Turr a Porta Capua di S. Maria. Tutta questa forza sotto gli ordini del generale Milbitz.
Ad Aversa il colonnello Corte con la brigata di formazione.
La riserva forte di 5500 uomini circa, con 12 pezzi di artiglieria, sotto gli ordini del generale Turr a Caserta.
La battaglia era imminente; Garibaldi la presentiva. Il 30 di settembre aveva notato un gran movimento in Capua, e siccome era sicuro di aver indovinato il pensiero del suo avversario,[90] mandava gli aiutanti ad avvertire i suoi Luogotenenti che facessero buona guardia perchè l'indomani sarebbe avvenuto l'attacco generale, ultimo, disperato tentativo da parte dei borboni.
Il 1o ottobre, alle 3 del mattino, il generale Garibaldi seguito dal suo stato maggiore e dai suoi aiutanti montava in ferrovia e giungeva a S. Maria sul far dell'alba. Il Milbitz era già alle prese col generale Tabacchi in S. Maria, e il Medici con Afan de Rivera a S. Angelo.
Il generale Tabacchi, attaccando S. Maria e trovando forte resistenza di fronte da parte dei reggimenti Lauger, Sprovieri, Corrao e La Porta, spinse una parte delle sue truppe a sinistra per girare la città e tagliare le comunicazioni fra S. Maria e Sant'Angelo; ma se ne avvide del tentativo Garibaldi ed ordina alla brigata Assanti di accorrere in aiuto.
Dava pure ordine al 2o battaglione bersaglieri livornesi comandati dal maggiore Sgarallino di spingersi a sinistra dalla strada per S. Angelo, al 2o reggimento colonnello Borghesi, ed al 1o comandato dal tenente colonnello Fazioli, di occupare il cimitero ed una casa, per tener testa all'irrompente nemico. Tutti questi ordini[91] rigorosamente eseguiti, malgrado il fulminare incessante del nemico, rafforzano la minacciata posizione tenuta con estremo valore dal brigadiere Malenchini e dai suoi eroici compagni. L'attacco fulmineo della brigata Assanti e dei bravi guidati da Lauger, Sprovieri, Palizzolo, Malenchini, La Porta ferma lo slancio del nemico che si riduce ad investire Santa Maria.
Mentre a destra ardeva così il combattimento a Sant'Angelo i Regi facevano i più arditi sforzi, con le più grandi masse, per sfondare la linea occupata dai nostri e irrompere su Caserta e Napoli. Il Dunn, lo Spangaro, il Simonetta, il Ferrari, il Pedotti facevano sforzi eroici per contenere ed arrestare l'impeto del nemico, ma battuti da tutti i lati dall'artiglieria dei Regi, ferito il brigadiere Dunn, morto il comandante del battaglione Ramorino, feriti i capitani Tito, Franco ed altri, sono costretti a dare indietro e a riparare dietro le barricate.
Il generale Medici comprendeva che la perdita della sua posizione sarebbe stata la perdita della battaglia e l'occupazione da parte dei Regi di Caserta e di Napoli. Bisognava vincere ad ogni costo: "Avanti figliuoli" egli grida—"moriamo[92] tutti qui se occorre, ma vinciamo in nome d'Italia e di Garibaldi".
"Avanti tutti" egli grida—e colla risoluzione di vincere o di morire si mette alla testa dei suoi e, sorretto dalla sezione d'artiglieria comandata dal tenente Torricelli, si slancia contro il nemico affrontandone il turbine di fuoco, caricando furiosamente alla baionetta; cadeva nella brillante carica il maggior Castellazzo, il luogotenente Capanelli e molti altri, ma il nemico era fermato e obbligato a retrocedere.
Il generale Garibaldi che dalle prime ore del mattino si trovava a S. Maria, confidando interamente in Milbitz, suo vecchio compagno di Roma, cui aveva raccomandato di tener duro e impedire ad ogni costo che le comunicazioni tra S. Maria e Sant'Angelo fossero tagliate, montò in vettura e, scortato dal suo stato maggiore, da Missori, da Arrivabene, da Canzio, da Basso e da alcune guide, si mosse verso Sant'Angelo per vedere se, anche in quel campo d'azione, il combattimento era impegnato seriamente.
La strada che da S. Maria va a Sant'Angelo era fulminata; il generale Garibaldi in quel momento supremo per le sue armi nel traversarla[93] si trovò avvolto in un nembo di morte; la carrozza tempestata da una grandine di fucilate fu involta fra un nugolo di nemici. Già le scariche avevano ucciso un cavallo ed il cocchiere, talchè Garibaldi fu costretto a balzare a terra e coi suoi difendersi; cadeva ferito, facendo scudo al generale il prode Arrivabene; il pericolo era grande; ma se ne avvidero i carabinieri genovesi comandati dal Mosto, i carabinieri lombardi comandati dal Simonetta, e il bravo capitano Romano Pratelli comandante la 7a compagnia della brigata Spangaro, i quali tutti si slanciarono con tale impeto che il nemico fu in breve sbaragliato e posto in fuga a punta di baionetta, e a Garibaldi e ai suoi fu aperta la via per Monte Sant'Angelo.
Ivi arrivato trovò Medici che alla testa dei suoi faceva eroici sforzi onde rigettare le masse borboniche e s'avvide che le sommità del Monte S. Nicola erano occupate dai nemici, i quali per strade coperte avevano delusa la vigilanza dei garibaldini e, girato Sant'Angelo, si erano portati dietro la nostra linea, occupando le alture.
Senza perdita di tempo il generale raccolse tutte le truppe che potè avere sotto mano e,[94] preso esso stesso il comando, si avviò per stretti sentieri di montagna passando al di sopra del nemico e d'improvviso fatta una sola scarica si precipitò sui borbonici che ne rimasero schiacciati e fatti prigionieri.
Intanto altre truppe giungevano in aiuto al Medici condotte dal maggiore Farinelli, dal maggior Morici, dal Simonetta, dal colonnello Ferrari, e dal colonnello Guastalla, capo dello stato maggiore; con tutte queste forze il Medici ordinava un estremo assalto alla baionetta; questo fu condotto con tale impeto irresistibile, che i borbonici furono rotti e posti in fuga lasciando numerosi prigionieri.
Quando Garibaldi fu assicurato che a Sant'Angelo per l'eroica condotta dei combattenti potevasi ormai contare sulla vittoria, si lanciò di nuovo verso S. Maria. Mentre accorreva in quella parte ove il combattimento era aspramente impegnato, il generale Turr mandò a Garibaldi un suo ufficiale d'ordinanza, per fargli noto di avere inviata parte della riserva a S. Maria e parte in rinforzo a Bixio; e per chiedergli se credeva arrivato il momento opportuno per fare entrare in combattimento i restanti 3500;[95] Garibaldi gli rispondeva: "marciate con tutte le forze su S. Maria, dove mi troverete".
Il generale Turr non perdette un minuto—egli teneva pronti i suoi—e presto fu a S. Maria ove trovò che Milbitz faceva eroici sforzi per ribattere gli attacchi sempre ripetuti del nemico.
Appena Garibaldi vide Turr con la riserva gli disse: "Siamo vincitori—non occorre che l'ultimo colpo decisivo".
All'istante il generale Turr ordina alla brigata Milano che aveva condotto con sè di caricare il nemico; Garibaldi seguito da Rustow coi suoi usseri si mette alla testa della brigata; tutti gli altri corpi fanno a gara per seguirlo nell'estremo cimento; Corrao, La Porta, Pace, Palizzolo, Sprovieri, Malenchini, Bassini, Tasca si slanciano in furioso attacco; il battaglione Tasca del reggimento Bassini, 1a compagnia Lepore alla testa, affronta il nemico che erasi fortemente trincerato nel Cimitero da dove seminava strage sui nostri; il primo a scalare la cinta è il valoroso furiere Pittaluga; il Pittaluga è seguito dalla 1a compagnia e dalle altre; il Cimitero è preso colla punta della baionetta e il nemico posto in fuga; molti rimangono prigionieri e il[96] prode Pittaluga è promosso sottotenente sul campo di battaglia.
Altri si avventano contro la batteria nemica e se ne impadroniscono.
Ma non era ancora la vittoria predetta da Garibaldi!
A S. Maria ancora si combatteva accanitamente.
La compagnia La Flotte teneva fermo nella Cascina davanti S. Maria dalla mattina, da dove cinque furiosi assalti nemici non avevano potuto sloggiarla. Ma tutti erano sfiniti.
Per fortuna il capitano Adamoli dello Stato maggiore portava la notizia al generale Turr dell'arrivo della brigata Eber; si sentiva il vivissimo fuoco col quale era stata accolta la brigata Milano guidata da Garibaldi in persona, e Turr ordinava che Eber con la brigata, colla legione ungherese e con la compagnia dei cacciatori esteri, accorresse a sostegno.
Il Dittatore, sboccato sulla strada S. Angelo colla brigata Milano, era stato accolto da fuoco violentissimo sulla sua sinistra; la cavalleria borbonica si slanciava alla carica, ma i bersaglieri milanesi mandati dal Medici a sostegno e guidati[97] dal capitano Pedotti, tennero testa con una furiosa controcarica loro e della legione ungherese e mettono in fuga, sbaragliata, la cavalleria borbonica.
Era ora di finirla; e Garibaldi manda ordine al Turr a S. Maria, a Medici a Sant'Angelo, perchè si faccia un ultimo supremo sforzo su tutta la linea; Scheiter coi suoi usseri ungheresi, Corrao, La Porta, coi loro reggimenti; Tanara, Cucchi, Tasca coi loro battaglioni si lanciano in aiuto delle truppe di Malenchini e del Bassini e tutti uniti si avventano contro il nemico con furiosa carica alla baionetta; il nemico è rotto su tutta la linea, sbandato ed in ritirata su Capua.
La giornata del 1o ottobre fu memorabile.—In quel fiero combattimento anche una volta Garibaldi dava prova di grande sapienza militare: i suoi luogotenenti Turr, Medici, Bixio, Milbitz e Dezza, si mostrarono degni di lui; i bravi garibaldini tutti, diedero prove di grandissimo valore e di abnegazione. Moltissimi furono coloro che si distinsero e fra questi i colonnelli Borghesi e Fazioli, il maggiore Pedotti, il tenente Carbone, il Tommasi, che il Malenchini promosse capitani; a fianco del Carbone[98] combattè da valoroso il furiere maggiore Coffa che veniva promosso sottotenente e fregiato della medaglia al valore militare.
Verso le 6 pom. tutta la linea di battaglia da S. Maria alle alture di S. Angelo era abbandonata dai nemici e i garibaldini estenuati, dopo 14 ore di combattimento accanito, potevano riposarsi sul campo tanto gloriosamente difeso.
Anche da Maddaloni Bixio aveva mandata la notizia della vittoria su tutta la sua linea.
Il combattimento fu lungo ed accanitissimo.—Bixio aveva voluto dai suoi compagni nel grave cimento la promessa che sarebbero morti tutti al loro posto piuttosto che permettere ai borbonici di marciare su Caserta—"Devono passare sui nostri corpi" aveva detto e gli assalti delle truppe regie, replicati ed accaniti, furono respinti ed infine i nemici furono posti in fuga.
Gli atti di eroismo di Bixio, di Dezza, di Menotti Garibaldi, degno figlio del padre, e di tanti altri, fra i quali si distinse anche il tenente Venzo che con pochi de' suoi fugato il nemico s'impadroniva di un cannone, non possono descriversi: si comportò da valoroso il tenente Giorgi Tullio;[99] venne proposto per la promozione e per la medaglia al valore il tenente Taglieri Antonio e si distinsero molti e molti altri nel fiero combattimento, che fu vinto colla punta della baionetta e con atti di vero eroismo.
È degno di memoria onorata questo episodio; mentre si combatteva accanitamente in tutta la linea a S. Maria, a S. Angelo ed a Maddaloni, il maggiore Bronzetti con 270 dei nostri sosteneva a Castel Morrone l'urto di 3000 borbonici, respingendoli a varie riprese in ben dieci assalti; la maggior parte di quei bravi era caduta; invano gli ufficiali napoletani esortavano i superstiti ad arrendersi, facendo sapere che tanto valore sarebbe stato rispettato; Pilade Bronzetti resistette entro il castello finchè ebbe cartucce, e, quando queste vennero meno, i difensori di Castel Morrone vollero morire da eroi. Stretti come un sol uomo, tentarono aprirsi un varco colla baionetta tra le migliaia dei nemici; caddero quasi tutti; fu ferito a morte lo stesso eroico Bronzetti e i pochi non feriti vennero condotti prigionieri. Fra questi eroi sacrati alla morte, combatterono disperatamente il valorosissimo Mirri capitano ed i tenenti Matteo Renato[100] Imbriani e Vincenzo Migliorini, che si guadagnarono la medaglia al valore militare e la promozione.
Mentre Garibaldi co' suoi del quartiere generale si ritirava da S. Angelo, s'imbattè nei carabinieri genovesi che vollero fargli scorta; fatto l'alt per il rancio, e per un piccolo riposo di cui tutti sentivano il bisogno, venne al Generale l'avviso che una colonna di 5000 borbonici trovavasi a Caserta vecchia, pronta a piombare su Caserta, quartiere generale garibaldino. Mandate staffette per avvertire Sirtori che era a Caserta e Bixio a Maddaloni, egli coi carabinieri genovesi e con altre forze, che potè avere sotto mano, si mise subito in marcia, prendendo la via della montagna. I nemici si erano mossi su Caserta ove trovavano Sirtori che li ricevette vigorosamente; e, sorpresi ai fianchi ed alle spalle dalle forze di Bixio e da quelle condotte da Garibaldi, dopo poca resistenza furono fatti prigionieri.
La vittoria del Volturno del 1 e 2 ottobre aveva tolto ai borbonici ogni possibilità di rivincita; rinchiusi nelle fortezze di Capua e Gaeta[101] non avevano altro scampo, che una resa più o meno lontana.
Però un pensiero crucciava Garibaldi. Esso diceva con gli amici nei brevi momenti di riposo al quartier generale di Caserta: "Il primo ottobre abbiamo sconfitto il nemico a tal punto, che non sarà più in grado di affrontarci; ma non posso andare a Roma, lasciando addietro 40,000 uomini trincerati in due fortezze: essi si riprenderebbero Napoli, quando io coi miei non fossimo qui a difenderla".
A distoglierlo da cotali pensieri era avvenuto un fatto politicamente assai importante.
Decisa l'occupazione delle Marche e dell'Umbria da parte delle truppe Piemontesi, il Conte di Cavour ne dava avviso con sua nota del 7 settembre 1860 al Cardinale Antonelli nella quale si diceva: Che il governo Sardo era dovuto venire in quella determinazione perchè "la coscienza del Re Vittorio Emanuele non[102] gli permetteva di rimanersi testimone impassibile delle sanguinose repressioni con cui le armi dei mercenari stranieri al soldo del governo papale, soffocherebbero nel sangue italiano ogni manifestazione del sentimento nazionale. Niun governo ha diritto di abbandonare all'arbitrio di una schiera di soldati di ventura gli averi, l'onore, la vita degli abitanti di un paese civile.
"Per questi motivi dopo aver chiesti gli ordini di S. Maestà il Re mio Augusto Sovrano, ho l'onore di significare a Vostra Eminenza che truppe del Re hanno incarico d'impedire, in nome dell'umanità, che i corpi mercenari pontificii reprimano colla violenza l'espressione dei sentimenti delle popolazioni delle Marche e dell'Umbria.
"Ho inoltre l'onore d'invitare Vostra Eminenza, per i motivi sopra espressi, a dare l'ordine di disarmare e di sciogliere quei corpi, la cui esistenza è una minaccia continua alla tranquillità dell'Italia.
"Nella fiducia che V. Eminenza vorrà comunicarmi tosto le disposizioni date dal governo di S. Santità in proposito, ho l'onore di rinnovarle gli atti dell'alta mia considerazione.
Firmato: C. Cavour"
Sciogliere l'esercito sarebbe stato lo stesso che aprire le porte alla rivoluzione; il governo pontificio dovette scegliere la guerra.
Dopo la giornata del 1859 nella quale le truppe pontificie comandate dal generale Schmidt espugnarono Perugia commettendovi fatti atroci, Cortona era divenuta il centro dei nuovi preparativi insurrezionali nel limitrofo Stato romano. Emigrati perugini, come il Danzetta, il conte Ansidei, il Pompili ed il Massarucci vi avevano preso stanza e vi tenevano adunanze di patrioti; v'interveniva anche il Gualterio che aveva preso parte al movimento del 27 aprile in Toscana. Questi, assieme al Diligenti, si recava a Torino dal conte di Cavour per stabilire accordi per una prossima sollevazione dell'Umbria.
Gli accordi furono questi: il Danzetta ed il Massarucci con altri patrioti ed amici dovevano preparare una sollevazione nel punto che essi avessero creduto il migliore per l'8 o 9 di settembre. Il Diligenti venne incaricato di intendersi coi patrioti Toscani vicini alla frontiera perchè si riunissero in armi a Chiusi il giorno 7 e di là corressero a prestare man forte ai sollevati dell'Umbria; il Diligenti per questo s'intese anche coi liberali livornesi e tutto era stabilito.[104]
Cento patrioti dell'eroica città di Perugia, dei quali erano capi Ugolini conte Galeazzo e Manni Gaetano, uscirono dalla città, si diressero all'osteria dell'Ellera, poco distante, ove trovarono ordine di recarsi a Chiusi per concretare le operazioni da farsi; durante il cammino incontrarono una squadra di gendarmi, impegnarono la lotta, ne uccisero alcuni e fecero gli altri prigionieri.
A Todi ed a Terni altri patrioti dei quali era alla testa il conte Alceo Massarucci erano pronti pel movimento; e l'8 di settembre i patrioti che il Massarucci aveva radunati si mettevano in marcia; erano circa 400 mandati dal Massarucci, dal Theodoli Mario, da Baldoni Giuseppe, e da Colacicchi di Todi; luogo di convegno era l'altura di Allerona; vi arrivarono alle 11 della notte del 9 ove trovarono i volontari condotti dal Danzetti e dal Bruschi. A Chiusi aveva preso il comando di altri 300 volontari, il colonnello Masi e ne aveva formata la legione alla quale aveva dato il nome dei Cacciatori del Tevere. Partito il Masi da Chiusi si diresse su Città della Pieve, ove nominava un governo provvisorio. Giungevano da Chiusi altri 150 volontari condotti dal capitano Giuseppe Baldini. Il giorno 10 il[105] colonnello Masi, arrivava al convento di S. Lorenzo ove erano adunati i volontari dell'Umbria e prendeva il comando del corpo di circa mille uomini.
Fu deciso di marciare su Orvieto e, colle intelligenze che si avevano nell'interno, impadronirsi della città di notte e di sorpresa. Il colonnello riunita la colonna nel piazzale del convento di S. Lorenzo, con voce vibrata disse parole patriottiche agli adunati chiedendo a tutti abnegazione e valore; tutti lo giurarono. Divise quindi le forze in due colonne, una la prese con sè e si diresse al nord della città d'Orvieto, con la speranza che gli amici interni gli aprissero la porta da quel lato della città come era convenuto, l'altra colonna sotto il comando del capitano Liborio Salvatori si diresse dalla parte sud della città, su quel cono di tufo alto ed inaccessibile, nel mezzo della spianata del quale sorgono le mura dell'antica Orvieto.
Erasi convenuto con i liberali orvietani che verso la mezzanotte avrebbero fatto scendere una scala di corda per la quale i volontari da fuori sarebbero ascesi sulle mura. All'ora stabilita la scala era al posto; primo a montarvi[106] fu il coraggioso Delbontromboni Giovanni di Crevalcore, già caporale dei finanzieri pontifici; altri lo seguirono; nel salire assai faticoso, disgrazia volle che i fucili di quei bravi urtassero e facessero rumore; già il bravo Delbontromboni stava per arrampicarsi sulla sommità delle mura, quando una voce gridò; "Chi vive?" alla risposta "Roma" seguì una detonazione che fu susseguita da altre; la scala venne abbandonata da coloro che la tenevano e i volontari che vi erano saliti, sbattendo violentemente contro il tufo, precipitarono nel fossato. Il tentativo era fallito e la colonna dovette ritirarsi a S. Lorenzo, ove prima del giorno faceva pur ritorno il colonnello Masi, essendogli fallito anche il tentativo dell'apertura della porta al nord della città.
L'audace tentativo non andava però perduto; il giorno seguente le autorità cittadine guidate dal conte Piccolomini, assecondate dal popolo orvietano tutto assembrato, si presentavano al legato del Papa monsignor Cerruti chiedendo si aprissero le porte alle truppe nazionali e si evitassero conflitti.
Il delegato, dopo breve indugio, accordava la[107] resa e dava incarico per l'esecuzione alla rappresentanza comunale; così i cacciatori del Tevere entravano in Orvieto dalla parte della Rocca, mentre i papalini ne uscivano dalla porta Romana.
La sera del 17 settembre i cacciatori incolonnati prendevano la via di Bagnorea preceduti da ardita avanguardia comandata dal tenente marchese Mario Theodoli. Arrivata la colonna a Bagnorea dopo breve sosta, riprese la marcia per Cellino e Montefiascone; si sperava di arrivare al paese di sorpresa, ma a tre chilometri distanti alcuni uomini dell'avanguardia mandati avanti dal Theodoli ad esplorare, s'imbatterono in una pattuglia di gendarmi a cavallo; altri a piedi seguivano a distanza; gli uomini dell'avanscoperta aprirono il fuoco: i carabinieri a piedi che si trovavano a distanza si misero in fuga, quelli a cavallo che erano già sopra ai nostri furono fatti prigionieri. Ma i fuggiti avevano dato l'allarme e la sorpresa non fu più possibile.
Una compagnia di pontifici (belgi) si fece avanti per arrestare l'avanguardia dei cacciatori comandati dal Theodoli, ma i nostri, fatta una scarica, e sorretti dal corpo del Masi sopraggiunto[108] di corsa, attaccano i belgi alla baionetta, li mettono in fuga e con essi entravano a Montefiascone, mentre i papalini fuggivano dalla parte opposta per la via di Viterbo.
Il giorno 20 settembre la guarnigione pontificia avendo abbandonato Viterbo, una deputazione cittadina veniva ad invitare Masi ad entrarvi, ed alle 5 pomeridiane dello stesso giorno i nostri erano a Viterbo. Il 24 i cacciatori del Tevere occupavano Civitacastellana e Corneto.
Il 2 di ottobre i cacciatori lasciata Civitacastellana giunsero parte a Rignano Flaminio, altri a Castelnuovo di Porto e una colonna a Fiano Romano; il 5 tutta la colonna transitava sulla sinistra del Tevere e nel pomeriggio arrivava a Poggio Mirteto, città delle più patriottiche.
Presavi stanza il colonnello Masi spediva il Diligenti ed il Massarucci al generale Brignone in Terni per sapere se poteva proseguire il suo movimento verso Roma e quali erano le intenzioni del Governo.
I due patrioti venivano incaricati dal generale di fare sapere al colonnello Masi che ogni speranza di andare a Roma era svanita e che[109] ordine perentorio eravi di sgombrare dal così detto patrimonio di S. Pietro.
Fu forza al Masi di ubbidire e l'8 di ottobre non restava un volontario sulla sinistra del Tevere. I cacciatori del Tevere si erano ridotti a Montefiascone diretti per Orvieto, da dove avevano mossi i primi passi pieni di ardire e di speranze; il 20 dovettero abbandonare anche Orvieto!
In seguito i cacciatori del Tevere formati in due battaglioni, sotto gli ordini del colonnello Masi, poterono rendere segnalati servigi al paese combattendo il brigantaggio che nell'Ascolano e negli Abruzzi perpetravano atrocità inaudite specialmente in Collalto, segnalandovisi in modo particolare il capitano Marchese Mario Theodoli che si meritava promozioni ed onoreficenze; vi si distinsero pure il tenente Giulio Silvestri ed il più giovane fratello Annibale sottotenente, romani.
Per liberare l'Umbria dai mercenari del papa comandati dal famoso generale Schmidt, fu dato incarico al generale Fanti, comandante del 5o corpo, il quale formò il piano seguente:[110]
1o Impadronirsi di Perugia come base d'operazione;
2o Marciare compatti su Foligno, centro delle comunicazioni dello Stato pontificio con l'intento d'assicurare per ogni evento la congiunzione col 4o corpo, comandato dal Cialdini;
3o Da Foligno rivolgersi su Spoleto o su Ancona secondo le mosse di Lamoricière.
Il generale De Sonnaz con la brigata granatieri di Sardegna ed altre truppe sussidiarie, bersaglieri, artiglieria, cavalleria e genio, doveva occupare Perugia. La mattina del 14 settembre investiva la piazza murata e alle ore 9 la colonna di destra comandata dallo stesso generale De Sonnaz, sfondava la porta S. Antonio e coi bersaglieri in testa, comandati dal colonnello Pallavicini, entrava in città. Mentre questo avveniva a destra, i granatieri di Sardegna a sinistra sfondata la porta Santa Margherita entravano essi pure trionfanti in Perugia. Il generale Schmidt che si era ritirato nel forte, alle 6 pomeridiane capitolava. Così per le eccellenti disposizioni tattiche prese dal generale De Sonnaz e pel valore delle nostre truppe si ebbe espugnata l'importantissima piazza di Perugia e si arrendevano[111] prigionieri 1700 ponteficii con sei pezzi d'artiglieria e la bandiera del 2o reggimento estero.
Nelle Marche le cose andavano così:
L'8 settembre Urbino insorgeva e fugati i gendarmi pontificii, abbattuti gli stemmi del governo papale proclamava l'unione all'Italia sotto la dinastia di Savoia; Fossombrone ne seguiva l'esempio innalzando il vessillo tricolore. A tale notizia il generale Lamoricière mandava ordine al Di Curten di ridurre a servitù le ribellate città. Il giorno 11 Fossombrone veniva violentemente assalita da una forte colonna di mercenari, i quali sorpresa la città vi rinnovarono le scelleratezze e gli eccidî che funestarono la patriottica Perugia; non ebbe il prode Di Curten l'ardire di assalire Urbino, ove lo attendevano in armi i generosi cittadini rafforzati da 800 volontari accorsi in loro soccorso dalle terre vicine, risoluti all'estrema resistenza.
Nè, nella baldanza brutale di quell'orgia sanguinaria, ardiva di muovere su Pergola che erasi pure sollevata con grande entusiasmo e si sosteneva con vigoroso ardimento, ispirato coll'esempio[112] dai patriotti G. Batt. Jonni e Ascanio Ginevri.
Per tutte le Marche il Lamoricière aveva fatto proclamare lo stato d'assedio e le scorazzava terrorizzando le popolazioni con atti feroci.
Al Cialdini, a cui il governo del Re aveva dato l'incarico di liberare le Marche da tanto flagello, era imposto il dovere di accelerare le sue mosse per cogliere il nemico disseminato e sconfiggerlo prima che avesse potuto raccogliersi.
Il mezzogiorno del 11 settembre una brigata di cavalleria e tre battaglioni di bersaglieri, divorata la via, accerchiavano la città di Pesaro.
Il Cialdini mandava un parlamentario coll'intimazione della resa, ma essendo stata questa respinta, l'artiglieria, che appena arrivata aveva preso posizione, apriva il fuoco contro porta Rimini e porta Cappuccini. Dopo un'ora di cannoneggiamento i nostri bravi bersaglieri entravano in città per le porte sfondate.
La guarnigione mercenaria erasi riparata nel forte coll'intendimento di resistere; ma il giorno di poi dopo un vivacissimo fuoco della nostra artiglieria piazzata sul colle di Loreto, inalberava bandiera bianca e si arrendeva a discrezione.[113]
Il giorno 12 i nostri s'impadronirono di Fano e la mattina del 13 riprendevano la marcia per Ancona.
Il 14 si volle dare un po' di riposo alle truppe a Senigallia, ma, saputosi che la colonna del generale Di Curten si trovava sulle alture di S. Angelo, il bravo generale Leotardi ordinava al brigadiere Avogadro di Casanova di muovere subito ad attaccarli e questi, con due battaglioni della brigata Bergamo e coi Lancieri di Milano, verso le 2 pomeridiane assaliva il nemico vigorosamente e lo sbaragliava, facendo buon numero di prigionieri.
Nella notte del 14 il generale Cialdini veniva informato che il generale Lamoricière si dirigeva per la Valle del Chienti a marcie forzate verso Ancona con circa 4000 uomini e che era seguito, ad un giorno di distanza, dal general Pimodan colla 2a brigata di circa 5000 uomini; e gli si riferiva pure che avrebbe passata la notte del 15 a Macerata.
Da Macerata per Ancona il Lamoricière poteva percorrere tre strade; la 1a, più breve e più diretta, discende in Val di Potenza, passa questo fiume, sale a Monte Casciano e per Monte[114] Fiore procede per Osimo e di là ad Ancona; la 2a che, dopo passato il fiume Potenza segue il versante a maestro di questa valle mette a Recanati, sale a Loreto e per la Valle di Musone va alle Crocette di Castelfidardo e ad Ancona; la 3a segue la cresta delle colline fra Potenza e Chienti, per Monte Lupone e Monte Santo sbocca alla spiaggia, varca il fiume Potenza presso la foce, viene a Porto Recanati e per Camerano va ad Ancona.
Il generale Cialdini al mattino del 16 fece occupare un'eccellente posizione fra Osimo e Jesi, spingendosi fino a Castelfidardo.
Per trarre in inganno il Lamoricière sulle sue intenzioni il Cialdini mandava nel cuore della notte del 15 uno squadrone di lancieri a Filottrano, con incarico di ordinare perentoriamente pel mattino seguente 24,000 razioni di pane per l'esercito, il quale doveva attraversare il paese diretto per Macerata. Invece, nella stessa notte, i due battaglioni 11o e 16o che colla brigata Como avevano occupato Torre di Iesi, si portavano a passo accelerato accompagnati da una sezione d'artiglieria, ad occupare la forte posizione di Osimo.[115]
Il Lamoricière arrivò il 15 a Macerata ed il 16 a Loreto, ove il 17 lo raggiunse la colonna Pimodan.
Soltanto il Musone separava i due eserciti; il generale Cialdini aveva dovuto disporre le sue truppe in modo da parare contemporaneamente a due attacchi, convergenti ma provenienti da direzioni opposte, e cioè da Loreto e da Ancona. A tale intento, aveva occupate le colline che dividono il Musone dall'Esino, e si protendono digradando verso il mare fin presso la confluenza dei fiumi. L'ordine di battaglia delle truppe italiane aveva quindi due fronti, l'uno rivolto al nord, verso Ancona e disteso dal ponte delle Ranocchie, per S. Biagio, la Badia e San Rocchetto, alle Crocette: l'altro, rivolto al sud, verso Loreto, dalle Crocette, per Campanari, Castelfidardo, S. Solino ad Osimo. Quest'ultimo era il più forte, come il più potente era il capo pontificio al quale doveva opporsi.
Il Lamoricière, che aveva per obbiettivo Ancona, comprese subito che per raggiungerlo gli era necessario d'impadronirsi della linea di colline che riunisce l'Esino al Musone e più che altro, del poggio che fa culmine al Monte Oro[116] ad oriente delle Crocette. Divise perciò il suo corpo in due colonne: l'una forte di cinque battaglioni, tre squadroni e 12 cannoni guidati da Pimodan, che, con una conversione a sinistra doveva sloggiare le truppe italiane dalla suindicata posizione; la seconda, sotto il proprio comando, forte di quattro battaglioni, riparti di cavalleria e 4 pezzi, doveva attaccare da destra.
Alle ore 9,30 del 18, l'avanguardia pontificia, carabinieri e svizzeri, urtò contro i primi avamposti italiani sulla destra del Musone. L'estrema punta dell'ala sinistra italiana era formata da bersaglieri, ossia dal 26o battaglione, e di una compagnia del 12o, ed occupava col grosso il poggio e col resto il piano inclinato antistante, circoscritto a Nord-Est dall'Aspio ed a Sud dal Musone. Due grosse case coloniche si ergevano in quello spazio, l'una nel piano, l'altra a mezza costa.
Il combattimento si accese innanzi alla casa di sotto, che le cinque compagnie di bersaglieri raccoltesi là intorno, difesero valorosamente contro tre battaglioni pontifici, carabinieri e svizzeri, il primo cacciatori indigeni ed i zuavi franco-belgi con due cannoni; dopo accanitissima resistenza,[117] soprafatti dal numero, i bersaglieri ripiegarono alla casa di sopra, che egualmente tennero con tenacia e che pur dovettero sgombrare. Ma, accorsi a sostegno, prima due e poi due altri battaglioni del 10o reggimento fanteria con due cannoni, dopo pugna ostinata le due case vennero riprese; ed invano varcarono il Musone e si schierarono in battaglia gli altri due battaglioni del Pimodan, che vi perdeva la vita, ed i quattro della colonna Lamoricière con tutta la loro artiglieria. Queste truppe non ressero a lungo al fuoco delle truppe italiane e si ruppero, sbandandosi quali verso Loreto, altre verso Recanati; mentre alcuni piccoli drappelli si diressero verso Umana. Riuscì a pervenire in Ancona solo il generale Lamoricière con pochi dei suoi, deludendo la vigilanza dei nostri.
Alle 2 del pomeriggio il combattimento era cessato.
Dalla parte di Ancona tuonava il cannone. Fin dalle 8 di mattina la flotta aveva aperto il fuoco contro la piazza, danneggiando le opere di Monte Cardetto e di Monte Marano; verso sera si ritrasse al largo avendo raggiunto il suo scopo, cioè quello di distogliere il presidio della piazza[118] dal portare soccorso ai combattenti di Castelfidardo.
Il giorno 19 fra il generale Cialdini ed il colonnello Coudenhoven venne stabilito che i pontificii avrebbero deposte le armi in presenza delle truppe italiane. Si arresero circa 5000 pontificii, con 150 ufficiali; 11 cannoni, cassoni e carri di artiglieria caddero nelle mani del vincitore.
Così ebbe termine la battaglia di Castelfidardo colla vittoria delle armi italiane.
Il giorno 20 il generale Cialdini diede le disposizioni per un largo blocco intorno ad Ancona, in aspettativa della sua 13a divisione e del 5o corpo che distava di poche marcie.
Il giorno 23 il generale Fanti riconobbe la piazza dal lato di mare e presi concerti coll'ammiraglio Persano dichiarò il blocco serrato di terra e di mare; sbarcò il parco d'assedio nella grossa spiaggia di Numana e dispose il completo investimento della piazza.
Dalla parte di terra l'obbiettivo principale era quello di Monte Gardetto, dal qual forte si poteva comandare e battere tutte le altre difese della piazza; per raggiungere tale obbiettivo era[119] necessario impadronirsi delle posizioni fortificate di Monte Pelago e Monte Pulito, onde impiantarvi le batterie per battere la Lunetta di S. Stefeno e Monte Gardetto.
Il generale Fanti ordinava pertanto che si concentrassero vivissimi fuochi d'artiglieria sulla Cittadella e sul campo trincerato, e comandava che si prendessero di viva forza la lunetta di Monte Scrima e il Lazzaretto.
Il giorno 24 si apriva il fuoco contro le opere esterne della piazza.
Dalla sua parte Cialdini radunati su Montagnolo 12 pezzi rigati investiva la Cittadella e il forte Scrima, che fu dovuto abbandonare dalle truppe pontificie e subito occupato dai nostri. Il giorno 25 il generale Cadorna vi piantava la 4a batteria e con essa apriva il fuoco contro il Lazzaretto, dal quale si voleva sloggiare il nemico.
Il giorno 26 fu deciso dal Fanti l'attacco al Monte Pelago. La brigata Bologna, condotta dal brigadiere Pinelli, si slancia col più grande vigore sulla posizione, unitamente al 23o e 25o battaglione bersaglieri, e nonostante la fitta grandine di palle di carabina e di mitraglia dei cinque[120] pezzi ivi piazzati, i nostri bravi continuano la loro corsa; ufficiali e soldati gareggiano a chi prima porrà il piede sul parapetto nemico; in un baleno superano gli spalti, saltano nel fosso, s'arrampicano sui parapetti e la bandiera del 39o reggimento sventola sul culmine del forte: i mercenari sono messi in piena fuga.
I nostri bravi soldati inebbriati dalla vittoria inseguono il nemico, scalano i parapetti della seconda lunetta e v'impiantano la bandiera del 40o reggimento impossessandosi di altri due pezzi.
Monte Pulito viene occupato dal 39o reggimento che vi si stabilisce.
Si dà allora alla squadra il segnale di aprire il fuoco e questa assale con le sue bordate il Gardetto e il Forte dei Capuccini, che ne vengono gravemente danneggiati.
Nella notte del 26 essendosi ultimati i lavori del forte Scrima, e piazzatavi una batteria d'obici ed altra di pezzi rigati sulla sinistra, al far del giorno tutti questi pezzi aprirono il fuoco contro le posizioni fortificate della piazza. Intanto il generale Cialdini ordinava al 7o battaglione bersaglieri, comandato dal capitano Brunetta, sotto la direzione del suo capo di stato[121] maggiore tenente-colonnello Piola, di occupare rapidamente Borgo Pio. Il battaglione si slancia risolutamente, e cacciati i posti nemici lo occupa provvedendo subito alle opere di prima difesa; verso sera due altri battaglioni di bersaglieri il 6o e il 12o rinforzarono il 7o e occupano solidamente quel borgo.
Alle ore 8 del 27 il 6o battaglione dei bersaglieri ebbe l'ordine d'impadronirsi del Lazzaretto; sotto un fuoco micidiale questi bravi si lanciano all'ardita impresa; una barca serve da ponte nello stretto canale che isola il Lazzaretto.
Il primo plotone accompagnato da un drappello di zappatori procede sotto un fuoco vivissimo all'atterramento della porta; ma il sottotenente Ferrari Luigi si slancia entro il ridotto per una cannoniera seguito dai suoi bersaglieri, e, cadendo all'improvviso sul nemico, facilita la apertura della porta; in un'ora l'intero battaglione si stabiliva al Lazzaretto, impossessandosi di 3 pezzi e facendo prigionieri 3 ufficiali ed i soldati che lo presidiavano.
Il giorno 28 e la notte fra il 28 al 29 le truppe piemontesi si occuparono nel piantare a 400 metri dalle mura, nuove batterie. Il Lazzaretto era stato[122] rinforzato da altre truppe, ma vedendo il generale Fanti che le batterie del Molo e quella della Lanterna lo avevano preso di mira e lo fulminavano, dava ordine al contrammiraglio Persano di attaccare quelle batterie e farle ad ogni costo tacere.
Il Persano corrispose prontamente all'invito del Fanti. Ad un'ora pomeridiana la Piro-fregata "Vittorio Emanuele" si abbozzava a 500 metri di distanza dalla batteria Casamatta della Lanterna; le Piro-fregate "Governolo" e "Costituzione" assecondarono la "Vittorio Emanuele" ormeggiandosi a 500 metri di distanza a ponente della Lanterna. Alle due pomeridiane le manovre erano eseguite sotto il fuoco delle batterie della piazza; senonchè il vento forte che soffiava da scirocco fece arare gli ancoroti che tenevano abbozzata la "Vittorio Emanuele" la quale dovette cambiare di posto e per manovrare fu obbligata a mettersi fuori di tiro. Fu segnalato alla "Carlo Alberto" di prendere il posto della nave suddetta e questa s'andò ad abbozzare verso le 3 pom. a 200 metri di distanza dalla Lanterna, senza rispondere neppure con un colpo ai tanti che le piovevano attorno dai forti.[123]
Alle 3 1/2 fatto il tiro di prova questa fregata lanciava tutta la sua fiancata contro la batteria della Lanterna; che ne aveva rovinato il piano superiore. "Il Governolo", "La Costituzione" e il "Carlo Alberto" continuavano a fulminare le batterie del porto.
La "Vittorio Emanuele" rientra in azione e a tutta velocità manovra per passare ad un tiro di pistola dalla Lanterna; alla temeraria manovra rimangono pietrificati gli stessi artiglieri delle batterie nemiche; ma, arrivata la bella fregata all'altezza della Lanterna lancia a bruciapelo la sua terribile fiancata e come se nulla fosse passa avanti prendendo il largo per girare di bordo e portarsi a lanciare all'occorrenza l'altra fiancata; ma non ve ne fu bisogno, perchè ad un tratto si vide uscire denso fumo dalle cannoniere della batteria e da li a poco si fe' udire un terribile scoppio e la Lanterna apparve avvolta in una fitta colonna di fuoco.
Svanito il fumo si vide la batteria ridotta ad un mucchio di macerie, sotto le quali rimasero sepolti ufficiali e artiglieri. La catena che sbarrava l'entrata del porto non esisteva più, perchè i pontoni che la reggevano erano stati affondati[124] dai colpi di cannone delle fregate, per cui il porto stesso era aperto alla nostra squadra e quindi Ancona poteva considerarsi perduta per i mercenari papalini.
Alle 4 1/2 cessava il fuoco ed il maggiore Mauri recavasi a bordo dell'ammiraglio per chiedere un armistizio; ma il Persano rispondeva che egli non aveva la facoltà di accordarlo e che bisognava trattare col generale Fanti; senonchè ripugnando al Lamoricière di trattare col Fanti non mandò alcun parlamentario e quindi il Fanti ordinava che alle 10 di notte tutte le batterie riaprissero il fuoco. Da due ore i nostri fulminavano la città, quando fu annunziato al Fanti l'arrivo di un parlamentario e la resa fu conclusa.
Così poterono fare ritorno in Ancona i patriotti conte Michele Fazioli, conte Ferdinando Cresci, l'Ornani, l'Albani, i fratelli Gigli, il Bravura, l'Andreucci, lo Stronati, i fratelli Schellini, l'Andreani e tanti e tanti altri che per sfuggire alle gravi pene, perfino di morte, inflitte loro dal mansueto governo dei preti, avevano dovuto abbandonare la patria e le loro famiglie.[125]
Disfatto a Castelfidardo il generale Lamoricière ed entrate le truppe italiane nella capitale delle Marche, il conte Cavour, sfidando la collera di qualche potenza europea, chiese al Parlamento subalpino l'approvazione della sua politica, che era quella di annettere tutte le provincie italiane, che liberamente avessero dichiarato di voler far parte della Monarchia Sabauda, ed avutone l'assenso dispose tosto che il Re stesso si mettesse alla testa dell'Esercito per passare il Tronto. Già il Re aveva emanato il seguente proclama ai soldati, che stavano per occupare l'Umbria e le Marche:
Soldati!
"Voi entrate nelle Marche e nell'Umbria, per restaurare l'ordine civile nelle desolate città, e per dare ai popoli la libertà di esprimere i propri voti.
"Non avete a combattere potenti eserciti, ma liberare infelici provincie italiane dalle straniere compagnie di ventura.
"Non andate a vendicare le ingiurie fatte a me o all'Italia, ma ad impedire che gli odi popolari rompano a vendetta della mala signoria.[126]
"Ora insegnerete coll'esempio il perdono delle offese e la tolleranza cristiana a chi, stoltamente paragona all'islamismo, l'amor della patria italiana.
"D'accordo con tutte le grandi potenze, ed alieno da ogni provocazione, io intendo togliere dal centro d'Italia una cagione perenne di turbamento e di discordia. Io voglio rispettare la sede del Capo della Chiesa, al quale sono sempre pronto a dare io, d'accordo colle potenze alleate ed amiche, tutte quelle guarentigie d'indipendenza e di sicurezza, che i suoi ciechi consiglieri si sono indarno ripromessi dal fanatismo delle sette malvagie, cospiranti contro la mia autorità e la libertà della Nazione.
"Soldati! Mi accusano di ambizione. Sì, ho un'ambizione: ed è quella di restaurare i principii dell'ordine morale in Italia, e di preservare l'Europa dai continui pericoli della rivoluzione e della guerra".
11 settembre 1860.
Vittorio Emanuele.
Il generale Cialdini nell'imminenza della battaglia di Castelfidardo dirigeva questo proclama alle truppe:[127]
Soldati di questo Corpo d'Armata!
"Vi conduco contro una masnada di briachi stranieri, che sete d'oro e vaghezza di saccheggio, trasse nei nostri paesi.
"Combattete, disperdete inesorabilmente quei compri sicari, e per mano vostra sentano l'ira di un popolo, che vuole la sua nazionalità e la sua indipendenza.
Soldati!
"L'invitta Perugia domanda vendetta e, benchè tarda, l'avrà.
"Il generale comandante il 4o corpo d'armata
Cialdini"
Garibaldi, informato che il generale Cialdini aveva disfatto a Castelfidardo i mercenari del Papa capitanati dal Lamoricière, emanava il seguente ordine del giorno:
Caserta, 5 ottobre 1860
"Il quartiere generale è a Caserta; i nostri fratelli dell'Esercito italiano, comandati dal bravo generale Cialdini, combattono i nemici d'Italia e vincono.
"L'esercito di Lamoricière è stato disfatto da quei prodi. Tutte le provincie serve del Papa[128] sono libere. Ancona è nostra: i valorosi soldati dell'esercito del settentrione hanno passata la frontiera e sono sul territorio napolitano. Fra poco avremo la fortuna di stringere quelle destre vittoriose.
G. Garibaldi"
Il 7 ottobre indirizzava a Vittorio Emanuele la lettera seguente:
Sire!
"Mi congratulo colla Maestà Vostra per le brillanti vittorie riportate dal vostro bravo generale Cialdini e per le felici loro conseguenze. Una battaglia guadagnata sul Volturno ed un combattimento alle due Caserte, pongono i soldati di Francesco II nell'impossibilità di più resisterci. Spero dunque poter passare il Volturno domani. Non sarebbe male, che la M. V. ordinasse a parte delle truppe, che si trovano vicino alla frontiera abruzzese, di passare quella frontiera e fare abbassare le armi a certi gendarmi che parteggiano ancora pel Borbone.
"So che V. M. sta per mandare quattromila uomini a Napoli, e sarebbe bene. Pensi V. M. che io le sono amico di cuore e merito un poco di essere creduto. È molto meglio accogliere[129] tutti gli italiani onesti a qualunque colore essi abbiano appartenuto per il passato, anzichè inasprire fazioni, che potrebbero essere pericolose nell'avvenire.
"Essendo ad Ancona, dovrebbe V. M. fare una passeggiata a Napoli per terra o per mare. Se per terra, e ciò sarebbe meglio, V. M. deve marciare almeno con una divisione. Avvertito in tempo, io vi congiungerei la mia destra e mi recherei in persona a presentarle i miei omaggi e ricevere ordini per le ulteriori operazioni.
"La M. V. promulghi un decreto, che riconosca i gradi de' miei Ufficiali. Io mi adoprerò ad eliminare coloro che debbono essere eliminati.
Della M. V. ubbidientissimo
G. Garibaldi"
Il 9 ottobre Vittorio Emanuele da Ancona lanciava ai popoli dell'Italia Meridionale il seguente manifesto:
Ai popoli dell'Italia Meridionale,
"In un momento solenne della storia nazionale e dei destini italiani, rivolgo la mia parola a voi, popoli dell'Italia meridionale, che mutato[130] lo Stato nel nome mio, mi avete mandato oratori d'ogni ordine di cittadini, magistrati e deputati de' municipii, chiedendo di essere restituiti nell'ordine, confortati di libertà ed uniti al mio Regno.
"Io voglio dirvi quale pensiero mi guidi, e quale sia in me la coscienza dei doveri che deve adempiere chi dalla Provvidenza fu posto sopra un trono italiano.
"Io salii al trono dopo una grande sventura nazionale. Mio padre mi diede un alto esempio, rinunziando la corona per salvare la propria dignità, e la libertà de' suoi popoli. Carlo Alberto cadde coll'armi in pugno, morì nell'esiglio; la sua morte accomunò sempre più le sorti della mia famiglia a quelle del popolo italiano, che da tanti secoli ha dato a tutte le terre straniere le ossa de' suoi esuli, volendo rivendicare il retaggio di ogni gente, che Dio ha posta fra gli stessi confini, e stretta insieme col simbolo di una sola favella.
"Io mi educai a quell'esempio e la memoria di mio padre fu la mia stella tutelare.
"Fra la corona e la parola data, non poteva per me essere dubbia la scelta, mai.[131]
"Riaffermai la libertà in tempi poco propizii a libertà, e volli che, esplicandosi, essa gittasse radici nel costume dei popoli, non potendo io avere a sospetto ciò che a' miei popoli era caro. Nella libertà del Piemonte fu religiosamente rispettata la eredità, che l'animo presago del mio Augusto Genitore, aveva lasciato a tutti gli Italiani.
"Colle franchigie rappresentative, colla popolare istruzione, colle grandi opere pubbliche, colla libertà dell'industria e dei traffici, cercai di accrescere il benessere del mio popolo: e volendo rispettata la religione cattolica, ma libero ognuno nel santuario della propria coscienza, e ferma la civile autorità, resistetti apertamente a quella ostinata e procacciante fazione, che si vanta la sola amica e tutrice de' troni, ma che intende a comandare in nome del Re, ed a frapporre tra il Principe e il popolo la barriera delle sue intolleranti passioni.
"Questi modi di governo non potevano essere senza effetto per la rimanente Italia. La concordia del Principe col popolo nel proponimento dell'indipendenza nazionale e della libertà civile e politica, la tribuna e la stampa[132] libere, l'esercito che aveva salvata la tradizione militare italiana sotto la bandiera tricolore, fecero del Piemonte il vessillo e il braccio d'Italia. La forza del mio principato non derivò dalle arti di una occulta politica, ma dallo aperto influsso delle idee e della pubblica opinione.
"Così potei mantenere nella parte di popolo italiano riunito sotto il mio scettro, il concetto di una egemonia nazionale, onde nascer doveva la concorde armonia delle divise provincie di una sola nazione.
"L'Italia fu fatta capace del mio pensiero, quando vide mandare i miei soldati sui campi della Crimea accanto ai soldati delle due grandi potenze occidentali. Io volli far entrare il diritto d'Italia nella realtà dei fatti e degli interessi europei.
"Al congresso di Parigi i miei legati poterono parlare per la prima volta all'Europa dei vostri dolori. E fu a tutti manifesto, come la preponderanza dell'Austria in Italia fosse infesta all'equilibrio Europeo, e quanti pericoli corressero la indipendenza e la libertà del Piemonte, se la rimanente penisola non fosse francata dagl'influssi stranieri.[133]
Il mio magnanimo alleato, l'Imperatore Napoleone III, sentì che la causa italiana era degna della grande nazione sulla quale impera. I nuovi destini della nostra patria furono inaugurati da una giusta guerra. I soldati italiani combatterono degnamente accanto alle invitte legioni della Francia. I volontari accorsi da tutte le provincie e da tutte le famiglie italiane sotto la bandiera della Croce Sabauda addimostrarono, come tutta l'Italia m'avesse investito del diritto di parlare e di combattere in nome suo.
"La ragione di stato pose fine alla guerra, ma non a' suoi effetti, i quali si andarono esplicando per la inflessibile logica degli avvenimenti e dei popoli.
"Se io avessi avuta quell'ambizione che è imputata alla mia famiglia da chi non si fa addentro nella ragione dei tempi, io avrei potuto essere soddisfatto dell'acquisto della Lombardia. Ma io aveva speso il sangue prezioso dei miei soldati non per me, per l'Italia.
"Io aveva chiamati gl'italiani alle armi; alcune provincie avevano subitamente mutato gli ordini interni per concorrere alla guerra d'indipendenza, dalla quale i loro Principi aborrivano.[134] Dopo la pace di Villafranca, quelle provincie dimandarono la mia protezione contro il minacciato restauro degli antichi Governi. Se i fatti dell'Italia centrale erano la conseguenza della guerra alla quale noi avevamo invitati i popoli, se il sistema delle intervenzioni straniere doveva essere per sempre bandito dall'Italia, io doveva conoscere e difendere in quei popoli il diritto di legalmente e liberamente manifestare i voti loro.
"Ritirai il mio Governo; essi fecero un Governo ordinato: ritirai le mie truppe; essi ordinarono forze regolari, ed a gara di concordia e di civile virtù vennero in tanta riputazione e forza, che solo per violenza d'armi straniere avrebbero potuto esser vinti.
"Grazie al senno dei popoli dell'Italia Centrale, l'idea monarchica fu in modo costante affermata, e la Monarchia moderò moralmente quel pacifico moto popolare. Così l'Italia crebbe nella estimazione delle genti civili, e fu manifesto all'Europa come gl'italiani siano acconci a governare sè stessi.
"Accettando la annessione io sapeva a quali difficoltà europee andassi incontro. Ma io non potevo mancare. Chi in Europa mi taccia d'imprudenza,[135] giudichi con animo riposato, che cosa sarebbe diventata, che cosa diventerebbe l'Italia, il giorno nel quale la Monarchia apparisse impotente a soddisfare il bisogno della costituzione nazionale!
"Per le annessioni, il moto nazionale se non mutò nella sostanza, pigliò forme nuove; accettando dal diritto popolare quelle belle e nobili provincie, io doveva lealmente riconoscere l'applicazione di quel principio, nè mi era lecito di misurarlo colla norma dei miei affetti ed interessi particolari. In suffragio di quel principio, io feci per utilità dell'Italia, il sacrificio che più costava al mio cuore, rinunziando a due nobilissime provincie del Regno avito.
"Ai Principi italiani che han voluto essere miei nemici, ho sempre dati schietti consigli, risoluto, se vani fossero, ad incontrare il pericolo che l'accecamento loro avrebbe fatto correre ai troni, e ad accettare la volontà dell'Italia.
"Al Granduca io aveva indarno offerta la alleanza prima della guerra. Al Sommo Pontefice, nel quale venero il Capo della Religione dei miei avi e dei miei popoli, fatta la pace, indarno scrissi offerendo di assumere il Vicariato per l'Umbria e per le Marche.[136]
"Era manifesto che queste provincie contenute soltanto dalle armi di mercenari stranieri, se non ottenessero la guarentigia di governo civile che io proponeva, sarebbero tosto o tardi venute in termine di rivoluzione.
"Non ricorderò i consigli dati per molti anni dalle potenze al Re Ferdinando di Napoli. I giudizii che nel Congresso di Parigi furono proferiti sul suo Governo, preparavano naturalmente i popoli a mutarlo, se vane fossero le querele della pubblica opinione e le pratiche della diplomazia.
"Al giovane Suo Successore io mandai offerendo alleanza per la guerra dell'indipendenza. Là pure trovai chiusi gli animi ad ogni affetto italiano e gli intelletti abbuiati dalla passione.
"Era cosa naturale, che i fatti succeduti nell'Italia settentrionale e Centrale, sollevassero più e più gli animi nella Meridionale.
"In Sicilia questa inclinazione degli animi ruppe in aperta rivolta. Si combatteva per la libertà in Sicilia, quando un prode guerriero devoto all'Italia ed a Me, il generale Garibaldi, salpava in suo aiuto. Erano italiani che soccorrevano italiani; io non potevo, non dovevo rattenerli![137]
"La caduta del Governo di Napoli riaffermò quello che il mio cuore sapeva, cioè quanto sia necessario ai Re l'amore, ai Governi la stima dei popoli!
"Nelle due Sicilie il nuovo reggimento si inaugurò col mio nome. Ma alcuni atti diedero a temere che non bene si interpretasse, per ogni rispetto, quella politica che è dal mio nome rappresentata. Tutta l'Italia ha temuto, che all'ombra di una gloriosa popolarità e di una probità antica, tentasse di riannodarsi una fazione pronta a sacrificare il vicino trionfo nazionale, alle chimere del suo ambizioso fanatismo.
"Tutti gl'italiani si sono rivolti a me perchè scongiurassi questo pericolo. Era mio obbligo il farlo perchè nell'attuale condizione di cose non sarebbe moderazione, non sarebbe senno, ma fiacchezza ed imprudenza, il non assumere con mano ferma la direzione del moto nazionale, del quale sono responsabile dinanzi all'Europa.
"Ho fatto entrare i miei soldati nelle Marche e nell'Umbria, disperdendo quella accozzaglia di gente di ogni paese e di ogni lingua, che qui si era raccolta, nuova e strana forma d'intervento straniero e la peggiore di tutte.[138]
"Io ho proclamato l'Italia degli italiani, e non permetterò mai che l'Italia diventi il nido di sette cosmopolite, che vi si raccolgano a tramare i disegni o della reazione o della demagogia universale.
Popoli dell'Italia Meridionale!
"Le mie truppe si avanzano fra voi per raffermare l'ordine. Io non vengo ad imporvi la mia volontà, ma a far rispettare la vostra.
"Voi potrete liberamente manifestarla: la Provvidenza, che protegge le cause giuste, ispirerà il voto che deporrete nell'urna.
"Qualunque sia la gravità degli eventi, io attendo tranquillo il giudizio dell'Europa civile e quello della Storia, perchè ho la coscienza di compiere i miei doveri di Re e di italiano!
"In Europa la mia politica non sarà forse inutile a riconciliare il progresso dei popoli colla stabilità delle monarchie.
"In Italia so che io chiudo l'era delle rivoluzioni.
"Dato da Ancona addì nove ottobre milleottocentosessanta.
"VITTORIO EMANUELE
"Farini".
Il giorno 15 ottobre il generale Garibaldi pubblicava questo manifesto:
"Per adempiere ad un voto indisputabilmente caro alla Nazione intera, determino:
"Che le Due Sicilie, che al sangue italiano devono il loro riscatto e che mi elessero liberamente Dittatore, fanno parte integrante dell'Italia una ed indivisibile, con suo Re costituzionale Vittorio Emanuele e i suoi discendenti.
"Io deporrò nelle mani del Re, al suo arrivo, la dittatura conferitami dalla Nazione.
"I prodittatori sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
"G. Garibaldi".
Il 21 il plebiscito era votato con la formula:
"Il popolo vuole l'Italia una e indivisibile sotto lo scettro di Casa Savoia".
E nel giorno stesso Garibaldi emanava il seguente
Ordine del giorno:
"Il prode generale Cialdini ha vinto presso Isernia. I borbonici sbaragliati hanno lasciato ottocentottanta prigionieri, cinquanta ufficiali, bandiere e cannoni.[140]
"Ben presto i valorosi dell'esercito settentrionale porgeranno la mano ai coraggiosi soldati di Calatafimi e del Volturno.
"G. Garibaldi".
Garibaldi aveva finita la sua impresa colla quale aveva collegata all'Italia settentrionale l'Italia meridionale. Arrivata al Volturno la divisione Della Rocca, serrò Capua di regolare assedio.
Il 31 di ottobre il generale consegnava solennemente alla legione ungherese la bella bandiera ricamata dalle Signore napoletane; il 4 il Generale faceva la solenne distribuzione della medaglia, che il Municipio di Palermo aveva decretato ai Mille. Il giorno 6 passava in rassegna il glorioso esercito, che aveva combattuto sì strenuamente per l'Italia e Vittorio Emanuele.
Il giorno 7 il Re Vittorio Emanuele faceva il solenne ingresso a Napoli, fra un entusiasmo indescrivibile ed una pioggia di fiori. Nella carrozza davagli la destra il generale Garibaldi: di fronte sedevano i due prodittatori Mordini e Pallavicino.
Il giorno 8 il Generale consegnava al Re il plebiscito delle Due Sicilie, e prendeva da lui[141] congedo, dopo di avergli raccomandato i suoi valorosi compagni d'armi; indi faceva pubblicare il seguente ordine del giorno, per accomiatarsi dai suoi compagni:
Ai miei Compagni d'armi,
"Penultima tappa del risorgimento nostro, noi dobbiamo considerare il periodo che sta per finire, e prepararci ad attuare splendidamente lo stupendo concetto degli eletti di venti generazioni, il cui compimento assegnò la provvidenza a questa generazione fortunata.
"Sì giovani! l'Italia deve a Voi un'impresa che meritò il plauso del mondo.
"Voi vinceste—e vincerete—perchè siete ormai istruiti nella tattica che decide delle battaglie!
"Voi non siete degeneri di coloro che entravano nel fitto profondo delle falangi Macedoniche e squarciavano il petto ai superbi vincitori dell'Asia.
"A questa pagina stupenda della Storia del nostro paese, ne seguirà una più gloriosa ancora, e lo schiavo mostrerà finalmente al libero fratello un ferro arruotato che appartenne agli anelli delle sue catene.[142]
"All'armi tutti! tutti, e gli oppressori, i prepotenti sfumeranno come la polvere.
"Voi, donne, rigettate lontani i codardi, essi non vi daranno che codardi.
"Che i paurosi dottrinari se ne vadano a trascinare altrove il loro servilismo, le loro miserie.
"Questo popolo è padrone di sè. Egli vuole essere fratello degli altri popoli, ma guardare i protervi con la fronte alta; non rampicarsi mendicando la sua libertà; egli non vuole essere a rimorchio di uomini a cuore di fango, no! no! no!
"La provvidenza fece dono all'Italia di Vittorio Emanuele. Ogni cuore italiano deve rannodarsi a Lui, serrarsi intorno a Lui. Accanto al Re Galantuomo ogni gara deve sparire, ogni rancore dissiparsi!
"Anche una volta io vi ripeto il mio grido—all'armi tutti! tutti!—Se marzo del 1861 non trova un milione d'italiani armati, povera libertà, povera vita italiana! Oh! no: lungi da me un pensiero che mi ripugna, come un veleno. Il marzo del 1861, e se fa bisogno, il febbraio, ci troverà tutti al nostro posto.
"Italiani di Calatafimi, di Palermo, del Volturno,[143] di Ancona, di Castelfidardo, d'Isernia, e con noi ogni uomo di questa terra non codardo non servile; tutti, tutti serrati intorno al glorioso soldato di Palestro, daranno l'ultimo colpo alle crollanti tirannide!
"Accogliete giovani volontari, resto onorato di dieci battaglie, una parola d'addio! Io ve la mando commosso d'affetto dal profondo della mia anima. Oggi io devo ritirarmi, ma per pochi giorni. L'ora della pugna mi troverà con voi ancora accanto ai soldati della libertà italiana.
"Che ritornino alle loro case quelli soltanto chiamati da doveri imperiosi di famiglia, e coloro che gloriosamente mutilati, hanno meritato la gratitudine della patria. Essi la serviranno nei loro focolari coi consigli e coll'aspetto delle nobili cicatrici che decorano la maschia figura di vent'anni. All'infuori di questi, gli altri restino a custodire le gloriose bandiere.
"Noi ci ritroveremo fra poco, per marciare insieme al riscatto dei nostri fratelli schiavi ancora dello straniero. Noi ci troveremo fra poco per marciare insieme a nuovi trionfi della libertà.
G. Garibaldi.
[144]Il giorno del suo ingresso in Napoli il Re Vittorio Emanuele indirizzava ai popoli dell'Italia Meridionale il seguente proclama:
17 novembre 1860.
Ai popoli Napoletani e Siciliani
"Il suffragio universale mi dà la sovrana potestà di queste nobili Provincie. Accetto quest'altro decreto della volontà Nazionale, non per ambizione di Regno, ma per coscienza d'italiano. Crescono i miei, crescono i doveri di tutti gli italiani. Sono più che mai necessarie la sincera concordia e la costante abnegazione. Tutti i partiti debbono inchinarsi devoti dinanzi alla maestà dell'Italia che Dio solleva.
"Noi dobbiamo instaurare un governo che dia guarentigia di viver libero ai popoli e di severa probità alla pubblica opinione. Io faccio assegnamento sul concorso efficace di tutta la gente onesta.
"Dove nella legge ha freno il potere e presidio la libertà, ivi il Governo tanto può pel pubblico bene, quanto il popolo vale per la virtù.
"All'Europa dobbiamo addimostrare che, se la irresistibile forza degli eventi superò convenzioni[145] fondate sulle secolari sventure d'Italia, noi sappiamo ristorare nella Nazione Unita l'impero di quegli immutabili dommi, senza dei quali ogni società è inferma, ogni autorità combattuta ed incerta".
Vittorio Emanuele.
Il 3 novembre, il generale Della Rocca d'ordine del Re scriveva una lusinghiera lettera a Garibaldi con la quale ammirava i prodigi di valore e i sagrifizi dell'Esercito Meridionale, ed esprimeva la riconoscenza che la patria italiana deve al loro eroismo.
Garibaldi a sua volta scrisse un'affettuosa lettera di commiato al Re, la quale si chiudeva con queste parole:
"Vogliate Maestà, permettermi una sola preghiera nell'atto di rimettervi il supremo potere. Io Vi imploro affinchè mettiate sotto l'altissima Vostra tutela, coloro che mi ebbi a collaboratori in questa grand'opera di affrancamento dell'Italia Meridionale, e che accogliate nel Vostro Esercito i miei commilitoni che han ben meritato della patria e di Voi".[146]
Il giorno 8 di novembre il Generale volle vedere Elia, al quale fece invito di andare con lui a Caprera. "Sarete fratello a Menotti" gli disse stringendogli la mano. L'Elia commosso ringraziò il generale a cui fece capire che egli aveva altri sacri doveri da compiere verso la madre vedova e verso le sue quattro sorelle orfane; e prese congedo con dolore da quel grande che in meno di sei mesi aveva assicurata l'unità italiana, unendo sotto lo scettro di Vittorio Emanuele l'Italia Meridionale, con quasi otto milioni di sudditi devoti.
La mattina del 9 Garibaldi s'imbarcava per Caprera.
Fu grande fortuna d'Italia la rivoluzione siciliana del 4 aprile 1860.
Questa provocò la spedizione dei Mille. Se questa spedizione non veniva in tempo—come è provato dalle rivelazioni di Brassier de Saint-Simon—l'Italia si sarebbe sistemata in base ai risultati della guerra del 1859—e secondo[147] il volere di Napoleone non si sarebbe avuta l'unità ma la federazione, ed il Papa ne sarebbe stato il Capo e tutt'ora Re di Roma!
La spedizione dei Mille ha avuto un'importanza massima, più di qualsiasi altro evento della Storia d'Italia.
La mattina del 28 ottobre ambo gli eserciti settentrionali e meridionali erano intorno a Capua. Una conferenza tra Garibaldi ed i generali Menabrea e Della Rocca aveva già determinato il piano di espugnazione della fortezza, per l'esecuzione del quale il generale Menabrea diede i suoi ordini agli ufficiali del genio e prendeva tutte le misure per una pronta espugnazione della piazza, mentre il generale Della Rocca dava le sue disposizioni all'artiglieria ed agli altri corpi, per effetto delle quali, le truppe piemontesi rinforzavano il posto di Caiazzo abbandonato dai borbonici, di S. Maria e di S. Angelo; il genio e l'artiglieria si distribuivano nelle rispettive posizioni intorno alla fortezza e tutto era ordinato per il bombardamento.[148]
Più di ventimila borbonici si erano trincerati con potenti artiglierie a Mola di Gaeta. Il 4 di novembre vennero destinati a conquistare quella posizione, la brigata granatieri di Sardegna, il 14o e 24o bersaglieri, due squadroni di lancieri di Novara e due batterie d'artiglieria.
Mola, è la parte più a mare della cittadella di Formia, ed è addossata ad una linea di colline che scendono sul mare lasciando appena posto per la strada.
Il 24o battaglione bersaglieri si andò a stendere su un'altura a cavallo della strada; a destra, sulle prime alture, si stendeva il 1o reggimento granatieri; il 2o reggimento granatieri si collocava più indietro; il 3o in riserva; il 14o battaglione dei bersaglieri venne mandato a sloggiare i borbonici che occupavano il paese di Maranola, situato in altura sopra Mola.
Alle ore 11 s'incominciò l'assalto con fuoco vivissimo da ambo le parti; un battaglione del 1o granatieri è mandato in sostegno del 14o bersaglieri e con vigoroso attacco scacciano i borbonici da Maranola.
Il battaglione granatieri dopo di avere cacciato i borbonici da Maranola, rinforzato da altro[149] battaglione del 2o granatieri si scaglia arditamente contro l'alta posizione chiamata Madonna di Ponza fortemente occupata e difesa da due batterie; i nostri con slancio ammirabile vi sono sopra, fugano il nemico e s'impossessano dei cannoni.
Eseguite queste due brillanti operazioni, tutta la linea dei nostri si slancia risolutamente all'attacco di Mola sotto il fuoco assai ben nutrito del nemico, attraverso un terreno difficile, seminato da siepi, da muri e da fossi; marciano in testa la 3a e la 4a compagnia del 2o granatieri che primi scavalcano le barricate e penetrano nel paese, mettendo in fuga il nemico che lascia in potere dei nostri undici cannoni. Non restava che di espugnare la posizione del Castellone fortemente tenuta dai borbonici; i granatieri e bersaglieri esaltati dalle riportate vittorie, si lanciano valorosamente all'assalto e, superati tutti gli ostacoli ed ogni resistenza, riescono vittoriosi e l'espugnano.
Ricoverati entro le mura di Gaeta, i Borboni di Napoli si sforzavano di tener ancora testa alle forze vigorose dell'unificazione d'Italia, con[150] una guarnigione di oltre 15 000 combattenti e con ben 528 bocche da fuoco.
Nella notte del 10 novembre 1860, otto pezzi da campagna aprivano il fuoco con tiri in arcata, producendo grande sgomento negli assediati; nella notte successiva il fuoco fu ripreso. Il giorno 12 il generale Cialdini, comandante delle due divisioni 4a e 7a, che aveva occupato tutte le alture dominanti la città e spinti i suoi avamposti più presso il Borgo di Gaeta—oggi Tlena—decise di ricacciare entro la cinta quella parte di truppe borboniche che aveva stabiliti i suoi bivacchi sull'istmo fino all'attrattina: le fa assalire da buon nerbo di bersaglieri che colla punta della baionetta l'obbliga ad abbandonare ogni esterna posizione.
Alla fine di dicembre tutte le batterie erano piazzate e l'8 di gennaio Cialdini ordinava si aprisse il fuoco. Mentre seguiva il bombardamento la diplomazia non mancava d'agitarsi. Napoleone III s'interponeva fra i belligeranti e riusciva a fissare un armistizio che aveva principio la stessa sera dell'8 gennaio per terminare il 19.
Dal 19 al 21 furono fatte pratiche per la[151] resa, ma avendo il Borbone rifiutato, alle ore 8 1/2 ant. del giorno 22 tutte le batterie assedianti entrarono in azione. Il bombardamento durò fino al 12 febbraio, producendo danni non lievi alla città e provocando esplosioni di magazzini di polvere. Infine il giorno 13 verso le 3 pomeridiane un orribile esplosione succedeva nelle batterie Malpasso e Transilvania, essendovisi appiccato il fuoco all'enorme quantità di 26 mila chilogrammi di polvere. Lo spavento in Gaeta fu così grande che rese necessario risolversi alla capitolazione, la quale fu firmata alle ore 5 pomeridiane.
Francesco II non s'intromise nella capitolazione e prima che l'esercito italiano entrasse a Gaeta s'imbarcava sul vapore francese "La Muette" che lo condusse a Civitavecchia.
Molti dei nostri valorosi ufficiali si distinsero nei combattimenti di Mola e nell'assedio di Gaeta e fra questi il prode capitano di San Marzano che veniva decorato della Croce militare di Savoia e promosso.
A Caprera il generale non rimaneva inoperoso; egli aveva l'anima fissa al riscatto di Roma[152] e di Venezia ed invitava gli amici a preparare i mezzi occorrenti. Con questi concetti scriveva al Bellazzi alla fine di dicembre 1860.
Caprera, 29 dicembre 1860.
Caro Bellazzi,
"Io desidero l'apertura concorde di tutti i comitati italiani di provvedimento per coadiuvare al gran riscatto. Così Vittorio Emanuele con un milione d'italiani armati questa primavera, chiederà giustamente ciò che manca all'Italia.
"Nella sacra via che si segue, io desidero che scomparisca ogni indizio di partiti; i nostri antagonisti sono un partito, essi vogliono l'Italia fatta da loro col concorso dello straniero e senza di noi.
"Noi siamo la Nazione, non vogliamo altro capo che Vittorio Emanuele; non escludiamo nessun italiano, che voglia francamente come noi; dunque sopra ogni cosa si predichi energicamente la concordia di cui abbisogniamo immensamente.
Vostro
G. Garibaldi".
Dopo aver preso parte ad una seduta tempestosa alla Camera dei Deputati, Garibaldi era tornato a Caprera, quando il 6 giugno si sparse la fulminea notizia che Cavour era morto. L'impressione fu enorme; l'Italia perdeva il suo più grande uomo di Stato, la libertà un devoto amico, la Dinastia di Savoia uno dei suoi più validi sostegni.
Il Ministro Ricasoli, succeduto al Conte di Cavour, volle accontentare il generale Garibaldi coll'istituzione dei Tiri a Segno Nazionali, ma dopo pochi giorni il Barone Ricasoli non era più al Governo; il partito moderato voleva che si fosse proceduto allo scioglimento dei Comitati di Provvedimento, ma egli in nome della libertà di associazione, rifiutò e diede le dimissioni. Gli successe Rattazzi, che, conseguente al disegno del Ricasoli, commise al generale la direzione dei Tiri a bersaglio.
All'Elia che ne voleva istituire uno in Ancona il generale così scriveva:[154]
Caprera, 18 gennaio 1862.
Caro Elia,
"Italia e Vittorio Emanuele è il programma consentaneo ai voti della nazione e fu di guida a tutti i Comitati di Provvedimento.
"Oltre ai servizi che hanno già resi alla patria, amministrati che siano da persone intelligenti ed oneste, potrebbero renderne altri importanti in avvenire, raccogliendo i fondi pel riscatto di Roma e Venezia.
"Qualunque altro Comitato che sorga con programma e fini diversi non potrebbe reggersi, perchè la Nazione lo riproverebbe.
"Accetto adunque con piacere l'offerta vostra di erigere in cotesta importante città un Comitato di Provvedimento. Intendetevi a tal fine con persone oneste e patriottiche e mettevi in relazione col sig. Federico Bellazzi, persona di mia confidenza, il quale ha diretto devotamente il Comitato Centrale di Genova, ma che si è ritirato, non accettando la presidenza di quel nuovo comitato.
"Gradite i sensi di stima e d'affetto dal
vostro
G. Garibaldi".
[155]Nei primi giorni di maggio 1862, quando già da qualche tempo il generale era in giro nella Lombardia per l'impianto dei tiri a bersaglio, incominciarono a manifestarsi i sintomi di un tentativo per la liberazione di Venezia; il tentativo di Sarnico, che venne impedito dal governo.
Disgustato da questo avvenimento, il generale erasi di nuovo ritirato a Caprera, quando amici della Sicilia lo invitarono ad andare a visitare le terre da lui liberate. La notte del 7 luglio coi pochi amici, che si trovavano all'Isola, prese imbarco per la Sicilia. A Palermo fu accolto con delirio. Chiamato nei luoghi dell'epopea del 1860, Alcamo, Partinico, Calatafimi, Corleone, Sciacca ed altre città, si spinse fino a Marsala. Dovunque passava dimostrava la necessità di riprendere le armi per la liberazione di Roma, essendo un'onta per la Nazione, che la sua Capitale rimanesse schiava del Papa. E fu allora che ebbe principio il grido di Roma o morte!, grido che condusse al doloroso fatto di Aspromonte ed alla gloriosa disfatta di Mentana.[156]
Ad Aspromonte, il generale veniva ferito al piede da palla italiana; il fatto suscitò profonda commozione non solo in ogni angolo d'Italia, ma in quante contrade era giunto il nome dell'Eroe condottiero e l'eco delle sue vittorie. I volontari accorsi intorno a lui, venivano dispersi ed egli stesso veniva portato in prigione nel forte del Varignano. Ecco come si svolsero i dolorosi fatti:
Il Governo, istigato dall'imperatore dei Francesi, aveva determinato di arrestare Garibaldi sulla via di Roma, incaricando il generale Cialdini di anche combatterlo, qualora fosse necessario, e ad ogni costo arrestarlo disperdendo i suoi seguaci.
Il general Mella, comandante della brigata Piemonte mandato in Sicilia sotto gli ordine del Cialdini, sapendo che diversi ufficiali suoi dipendenti erano stati compagni a Garibaldi nelle guerre combattute per l'indipendenza, considerando che questi mal si sarebbero trovati se condotti a combattere contro Garibaldi ed i loro[157] antichi compagni, riuniva gli ufficiali superiori e, intesosi con questi, chiamava a rapporto gli ufficiali subalterni, e faceva loro intendere, che quelli che non si sentissero di combattere contro Garibaldi, potevano chiedere le dimissioni, giacchè l'ufficiale non essendo legato come il soldato, era libero di dimettersi; rammentava ad essi che da ufficiali d'onore avevano l'obbligo di francamente dichiararsi; accordava per ciò mezz'ora di tempo per decidersi.
Gli ufficiali che erano stati compagni a Garibaldi, senza calcolare fin dove poteva arrivare la competenza dei loro superiori, piuttosto che combattere contro Garibaldi, il che avrebbero pur fatto anche a malincuore pur di compiere il loro dovere, in numero di trentadue rassegnarono le loro dimissioni, mai immaginando che ciò facendo il loro onore potesse rimanere intaccato. Le dimissioni furono da ognuno così formulate:
"A termini delle parole del Comandante del Reggimento e del generale, al rapporto del quale gli ufficiali furono chiamati, il sottoscritto domanda le dimissioni".
Gli ufficiali dimissionari in seguito alle dichiarazioni del generale Mella e degli ufficiali superiori[158] del 3o e 4o reggimento, Brigata Piemonte, furono i seguenti:
Capitani: Bennici Giuseppe, Buttinoni Francesco, Burruso Giuseppe, Alessi Antonio, Bonafini Francesco, Pastori Enrico, Bonetti Pietro.—Luogotenenti: Tosti Paolo, Maggioni Ulrico, Bonighi Arnoldo, Armanni Ernesto, Amadesi Alfonso, Bresciani Giuseppe, Nizzori Antonio, Plebani Luigi.—Sottotenenti: Quercioli Egisto, Zanoncelli Michelangelo, Sassi Francesco, Cucchiarelli Levino, Archieri Federico, Lucianetti Lodovico, Rosignoli Francesco, Bergalli Nicolò, Bertone Luigi, Orsoni Emilio, Conti Carlo, Pollina Pietro, Sparacio Giuseppe, Aceto Emidio, Fioravanti Valentino, Sulli Giovanni, Belluzzi Raffaele, De Carli Carlo.
Di questi dimissionari, uno che maggiormente s'era nella campagna precedente distinto, e che corse serio pericolo di essere due volte fucilato fu un carissimo amico di Bixio, un valorosissimo ufficiale e caldo patriota, Giuseppe Bennici; preso con l'armi in pugno dai borbonici alli 21 di maggio 1860 sui Monti di Monreale, come capo squadra dell'insurrezione siciliana, il giorno 27 doveva essere tradotto sul banco dei rei colpevoli di fellonia e di ribellione[159] al Re di Napoli. La condanna a morte era sicura; ma la fortuna volgeva uno sguardo pietoso sulla patria e sul bravo giovane di Piana de' Greci.
All'alba del 27 Garibaldi entrava in Palermo, la sentenza restava sospesa e dopo tre giorni era reso libero cittadino in libera terra. Da quel giorno Giuseppe Bennici giurava affetto eterno e fede costante al liberatore Giuseppe Garibaldi; Bixio lo vide, lo volle con sè e ne fece il suo aiutante.
Dopo quasi due anni nell'agosto del 1862 in Adernò gli veniva ordinato di battersi contro Garibaldi che con la medesima bandiera dei plebisciti marciava alla liberazione di Roma, o, se meglio gli fosse piaciuto, rassegnasse le sue dimissioni. Il giovane non aveva di ricchezza che la sua sciabola, e tutto il suo avvenire era basato nell'intrapresa carriera militare; ma per lui la riconoscenza verso il suo liberatore s'imponeva, e depose le spalline. Incontrato Garibaldi a Catania, si univa a lui ed ai suoi vecchi compagni di Calatafimi e del Volturno. Ad Aspromonte venne fatto prigioniero; trasportato alla Sede del comando del generale Pallavicini, gli si partecipava che sarebbe stato fucilato. Alla mezzanotte,[160] data la muta alla guardia, il capo scorta gli ordinava di seguirlo; gli si fece percorrere tutta la linea degli avamposti e lo si accompagnava al posto, ove doveva essere fucilato, quando sopraggiunse un ufficiale latore di un contr'ordine.
L'indomani sotto buona scorta fu mandato a Scilla, il 31 a Reggio ed il 1 settembre fu trasportato a Messina e rinchiuso nel forte Gonzaga. Il 9 di ottobre era condotto innanzi al tribunale militare, dal quale veniva emanata la seguente sentenza:
NELLA CAUSA
contro
"Bennici Giuseppe, del fu Gerlando d'anni 21, nato a Piana de' Greci, celibe, Luogotenente nella 8a Compagnia del 4o Reggimento Fanteria.
detenuto e accusato
"di tradimento, per aver portato le armi contro lo Stato, prestando servizio nelle file del generale Garibaldi, arrestato il giorno 29 agosto p.p. ecc.
"Condanna alla pena di morte previa degradazione ecc."
Ma anche questa volta un altro angelo salvatore vegliava sulle sorti del Bennici; il generale[161] Pinelli si adoperò con ogni sua possa per ottenergli, se non la grazia, la commutazione della pena, e così il 26 di ottobre S. M. il Re firmava il decreto col quale si commutava la pena di morte in quella dell'ergastolo.
La madre del Bennici, angosciata per la sorte del figlio, si rivolse con calde preghiere al generale Garibaldi, e ne riceveva questa confortante lettera.
Pisa, 11 novembre 1862.
Signora,
"Mi commuove il modo eroico col quale sopportate la vostra sventura. Vostro figlio sarà libero e presto; io appena potrò farlo, m'incaricherò di lui.
"Le catene di vostro figlio sono gloria per lui.
"Credetemi
G. Garibaldi.
Fu un conforto per Bennici e per gli altri ufficiali compromessi pel fatto di Aspromonte udire come patrioti, quali il Mordini, il Crispi, il Cadolini, il Macchi, ed altri perorarono la loro causa in Parlamento, e fu gioia e speranza per essi il sapere che nobili Signore, come Donna Pallavicino Trivulzio, Laura Mancini, Laura Mantegazza[162] ed altre, facevano coprire da molte migliaia di firme una petizione al Sovrano per la loro liberazione.
Finalmente il 14 marzo 1865 si aprivano le porte del Castello di Vinadio, ed il Bennici ed altri compagni che vi erano stati tradotti, venivano posti in libertà.
Primo pensiero dei liberati fu quello di dirigersi al camposanto e formato circolo sul luogo che racchiudeva le ossa di alcuni loro compagni di sventura, il più anziano tra i graduati, dinnanzi alle autorità civili e militari, pronunziava un discorso funebre, che concludeva con queste commoventi e nobili parole.
"E lassù sono i nostri compagni d'armi caduti in Aspromonte, e lassù gli altri trapassati, sopraffatti dai dolori; e di lassù ci mirano le anime dei nostri undici compagni che lasciarono il loro misero corpo in questo tenebroso recinto, ed esultano nel ricevere questo tributo d'affetto; e lassù faranno voti, che ognora il nostro cammino sia quello dell'onore e della gloria.
"E noi, forti sotto l'usbergo della nostra pura coscienza, osiamo gridare arditamente a' quattro angoli d'Italia, che dall'Esercito che ha saputo[163] vincere a S. Martino, a Castelfidardo, a Calatafimi e sulle barricate di Palermo, non escono e non usciranno giammai traditori. Pronti a chinare il capo ad una espiazione militare, sdegnosamente protestiamo, contro qualunque accusa infamante, per chi col vessillo tricolore alla liberazione di Roma con Garibaldi, marciava. Si! per Roma solo andavamo; per Roma abbiamo sofferto, e per Roma questi undici nostri compagni sono morti! Quando nel tempio di Marsala il duce dei Mille giurava Roma o morte, non era per ribellarsi contro il principe eletto da liberi plebisciti.
"Garibaldi, facendosi interprete del bisogno supremo dell'Italia, intimava la crociata del 1862, solo ambizioso di offrire, come fece al Volturno della corona delle due Sicilie, Roma a Vittorio Emanuele, in Campidoglio...
"Si paralizzino i nostri sensi, e la vergogna ricopra le nostri fronti, se cesseremo di combattere, finchè il vessillo tricolore non isventoli sulla pina di S. Pietro".
Dopo Aspromonte e dopo sì avversa fortuna, i liberali, prima di ritornare alle loro case, vollero sulla cenere dei loro morti rinnovare il giuramento di Marsala, "Roma o morte".[164]
La palla del 29 agosto 1862, se abbattè il corpo del temuto capitano, fece percorrere alla idea sua animatrice per tal fatto, un cammino quale non avrebbe potuto sperare con la più splendida vittoria.
Aspromonte giovò alla questione romana in modo decisivo.
Nel 1862 il Governo Russo aveva ordinata la leva generale in tutto l'impero, ma per la Polonia si prescriveva, che fossero esenti dall'obbligo di leva i contadini ed i grandi proprietari rurali, per cui la legge colpiva soltanto gli abitanti delle città. Questo privilegio promosse una agitazione grandissima in tutta la Polonia, e quando il Governatore di Varsavia volle applicare la legge, il 18 gennaio 1863, il Comitato Nazionale di Varsavia bandì l'insurrezione e la lotta incominciò.
Il Generale era infermo a Caprera, e si doleva di non poter accorrere in aiuto dei Polacchi per pagare un debito di gratitudine verso un paese che tanti suoi figli aveva sacrificati per la causa della nostra libertà. Non potendo pagare di persona scriveva all'Europa: "Non abbandonate la Polonia".[165]
Ed in Italia recar soccorso alla Polonia era come un dovere. Il valoroso Nullo Francesco dei Mille, impaziente d'indugio e di martirio, partiva e, unitosi ai ribelli, trovava la morte sugli argini di Skutz.
In Genova si era costituito il Comitato Generale di soccorso ai Polacchi sotto il patronato di Garibaldi, e presieduto dal generale Clemente Corte.
Alla fine di maggio due emissari Polacchi sbarcavano a Caprera apportatori di un audacissimo progetto:
Sommuovere la Rumenia, coll'aiuto del Rossetti e del Bratiano, rovesciare il principe Couza; formare la base dell'insurrezione nel principato; penetrare nella Bessarabia e di là in Polonia, per dare mano forte alla rivoluzione.
In Ancona pure, fin dai primi del 1863 si era costituito un comitato di soccorso per la Polonia.
Il 16 marzo 1863 Elia riceveva la seguente lettera dal generale Clemente Corte, accompagnata da poche linee del generale Garibaldi.[166]
Genova, 16 marzo 1863.
Pregiatissimo Signore,
"Ho ricevuto il di lei foglio 15 corrente e m'affretto a risponderle, che sentii con molto piacere come la sottoscrizione per la Polonia sia stata iniziata e promossa in Ancona, da cittadini distinti pel loro patriottismo.
"È urgente che tale sottoscrizione sia spinta con la maggiore sollecitudine possibile, e che il denaro raccolto venga spedito al nostro Comitato di Genova. Confido quindi, che Ella e gli altri patrioti d'Ancona, faranno in modo di soddisfare a tale mia richiesta.
"Le accludo copia della lettera colla quale il generale Garibaldi autorizza il nostro Comitato a raccogliere e disporre dei fondi suddetti
"Aggradisca i miei più cordiali saluti e mi creda con distinta stima
Dev.mo suo
Clemente Corte."
Caprera, 1 marzo 1863.
Signori,
Vogliate pregare i Comitati italiani per la Polonia di mettersi in relazione con Voi, acciò[167] si possa disporre dei fondi raccolti in favore della rivoluzione.
Vostro
G. Garibaldi.
Al Comitato per la Polonia
Genova.
Il gennaio del 1864, Elia data la sua piena adesione al movimento insurrezionale della Polonia e deciso di prendervi parte, gli venne trasmesso dall'organizzatore generale del Governo Nazionale, il decreto qui trascritto col quale lo si creava organizzatore delle forze insurrezionali a favore della Polonia nell'Adriatico e lo si nominava provvisoriamente Capitano di Fregata.
Pour etre remplace |
 |
Donè o Gene 1864 Mars 15. |
En vertu des pouvoirs qui nos sont confères pour le Gouvernement National Polonais par un Decret du 10 fevrier 1864 daté de Varsavie, nous nommons au post d'Organizateur des forces Navales Polonais sur le mer Adriatique le Citoyen Auguste Elia sujet du Roy.me de l'Italie, natif d'Ancone, et lui conferons provisoirement[168] le grad de Capitaine de Fregate dans la Marine Nationale; il aurà a se conformer dans l'esercice de ses funtions a nos ordres et instruction ulterieurs.
F.to F. K.
Organizateur General.
Il 13 marzo Elia ricevette dal Cy John Robson di Londra la seguente lettera, con la quale l'avvisava dell'arrivo in Ancona di un vapore a lui diretto e gli dava commissione di vendere il carico e di fare del vapore quell'uso, che più gli fosse piaciuto, dandogli assicurazione, che il vapore medesimo era pienamente adatto pel servizio dei passeggeri nel mare Adriatico e per non lunghe navigazioni.
London, 1864 mars 13th
Dear Sir,
"Having been furnished with your address by my commercial friend. I avail myself of the opportunity, and beg of yon, to take in your charge my steamer the "Princess," Master Sainscler, destined to your port and charged with goods insended for speculation. Should yon accept this commission, I then will send you the power[169] for sale, or to dispose of her in manner yon would think proper. She is fit for transport, and passengers trade of short distance, and I think she will answer well in the Adriatic. She may be in your place towards the end of this month.
"The bearer of this letter, the Master of the steamer, will require your aid and your advice, which yon will kindly afford him and oblige.
"Your obedient servant
John Robson".
Nell'aprile, insistendo Elia che non aveva avuto altre notizie, perchè gli si facesse fare qualche cosa, riceveva la seguente lettera:
Torino, 22 aprile 1864.
Pregiatissimo Signore,
Ho ricevuto la vostra del 11 aprile. Aspettate e fate aspettare gentilmente, fino a che non riceverete notizie positive da Londra.
Spero che gli avvenimenti camminino e che con loro camminerà anche il nostro affare. Fra poco riceverete da parte mia la lettera patente commerciale, che ho ricevuto oggi e che manderò a voi col mezzo di una persona sicura. A tutti i miei saluti.[170]
Aggradite l'espressione della mia sincera amicizia e del mio distintissimo rispetto
Vostro dev.mo
S. S.
Ma passò del tempo. Il vapore annunziato non erasi veduto, nè arrivavano altre notizie, quando da persona sconosciuta gli venne portata la seguente lettera:
Torino, 30 giugno 1864.
Mio caro Elia,
"Se potete e volete consacrarvi ad una grande impresa, che vi allontanerà per qualche tempo dalla vostra famiglia, ma che può e deve essere base della nostra gloria e della grandezza avvenire, venite immediatamente a Torino e da Torino al Campo di S. Maurizio, dove debbo dirvi cosa e come. Non dite niente a nessuno. Il latore non sa nulla e non gli dite nulla.
"Se poi le vostre ferite non vi permettessero di viaggiare per mare e per terra rispondetemi non posso.
"Attendo con impazienza voi od una vostra riga. Tacete tutto e vogliate sempre bene al
Sempre Vostro
Nino Bixio"
È da immaginarsi con che premura Elia rispondesse all'appello del caro amico generale Bixio, che già presentiva essere d'accordo col Re Vittorio Emanuele e con Garibaldi per qualche ardita e gloriosa impresa. Non indugiò la partenza e raggiunse dopo due giorni, Bixio al Campo di S. Maurizio.
Montati a cavallo si recarono in una casina di proprietà di Accossato, dove Elia ebbe l'altissimo onore e la grande soddisfazione di stringere la mano che gli veniva stesa dal Padre della Patria, Re Vittorio Emanuele II, che ebbe parole assai benevoli per lui. Elia ricevette verbali ordini e disposizioni intorno ad una combinata operazione e ritornò in Ancona in attesa di essere chiamato.
Anche Mazzini cooperava con Vittorio Emanuele e spronava gli amici suoi a dare il loro appoggio per l'insurrezione in Gallizia, e nel trovare appoggio nei principati Balcanici, e sopratutto nel Montenegro, per un forte diversivo contro l'Austria, per poi marciare colle forze nazionali alla conquista del Veneto.
Intanto che tali trattative correvano, il generale Garibaldi, invitato dal popolo inglese a recarsi in Inghilterra, la mattina dell'11 aprile[172] vi faceva il suo ingresso, accolto da per tutto da una moltitudine fremente d'ammirazione e di amore.
Fra le feste che gli furono fatte merita di essere ricordata quella della prima autorità cittadina.
Il Lord Mayor di Londra salutava in lui in nome della libera Inghilterra:
"Il grande Apostolo della libertà; l'eroico e cavalleresco soldato che non impugnò mai la spada che per una giusta causa; il conquistatore di un regno per liberarlo dall'oppressione; colui che rimase povero per arricchire gli altri; il cittadino amante della sua patria e di tutta la razza umana, assai più della propria vita; l'uomo sinceramente buono e giusto di cui le private virtù sono superate soltanto dalle virtù pubbliche, dalla magnanimità più che spartana o romana".
Invitato ad un banchetto di amici polacchi ed italiani tra i quali Mazzini, Saffi e Mordini, al levare della mensa Mazzini si levò e propose un brindisi al generale Garibaldi con queste parole:
"Il mio brindisi racchiuderà tutto quanto[173] ci è caro, tutto quello per cui abbiamo sofferto, e combattuto. Bevo alla salute della libertà dei popoli, dell'uomo, che è la incarnazione vivente di queste grandi idee, di Giuseppe Garibaldi; della povera, sacra ed eroica Polonia i cui figli silenziosamente combattono e muoiono per la libertà da più di un anno; bevo alla salute di quella giovane Russia la cui divisa è terra e lavoro; della nuova Russia che fra non molto offrirà la mano alla Polonia sorella, riconoscendo la sua indipendenza e cancellando i ricordi dei russi degli Czar; alla salute dei russi che col nostro amico Herzen hanno fatto tanto per creare questa nuova Russia".
Garibaldi rispose:
"Sono per fare una dichiarazione che avrei dovuto fare già da gran tempo; vi è fra noi un uomo che ha reso i più grandi servigi al nostro paese ed alla causa della libertà.—Quando io ero giovinetto non avendo che aspirazioni verso il bene, cercai uno capace di servire di guida e di consiglio ai miei giovani anni, e lo trovai.—Egli solo vegliava, mentre tutti intorno a lui dormivano—Egli solo alimentò il fuoco sacro—Egli conservò sempre la sua[174] fede, l'amore sviscerato al suo paese e la devozione alla causa della libertà—Quest'uomo è il mio amico e Maestro Giuseppe Mazzini. Beviamo alla sua salute".
Il 5 maggio Garibaldi lasciava l'Inghilterra, ed il 9 l'"Ondine" Jakt del Duca di Sutherland lo sbarcava a Caprera.
Prima d'imbarcarsi per far ritorno alla sua Isola il generale così scrisse a Victor Ugo che avevagli espresso il desiderio di stringergli la mano qualora avesse potuto visitarlo nella partenza da Londra:
Mio caro Victor Ugo,
"Il visitarvi nel vostro esiglio era per me più che un desiderio; era un dovere: ma molte circostanze me lo impediscono. Spero mi capirete, chè lontano o vicino, non sono mai separato da Voi e dalla causa che rappresentate.
"Sempre vostro
"Londra, 22 aprile.
"G. Garibaldi".
Volle pure fosse pubblicata una lettera di commiato e di omaggio alla stampa inglese e così scriveva:[175]
"Nel lasciare l'Inghilterra non posso a meno di offrire un pubblico omaggio alla stampa inglese, e uno speciale tributo di gratitudine a tutti quei giornali che furono sinceri e fedeli organi della pubblica opinione verso di me, e benevoli interpreti dell'ammirazione e dei sentimenti che nutro per la nazione che mi diede ospitalità.
"Londra, 28 aprile.
"G. Garibaldi".
Garibaldi però non si trattenne a lungo nella sua isola. Il 14 di giugno, collo stesso vapore che lo aveva ricondotto dall'Inghilterra e che il Duca di Sutherland aveva messo a sua disposizione, sbarcava nell'Isola d'Ischia per curarsi, secondo si diceva, dell'artrite.
Come si disse già da qualche tempo correva una corrispondenza privata fra Mazzini e Vittorio Emanuele.
Intermediario fra Vittorio Emanuele e Mazzini era il patriota Diamilla Muller amico al Mazzini e carissimo quanto altrettanto devoto a Vittorio Emanuele.[176]
Nel novembre del 1863 il Diamilla Muller riceveva da Mazzini un messaggio che diceva così:
"Il Re non intende questo cospirare continuo a impiantare un dualismo tra il governo e il partito d'azione, in cose nelle quali si era, in sostanza, d'accordo; volere egli Venezia quanto me: avere egli fede nell'onestà del mio procedere; perchè non si verrebbe a un patto per l'intento comune?"
E il 15 novembre del 1863 il Mazzini in una sua lettera nella quale apriva l'animo suo grande, concludeva così:
Caro Muller
"Se chi pensa alla guerra contro l'Austria ha coscienza di me, e crede al mio onore, che non ho tradito mai, io dichiaro
"Che non credo a vittoria definitiva possibile senza l'esercito regolare e l'intervento governativo.
"Che non sogno neanche d'innalzare, ove anche il potessi, una bandiera repubblicana sul Veneto—che tacendo noi per coscienza e per dignità d'ogni programma politico, e limitandoci a gridare guerra all'Austria, aiuto ai nostri fratelli,[177] accetteremmo il programma che escirebbe dal Veneto. Ora il grido del Veneto che abbisogna dell'esercito e dell'Italia costituita come è, sarà infallibilmente monarchico. Su questo punto il re non ha dunque da temere.
"Data questa sicurezza, il migliore accordo è quello di lasciarci fare, e apprestarsi a cogliere rapidamente l'opportunità che noi cercheremo di offrire.
"Garibaldi è l'anima d'ogni moto di volontari. Nessuno può dubitare sulla di lui adesione alle dichiarazioni che io feci sul principio di questa mia lettera. Ma sono convinto, che la di lui azione dovrebbe essere lasciata libera ed indipendente. S'intende che i primi fatti di guerra governativa regolarizzerebbero il contatto dell'insurrezione e del capo dei volontari col disegno generale strategico.
"Potete comunicare al re questa mia e credetemi vostro
G. Mazzini
La risposta di Vittorio Emanuele fu:
"Avere comuni lo slancio e il desiderio di fare con la persona di cui si parla. Giudicare le cose da me e con la massima energia, non con timide impressioni altrui.[178]
"Ma sappia la persona che gravi sono i momenti, che bisogna ponderarli con mente calma e cuore ardente, che io e noi tutti vogliamo e dobbiamo compiere nel più breve spazio di tempo la grand'opera; ma guai a noi tutti se non sappiamo ben farlo, o se, abbandonandoci ad impetuose intempestive frenesie, venissimo a tale sciagura da ripiombare la patria nostra nelle antiche sventure.
"Il momento non è ancora maturo; fra breve, spero, Dio aiuterà la patria nostra.
"V. E."
Il 2 di maggio in un autografo il Re faceva a Mazzini questa risposta:
"La Polonia mancò ognora nelle varie sue fasi insurrezionali della forza vitale di espansione, e questa è la principale cagione della sua rovina: forse potrebbe rinascere come la fenice dalle proprie ceneri, estendendo le sue ramificazioni in Gallizia, Principati ed Ungheria, dove il terreno sarebbe facile á exploiter se vi fossero uomini energici ed audaci che servissero di trait-d'union.
Se i moti in Gallizia estesi alle citate contrade prendessero le proporzioni di una spontanea[179] popolare insurrezione da tenere fortemente occupata l'Austria, allora sarebbe necessario anzitutto d'aiutarla con un nucleo d'italiani determinati, e così riuniti vari fecondi elementi, tutti ostili al principale nemico si potrebbe condurre a compimento il comune desiderio.
"V. E."
Intanto correvano intelligenze oltre che con Mazzini e Garibaldi anche coi generali Klapka e Turr capi dell'insurrezione ungherese e con altri a Belgrado ed a Bukarest—Garibaldi era pronto a tutto.
Nel maggio il Re Vittorio Emanuele approvava tutte le proposte di Mazzini e si metteva d'accordo col generale Garibaldi, che doveva essere il condottiero dell'ardita impresa; intermediario del Re Vittorio Emanuele con Garibaldi era il sig Porcelli.
Alcuni amici del generale Garibaldi non approvavano questa pericolosa spedizione e temevano pel Generale stesso, che volevano rimanesse in Italia ad aspettare altri eventi propizi. Ma egli era risoluto; si doveva partire ed Elia stava aspettando impaziente l'annunziato vapore, quando ricevette la seguente lettera:[180]
Torino, 9 luglio 1864.
Mio caro Elia,
"I mestatori hanno tentato di fare andare a monte il tutto e di far cambiare idea al nostro G....
"Spero che non riesciranno! Questa sera vedrò l'altra persona e cercherò di accomodare ogni cosa.
"Domani vi saprò dire qualche cosa di positivo.
"Intanto ho voluto scrivervi queste due righe in risposta alle vostre due, perchè attendiate senza inquietarvi.
"Sarà un piccolo ritardo, ma pazienza! Ho scritto a Stagnetti ciò che desiderate.
"A domani dunque.
"Tutto Vostro
"Porcelli".
Ma l'indomani 10 luglio 1864 il Giornale il Diritto pubblicava la seguente protesta anonima:
"Avuta certa notizia, che alcuni fra i migliori del partito d'azione sono chiamati a prendere parte ad imprese rivoluzionarie e guerresche fuori d'Italia, i sottoscritti (che non si sottoscrissero!) convinti:[181]
"Che noi stessi versiamo in gravi condizioni politiche;
"Che nessun popolo e nessun terreno sia più propizio ad una rivoluzione per gli interessi della libertà, che l'italiano;
"Che le imprese troppo incerte e remote quali sono le indicate, ordite da principi, debbano necessariamente servire più a' loro interessi che a quelli de' popoli;
"Credono loro dovere per isgravio della loro coscienza dichiarare;
"Che l'allontanarsi dei patriotti italiani in questi momenti non può che essere funesto agli interessi della patria".
Questa pubblicazione del Diritto fece persuaso Vittorio Emanuele che non potendosi più condurre l'impresa con la dovuta segretezza, se ne accrescevano i pericoli; e non volendo che si pensasse, che egli mandava al sagrifizio Garibaldi coi suoi valorosi compagni, per vedute ambiziose proprie, con lettera, portata al Generale dal Porcelli, lo scioglieva da ogni impegno e ritirava il suo concorso all'opera progettata.[182]
La guerra del 1864 intrapresa dalle due grandi potenze germaniche contro la Danimarca fu poi l'origine dei loro dissensi. Finchè si trattò di togliere ad un piccolo regno i tre ducati dell'Elba; finchè si volle togliere ogni ingerenza ai minori Stati della Confederazione, Austria e Prussia andarono d'accordo; ma quando si fu alla spartizione della conquista fra le due potenze, si sviluppò un forte antagonismo che doveva condurre alla guerra.
In vista di questa eventualità il Conte di Bismark chiamato a sè nei primi di marzo il Conte Barral, Ministro d'Italia presso il Re di Prussia, ebbe con lui una conversazione concernente un trattato di alleanza offensiva e diffensiva a concludere il quale La Marmora incaricava il generale Govone—non poteva farsi scelta migliore—e il 9 marzo egli partiva da Firenze per Berlino. Il trattato fu concluso e firmato, ed a questo l'Italia si mantenne fedele, sebbene l'Austria le offrisse la cessione del Veneto, purchè si distaccasse dalla Prussia. Essa si preparò alla[183] guerra con la mobilitazione dell'esercito e col richiamo sotto le armi delle vecchie classi.
La guerra fu dichiarata.
Il Re Vittorio Emanuele, dopo la dichiarazione di guerra all'Austria, indirizzava alla Nazione il seguente proclama:
Italiani!
"Sono corsi ormai sette anni che l'Austria assalendo armata i miei Stati, perchè Io aveva perorata la causa della comune patria nei consigli d'Europa, e non ero stato insensibile ai gridi di dolore che si levavano dall'Italia oppressa, ripresi la spada per difendere il mio trono, la libertà dei miei popoli, l'onore italiano e combattere pel diritto di tutta la nazione.
"La vittoria fu pel buon diritto; e la virtù degli eserciti, il concorso dei volontari, la concordia ed il senno dei popoli e gli aiuti di un magnanimo alleato, rivendicarono quasi intera la indipendenza e la libertà d'Italia.
"Supreme ragioni che noi dovemmo rispettare ci vietarono allora di compiere la giusta e gloriosa impresa: una delle più nobili ed illustri[184] regioni della penisola, che il voto delle popolazioni aveva riunito alla nostra Corona e che per una eroica resistenza e una continua e non meno eroica protesta contro il restaurato dominio straniero ci rendeva particolarmente sacra e cara, rimase in balia dell'Austria.
"Benchè ciò fosse grave al mio cuore, nondimeno mi astenni dal turbare l'Europa desiderosa di pace, che favoriva colle sue simpatie il crescere ed il fondarsi del mio Regno.
"Le cure del mio governo si volsero a preferenza ad accordare gli ordinamenti interni, ad aprire ed alimentare le fonti della pubblica prosperità, a compire gli armamenti di terra e di mare, perchè l'Italia, posta in condizione di non temere offesa, trovasse più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragione delle opportune prudenze, aspettando si maturasse col tempo, col favore dell'opinione delle genti civili e degli equi e liberali principii che andavano prevalendo nei consigli d'Europa, l'occasione propizia di ricuperare la Venezia e di compiere ed assicurare la sua indipendenza. Quantunque l'aspettare non fosse senza pericoli e senza dolori entro confini mal circoscritti e disarmati, e[185] sotto la perpetua minaccia di un inimico, il quale nelle infelici provincie rimaste soggette alla sua dominazione aveva accumulato i suoi formidabili armamenti della offesa e della difesa: collo spettacolo continuo innanzi agli occhi dello strazio che egli faceva delle nostre popolazioni, che la conquista e una spartizione iniqua gli avevano dato, pure io seppi frenare, in omaggio alla quiete d'Europa, i miei sentimenti di italiano e di Re, e la giusta impazienza dei miei popoli. Seppi conservare integro il diritto di cimentare opportunamente la vita e le sorti della Nazione: integra la dignità della Corona e del Parlamento, perchè l'Europa comprendesse che doveva dal canto suo giustizia intiera all'Italia.
"L'Austria ingrossando improvvisamente sulla nostra frontiera, e provocando con un atteggiamento ostile e minaccioso, è venuta a turbare l'opera pacifica e riparatrice intesa a compiere l'ordinamento del regno, e ad alleviare i gravissimi sacrifici imposti ai miei popoli dalla sua presenza nemica sul territorio nazionale.
"All'ingiustificata provocazione ho risposto riprendendo le armi, che già si riducevano alla proporzione della necessità dell'interna sicurezza:[186] e voi avete dato uno spettacolo meraviglioso e grato al mio cuore, colla prontezza e con l'entusiasmo con che siete accorsi alla mia voce nelle file gloriose dell'esercito e dei volontari.
"Nondimeno quando le potenze amiche tentarono di risolvere le difficoltà suscitate dall'Austria in Germania ed in Italia per via di un Congresso, io volli dare un ultimo segno dei miei sentimenti di conciliazione all'Europa, e mi affrettai di aderirvi.
"L'Austria rifiutò, anche questa volta, i negoziati, e respinse ogni accordo e diede al mondo una novella prova che, se confida nelle sue forze, non confida ugualmente nella bontà della sua causa e nella giustizia dei diritti che usurpa.
"Voi pure potete confidare nelle vostre forze, Italiani, guardando orgogliosi il florido esercito e la formidabile marina, pei quali nè cure nè sacrifizi furono risparmiati; ma potete anche confidare nella santità del vostro diritto, di cui ormai è immancabile la sospirata rivendicazione.
"Ci accompagna la giustizia della pubblica opinione, ci sostiene la simpatia dell'Europa, la quale sa che l'Italia, indipendente e sicura del suo territorio, diventerà pur essa una garanzia[187] d'ordine e di pace, e ritornerà efficace istrumento della civiltà universale.
Italiani!
"Io do lo Stato a reggere al mio amatissimo cugino il principe Eugenio e riprendo la spada di Goito, di Pastrengo, di Palestro e di S. Martino.
"Io sento in cuore la sicurezza che scioglierò pienamente questa volta il voto fatto sulla tomba del mio magnanimo Genitore. Io voglio essere ancora il primo soldato della indipendenza italiana.
"Viva l'Italia.
"Firenze, li 20 giugno 1866.
"Vittorio Emanuele".
Il Re rivolgeva poscia il seguente proclama all'esercito:
Ufficiali, sottufficiali e soldati!
L'Austria, armando sulla nostra frontiera, vi sfida a novella battaglia. In nome mio, in nome della Nazione, vi chiamo alle armi. Questo grido di guerra sarà per voi, come lo fu sempre, grido di gioia. Quale sia il vostro dovere, non ve lo dico, perchè so che bene lo conoscete. Fidenti nella giustizia della nostra causa, forti del[188] nostro diritto sapremo compiere con le armi la nostra unità.
Ufficiali, sottufficiali e soldati!
Assumo oggi nuovamente il comando dell'esercito per adempiere al dovere che a me ed a voi spetta di rendere libero il popolo della Venezia, che da lungo tempo geme sotto ferreo giogo. Voi vincerete, ed il vostro nome sarà benedetto dalle presenti e future generazioni.
Firenze, 21 giugno 1866.
Vittorio Emanuele.
Disponeva poi che si istituissero due depositi a Como ed a Bari per la formazione del corpo dei volontari e ne offriva il comando al generale Garibaldi, che rispondeva così al Ministro della guerra:
Caprera, 14 maggio 1866.
Signor Ministro,
"Accetto con vera gratitudine le disposizioni emanate da S. M. in riguardo al corpo dei volontari, riconoscente della fiducia in me riposta coll'affidarmene il comando.
"Voglia essere interpetre presso Sua Maestà[189] di questi miei sentimenti, nella speranza di potere subito concorrere col glorioso nostro esercito al compimento dei destini nazionali.
"Ringrazio la Signoria Sua della cortesia colla quale si è degnato farmene partecipazione.
"Voglia credermi della Signoria Sua
Dev.mo
"G. Garibaldi".
Si sapeva dunque della formazione di un corpo di volontari e tutta la vecchia guardia aspettava di essere chiamata; non si sapeva però dal Generale quale destinazione gli si sarebbe data. Si parlava che avrebbe avuto incarico di sbarcare coi suoi volontari in Istria, sollevare quelle popolazioni italianissime e piombare su Trieste. Ma prevalsero altri concetti.
Quando tutto fu deciso egli chiamò a sè i suoi fidi, ed all'Elia così scriveva:
Mio caro Elia,
"Venite—Se vi fosse Burattini, che venga. Se vi fossero pure dei bravi marinari volontari conduceteli a Milano e arrivati là avvisatemi.
Vostro
"G. Garibaldi".
[190]Subito Elia metteva assieme un buon numero di marinari volontari, ai quali, oltre il Burattini, si unirono alcuni capitani della marina mercantile che si offersero come marinari; e tutti partirono per Milano, ove giunti Elia informava subito il Generale chiedendo ordini.
Il 16 di giugno il "Monitore Prussiano" pubblicava la dichiarazione di guerra, mentre le truppe incominciavano le ostilità. Il 17 il telegrafo ne dava notizia all'Italia e La Marmora fedele ai suoi impegni partiva pel Quartiere generale, ed il 20 inviava la dichiarazione di guerra all'Austria.
Se la flotta italiana fosse stata affidata al comando di un uomo come Garibaldi, con la certezza di dominare con la stessa l'Adriatico, tenendo obbligata la flotta nemica a stare riparata sotto i cannoni di Pola, il miglior piano di campagna sarebbe stato quello d'impossessarsi, con un energico colpo di mano di Trieste per farne base di operazione dell'esercito, che sbarcato su quel punto avrebbe girato tutte le difese accumulate per tanti anni sul territorio Veneto, trasportando di primo slancio la guerra nel suolo nemico; disgraziatamente prevalse altro criterio, e la flotta[191] italiana fu data in mano a persona mancante di energia e di quella capacità superiore, che richiedevasi in momento così grave e decisivo per la nazione.
Per maggiore sventura, nella fissazione e nella esecuzione del piano di campagna, si urtarono due pareri contrari.
La Marmora non ammetteva altra offesa possibile se non dal Mincio colla base di Alessandria e Piacenza. Cialdini invece aveva capito essere folle impresa l'attacco di fronte al quadrilatero; essere indispensabile girarlo, facendo base a Bologna e dirigendo le operazioni di attacco su Padova per Pontelagoscuro e Rovigo. L'attacco dal Mincio conduceva per necessaria conseguenza agli assedi di Peschiera e di Verona che bisognava assolutamente evitare.
L'aggressione invece da Bologna a Rovigo non presentava grandi difficoltà. La marcia dal Po all'Adige, comeche brevissima era tutt'altro che difficile, tanto più che gl'italiani potevano contare sul simpatico concorso delle popolazioni.
Concentrate le maggiori forze italiane fra Badia e Rovigo, con la sinistra, forte da poter reggere ad un'energica offesa proveniente da Legnago[192] facile sarebbe stata la riduzione dei quattro piccoli forti di Rovigo col gran materiale di artiglieria rigata di cui si disponeva; così con Rovigo in mano era assicurato il passo dell'Adige e l'arciduca comandante le forze austriache veniva obbligato o a dar battaglia con tutti gli svantaggi d'inferiorità numerica nei pressi di Padova, o chiudersi in Verona, o retrocedere verso il Piave.
Così la campagna ci sarebbe iniziata nel modo il più brillante.
La Marmora rifiutò recisamente di operare nel Po; adottò invece un mezzo termine che doveva infine condurre a cattivi risultati. Fu quindi stabilito che i primi tre corpi di armata eseguirebbero una seria dimostrazione sul Mincio onde attrarre da quel lato le forze dell'arciduca, mentre il 4o Corpo, varcato il Po marcerebbe su Rovigo di cui s'impadronirebbe, attendendo per inoltrarsi oltre l'Adige, di essere raggiunto dal grosso dell'Esercito, che vi si porterebbe mediante una marcia di fianco, utilizzando la ferrovia dell'Emilia. Se la dimostrazione accennata non fosse riuscita e che l'arciduca avesse opposti gravi ostacoli al passaggio del basso Po, era[193] allora Cialdini che sarebbe andato a raggiungere La Marmora sul Mincio.
Fissato dal La Marmora questo piano, nella mattina del 19 giugno, dal comando supremo dell'Esercito fu ordinato che all'alba del domani il 1o Corpo si avanzasse a prendere posizione sulle alture tra Pozzolengo e Volta in modo da poter chiudere il passo ad ogni sortita da Peschiera sulla destra del Mincio; che il 3o Corpo d'armata si avanzasse su Goito legandosi a sinistra col 1o sotto Volta e a destra col 2o per Rivalta; che il 2o Corpo si appressasse a Mantova, senza passare il confine, ma in modo da potere al rompere delle ostilità, impadronirsi subito di Curtatone e minacciare Borgoforte; che la divisione di cavalleria muovesse nella notte per porsi tra Castiglione delle Stiviere, San Cassiano, Guidizzolo e Medole.
La riserva generale d'artiglieria si collocasse attorno a Cremona.
Il fronte dell'armata del Mincio era per tal modo collocato su una distesa di 42 chilometri.
Disegno del comando supremo dell'Esercito era il seguente: al mattino del 23 impadronirsi dei passi del Mincio tra Monzambano e Goito con[194] truppe del 1o e 3o Corpo, porre piede sulla sponda sinistra e spingere la cavalleria verso l'Adige; e, nel tempo stesso, colle truppe pel 2o Corpo impossessarsi dei fortini avanzati di Curtatone e Montanara dinanzi a Mantova, entrare nel Serraglio, tagliare le comunicazioni tra quella fortezza e Borgoforte, e assalire questa ultima posizione dalle due sponde del Po e costringere con un rapido fuoco di numerosa artiglieria, il presidio alla resa o allo sgombro.
Nel mattino del 23 il passaggio del Mincio fu effettuato come era stato ordinato senza contrasti da parte degli austriaci.
Il 1o Corpo passò il Mincio a Monzambano colla brigata Pisa e si ritirò al di là ed a cavallo del fiume; la quinta divisione lo passò a Borghetto ed occupò Valleggio; la 3a lo valicò ai mulini di Volta ed occupò l'altipiano di Pozzuolo; la 2a restò nella sua posizione di Pozzolengo osservando Peschiera; una forte riserva si situò a metà strada tra Volta e Borghetto.
Il 3o Corpo valicò il fiume al ponte di Goito, alla presenza del Re.
Vi passarono la 7a, 16a e 9a Divisione mentre l'8a gettava un ponte più in alto, a Ferri; le divisioni[195] 16a e 7a si collocarono in prima linea, fra Belvedere e Roverbella, le altre due rimasero in seconda linea.
Il 2o Corpo non passò il Mincio; ma con la 6a Divisione ed una brigata della 4a varcò la frontiera delle Grazie ed occupò Curtatone e Montanara; l'altra brigata della 4a Divisione fu posta sulla destra del Po, osservando Borgoforte.
Le divisioni Longone e Angioletti rimasero nei pressi di Castelluccio.
Tutti questi movimenti, come si disse, non incontrarono alcuna resistenza. L'assenza di forze austriache nella pianura avanti Verona, indusse il generale La Marmora a ritenere che il nemico avesse rinunziato a difendere il terreno fra l'Adige e il Mincio, e che si sarebbe limitato a contrastare il passo del primo fiume. Perciò venne nel concetto di gettarsi arditamente fra le piazze di Verona, Peschiera e Mantova, per separarle una dall'altra, ed occupare una forte posizione che, richiamando l'attenzione del nemico, favorisse il passaggio del 4o Corpo d'Armata, concentrato fra Bologna e Ferrara. In conseguenza di questo presupposto diede gli ordini perchè il 1o Corpo occupasse Castel Nuovo, S. Giustino e Sorra. Il[196] 3o, prolungando questa linea, avesse occupato Somma-Campagna e Villafranca.
Ordinava infine che il 2o Corpo, passando il Mincio a Goito, avesse occupato quel paese, Marmirolo e Roverbella, quale riserva generale.
Tutti questi movimenti dovevano farsi nelle prime ore antimeridiane del giorno 24.
Garibaldi aveva accettato con gran cuore, che Trento, fosse l'obbiettivo delle sue operazioni; ma v'erano altre vie per giungervi oltre quella all'ovest del Garda. Scalare le sue truppe a Bergamo, accennando a nord per richiamare gli austriaci ai passi del Tonale e del Caffaro; poi correre a gran passi al Po Cremonese, e, per l'Emilia, al basso Po, dietro il corpo del generale Cialdini; entrare con questo nel Veneto, sopravanzarlo, e per la Val Sugana lanciarsi su Trento. Questo era il piano che egli aveva in mente. La Val Sugana era infatti la più facile per la impresa del Trentino; ma tale disegno non combinava colle idee del Comando Supremo ed a questo dovette sottomettersi.
Il generale il 23 giugno contava di avere con sè seimila uomini circa, e con questi si metteva[197] in marcia per la via che gli era stata tracciata, mentre sapeva che il generale Kunn gli opponeva una forza superiore ai 18 mila uomini.
Elia aspettava da tre giorni a Milano la chiamata di Garibaldi, quando a mezzo del tenente colonnello Francesco Cucchi dello Stato Maggiore, riceveva l'ordine di portarsi con tutti i suoi a Salò.
Ivi arrivato Elia presentava al generale i volontari che lo accompagnavano. Questi lo informò che suo intendimento era di affidare a lui il comando della minuscola flottiglia del Lago di Garda; ma Elia gli fece osservare che avendo già il maggiore Sgarallino Andrea di Livorno, arrivato prima, presa la consegna ed il comando della flottiglia stessa, per ordine del Capo di Stato Maggiore, era suo desiderio di lasciarglielo; solo chiedeva il comando dell'unica barca cannoniera pronta ed armata "Il Torione", se il generale avesse risolutamente deciso di lasciarlo nella flottiglia. Il generale pregò Elia di rimanere nella flottiglia e gli diede il comando desiderato.
Questa flottiglia si componeva di cinque barche cannoniere armate con un cannone da 24 mm. a prua, difese da un parapetto di corazza[198] e da 2 da 5 1/3 mm. nei fianchi; ma quattro di esse erano in riparazione e solo dopo alcuni giorni furono pronte all'azione.
La flottiglia austriaca sul lago era composta delle cannoniere ad elica "Speinthenfel" "Wildfang" "Scharfschiutez" "Raufbold" "Wespe" e "Nikoke" e dei vapori a ruote "Francesco Giuseppe" e "Hess".
Il 23 il generale aveva ordinato ai volontari che aveva sottomano, di marciare avanti e di occupare con audaci colpi di mano il Caffaro e Montesuello; e i garibaldini non perdettero tempo.
Il colonnello Spinazzi, comandante del 2o reggimento, messosi subito in marcia si spingeva fino ad Anfo; il maggiore Castellini faceva avanzare il suo battaglione di bersaglieri in due colonne di due compagnie ciascuna e da una compagnia del 2o reggimento, per la strada di Bagolino verso Montesuello e vi riusciva mettendo in fuga il nemico che si ritirava. Così i nostri si erano stabiliti sul Montesuello e sul Caffaro, con drappelli di fianco a Bagolino da un lato ad Hano e Monte Stino dall'altro, quando arrivava allo Spinazzi l'ordine di retrocedere su Lonato e Desenzano; e ciò in seguito all'ordine[199] che il generale Garibaldi aveva ricevuto dal Comando Supremo, di recarsi a proteggere l'eroica Brescia.
Si credeva, secondo notizie avute, che a Villafranca fosservi due squadroni di cavalleria nemica. S. A. R. volendo sorprenderli ordinava al Capitano di Stato Maggiore Taverna di porsi alla testa dello squadrone d'avanguardia e di attraversare di gran galoppo quella città, per la strada diritta e larga che la taglia nel mezzo, e ai due battaglioni di bersaglieri di seguirlo a passo di corsa. Intanto la Divisione sostava a breve distanza.
L'avanscoperta fu eseguita con prontezza, ma fu trovata la città sgombra di nemici.
Il conte Taverna spinse la ricognizione sulla strada di Verona e Povegliano e vi scoperse le vedette nemiche; erano Ussari Wurtemberg della brigata Radakowschi in marcia. Avviso ne fu dato al grosso della Divisione che già aveva traversato Villafranca; questa spiegò subito la brigata Parma in prima linea con due batterie a cavallo della strada Regia e della ferrovia, tendenti a Verona. Era tempo perchè l'attacco[200] della cavalleria austriaca, si sviluppò immediato, energico e violento.
Gli squadroni Usseri si slanciarono a galoppo serrato contro lo squadrone italiano inseguendolo fino sulle catene dei bersaglieri che coprivano la brigata Parma; lì si arrestarono accolti da viva fucilata, batterono in ritirata e si ridussero presso le due brigate comandate dal Pulz e dal Radakowschi, le quali spiegati i propri cavalieri in battaglia, gli Ussari Imperatore a diritta, gli Ulani di Trani a sinistra, la batteria al centro, si lanciano contro Villafranca.
Gli Ulani preso il galoppo sopravanzarono gli Ussari; oltrepassato Canova incontrarono le fitte catene dei bersaglieri. Caricare queste ed i sostegni fu l'affare di un momento, ma al di là diedero di cozzo contro gli otto quadrati della brigata Parma, appoggiati da una potente artiglieria che vomitava mitraglia. Il principe Umberto aveva avuto appena il tempo di gettarsi in un quadrato del 49o, comandato dal maggiore Ulbrich. Lo spettacolo era imponente; da una parte una giovane fanteria, cui non intimidivano gli urrak dei cavalieri lanciati a briglia sciolta, dall'altra una brillante cavalleria che si gettava[201] impavida contro quella muraglia di ferro e di fuoco. Ma i quadrati del 49o rimasero immobili come torri e la cavalleria austriaca vide spezzarsi tutti i suoi sforzi contro la muraglia di ferro della brava fanteria, superba di mostrare il suo sangue freddo e il suo eroismo al figlio primogenito di Vittorio Emanuele il quale, con serenità d'animo dava l'esempio del coraggio e della devozione al dovere.
Dopo inutili, ripetute cariche gli avanzi del reggimento Trani retrocedettero laceri e malconci; quando il Radakowschi li riannodava appena 200 risposero all'appello.
Al rumore delle cannonate la divisione Bixio era accorsa a spiegarsi sulla sinistra del principe il generale ordinava al suo capo di stato maggiore, tenente colonnello di San Marzano di porsi alla testa dei tre squadroni di cavalleggeri di Saluzzo, muovere in ricognizione e portare soccorso, occorrendo, a S. A. R. Il tenente colonnello di San Marzano si slancia alla testa dei suoi bravi squadroni si avventa contro la cavalleria nemica che tentava sfondare i quadrati della fanteria della divisione del principe e concorre a decimarla; per questo fatto brillante[202] Di San Marzano veniva decorato della Croce di Ufficiale dell'ordine militare di Savoia.
Nel frattempo l'attacco da parte degli austriaci era divenuto generale. Fino alle 4 pomeridiane si combattè dando i nostri prova di indomabile resistenza contro un nemico assai superiore in numero, perchè quasi la metà delle nostre forze, al comando del Cialdini, era rimasta sulla destra del Po colle armi al piede.
Alle 5 tutto il 7o corpo austriaco appoggiato da una brigata del 5o corpo, dopo di essersi fatto padrone di Sommacampagna, assaliva le poche truppe italiane per sloggiarle dalle alture di Belvedere, che eroicamente difendevano. Ottomila dei nostri, sebbene spossati dalle marcie e dai lunghi combattimenti, tenevano testa a forze tanto soverchianti nemiche che ben presto sommarono a più di venticinquemila. I nostri non cedevano, la lotta continuava sempre più accanita, furiosa, con gravissime perdite da ambo le parti. Ma nuove forze subentravano e il nemico ingrossava, premeva sempre più, e i nostri furono obbligati a ripiegare.
Il 29o reggimento e il 18o bersaglieri assaltarono risolutamente la Mongabia e il Monte Cricol.[203]
Erano 20 compagnie sostenute dal fuoco di otto cannoni che andavano ad assalire 25 compagnie austriache con otto pezzi, in fortissime posizioni. Di contro alla parte orientale del Monte Cricol, il generale Willarey colla 5a compagnia del 30o si avanzava tenendo alto il berretto e gridando Viva il Re, quando, colpito da tre proiettili cadde fulminato. Ma quelle alture con tanto accanimento difese, furono dai nostri valorosi conquistate; e le truppe della brigata austriaca furono obbligate ad una ritirata scompigliata, con l'abbandono di due cannoni e tre carri di munizioni rovesciati.
Il Casale di Mongabia veniva occupato dal maggiore Raiola-Pescarini con tre compagnie del 29o reggimento.
Il generale Govone che era stato mandato dal Re sulle alture di monte Torre con la brigata Alpi, vide quanto vantaggio poteva ricavare da questa posizione, ove aveva raccolto tutta la sua artiglieria. Per primo scopo si prefisse di conquistare Custoza. Fece piazzare tutte tre le batterie coi tiri rivolti contro quel villaggio; ordinò che il 34o bersaglieri (maggiore Pescetto) muovesse ad aiutare i granatieri che combattevano per riprendere quella posizione.[204]
L'effetto di quel potente fuoco d'artiglieria fu grande. Il 34o bersaglieri superò con mirabile slancio l'erta scoscesa del poggio di Custoza, di contro alla testa del Monte Torre, raggiunse i valorosi della 3a Divisione, e al suono delle trombe si slanciò insieme a quelli, entro il villaggio, impegnando contro gli Austriaci lotta accanita.
In quel momento arrivava dalla parte di Villafranca, inaspettato rinforzo, la seconda batteria a cavallo comandata dal valoroso maggiore Ponzio-Vaglia.
Giungendo sull'alto del poggio all'entrata sud-occidentale del villaggio, la testa della batteria urtava in un forte drappello di cavalleria Austriaca e ussari di Baviera; il maggiore Ponzio-Vaglia riuniti intorno a sè i serventi dei pezzi, cui si aggiunsero gli ufficiali della batteria, carica furiosamente la cavalleria austriaca, la rompe, la mette in fuga, facendone alcuni prigionieri.
Infine gli austriaci sono obbligati a ritirarsi in rotta verso il Belvedere.
Rimasti padroni di quella posizione, bersaglieri e granatieri impegnarono il fuoco contro i nemici appostati in Val Busa, nel cimitero, nella[205] chiesa, nel palazzo Maffei e sul poggio soprastante.
Il maggiore Ponzio-Vaglia ordinava al capitano Perrone di condurre i suoi cinque pezzi in aiuto dei combattenti nel villaggio di Custoza contro il nemico, appostato fortemente a Belvedere.
Appena impadronitosi di Custoza il generale Govone mandava avviso al generale della Rocca, cui diceva di inviare colà altre truppe per fronteggiare quelle assai numerosa del nemico che sempre più ingrossava e col quale il combattimento era seriamente impegnato.
Digraziatamente la 3a divisione (Brignone) assalita da forze preponderanti, era stata costretta ad abbandonare le importantissime posizioni del Monte della Croce e di Monte Torre. L'annunzio fu doloroso assai pel generale La Marmora il quale, vista l'importanza di esse, ordinava al generale Cugia di affrettarsi a portare soccorso a quella divisione, muovendo verso le alture ed ordinava al colonnello Ferrari, comandante del 64o fanteria, di seguire senz'altro la mossa.
Intanto il generale Govone che aveva obbligato gli austriaci ad abbandonare non solo Belvedere[206] ma anche le posizioni di Monte Molimenti e Cavalchina, ordinava alle sue brave truppe di marciare alla conquista di quelle posizioni, che alle 2 1/4 pom. furono in mano dei nostri.
20 compagnie stavano ora su quelle alture dinanzi a Belvedere sino a Bagolino. Urgeva apparecchiarsi a gagliarda difesa su quelle importantissime posizioni e sopratutto coprirle di artiglieria; ma tempo e mezzi mancavano.
Il generale austriaco Moroicic riceveva ordine dell'arciduca di muovere le sue due brigate di riserva ed impadronirsi nuovamente di Custoza. Erano passate le 3 pom. e le nostre truppe non avevano alcun sentore di quella mossa che doveva dare il crollo alla battaglia. Alle 3 1/4 ricominciava il fuoco dell'artiglieria nemica più violento che mai.
Nell'udire il forte rumore della battaglia sulle alture di Custoza il generale Bixio mandava il suo capo di stato maggiore colonnello di San Marzano, a chiedere al comandante del corpo se poteva muoversi in soccorso. Anche S. A. R. Umberto mandava a prendere ordini, e ricevevano quello di rimaner fermi nelle loro posizioni. Infatti il generale della Rocca interpretando gli[207] ordini ricevuti dal La Marmora nel più stretto senso, non si credette autorizzato ad un atto spontaneo di vigorosa controffensiva.
Vedendo addensarsi rapida tanta massa d'armati attorno a Belvedere, il generale Govone fa scendere dal Monte Torre il 27o bersaglieri e lo spinge contro la sinistra del nemico; ordina al generale Bottacco di fare avanzare il 36o reggimento sulla destra ad est di Custoza. Il combattimento infuria; le nostre quattro batterie dal Monte Torre, tirando a mitraglia, fanno strage dei nemici; ma il numero di questi è stragrande e i vuoti si riempiono in un attimo. I nostri sono esausti di forze, e vengono meno le munizioni; il nemico ingrossa e preme sempre più; non è possibile resistere più a lungo, le nostre perdite sono enormi; il maggior Fezzi cade ferito a morte, sono feriti gravemente i tenenti Salini e Tornaghi, il capitano Alberi è ucciso, il capitano Serratrice e il maggiore Lavezzeri feriti. Anche il capitano di stato maggiore Biraghi è ferito gravemente. Gli Austriaci occupano l'altura sovrastante a Valle Busa; i nostri, sempre combattendo, sono costretti a scendere verso la chiesa[208] e il cimitero; i due cannoni della batteria a cavallo rimangono nelle mani del nemico.
Intanto il generale Moroicic aveva fatto piazzare sulle alture di Belvedere e di Monte Molimenti le batterie delle due sue brigate e tre altre della riserva e, d'accordo con quelle del 9o corpo batteva furiosamente Custoza, monte Torre e il Monte della Croce, quindi ordinava un attacco generale che divenne formidabile per la gran massa degli assalitori.
I difensori di Custoza si sforzano di tener fronte al nemico col fuoco e con cenni di contrattacco sotto la tempesta dei proiettili, tramezzo alle case che ardono e minacciano rovina. Il colonnello Marchetti eccita i suoi a resistere; la batteria a cavallo ha finito le munizioni; il tenente Polloni ne protegge la ritirata. Granatieri, bersaglieri e fanteria del 51o e del 35o combattono furiosamente; il generale Bottaco dirige impavido il combattimento; ma ogni più lunga resistenza non è possibile; troppo è grande la soverchiante forza nemica.
Frattanto il generale Govone ha avuto risposta da Villafranca che nessun soccorso può essergli mandato; la sua artiglieria è all'ultimo[209] colle munizioni; il capitano Gatti, del suo seguito, è ucciso al suo fianco, il capitano Nasi ferito gravemente.
Le sue truppe non possono più reggere il peso della battaglia divenuto enorme. Non gli rimane un momento da perdere se vuole salvare la sua Divisione dalla terribile conseguenza degli attacchi di fronte e di fianco. Comanda la ritirata su Villafranca. Manda ufficiali a fare riordinare dietro la casa Coranini i retrocedenti per avviarli in colonna di marcia sulla strada; i colonnelli Cravetta e Di Salasco sono ordinati sui fianchi della strada per agevolare e coprire la ritirata dell'artiglieria e della fanteria.
Il movimento si eseguisce con tanto ordine, quanto è possibile in simili casi, sotto il micidiale tiro delle artiglierie situate nelle alture; e qualche centinaio di valorosi rimasti a contatto col nemico in Custoza e nel bosco, assicurano, con un ultimo sforzo di difesa, la ritirata.
Così finisce verso le 6 pom. la battaglia di Custoza combattuta con straordinario valore.
Mentre questo avveniva a Custoza e nelle alture di Belvedere e di Monte Croce, il comandante[210] del 7o reggimento bersaglieri, maggiore Giolitti, segnalava la comparsa di grosse masse di truppa nemica sulle alture di là di Val di Staffolo. Il generale Cugia spediva avviso al Comandante del 3o corpo della minaccia d'imminente attacco di forze preponderanti, facendogli presentire l'impossibilità di mantenersi in quella posizione. Il generale Della Rocca gli mandava ordini di ritirarsi in direzione di Villafranca.
Il generale Della Rocca comprendendo che il momento finale era giunto, dava le disposizioni per la ritirata verso il Mincio; la divisione Bixio e la cavalleria di riserva doveano coprirla.
La fermezza del generale Bixio e delle sue truppe assicurarono la ritirata del 3o Corpo di armata ed egli stesso si affrettò poi ad occupare Quaderni, per impedire al nemico di penetrare tra Villafranca e Valleggio.
Il combattimento del 24 giugno non fu affatto disonorevole per le truppe italiane. Il campo di battaglia rimase in parte agli austriaci, in parte a noi, e se noi ci ritirammo, si ritirarono essi pure.
Le nostre perdite furono sensibili, ma quelle del nemico furono maggiori. La maggior parte[211] dei nostri combattenti fecero prodigi di valore, tanto è vero che gli austriaci, persuasi che l'armata italiana non è inferiore ad alcun altra, si astenne dal cimentarsi a molestare e ad impedirne la ritirata. Nove divisioni non avevano potuto prender parte a quel combattimento; due rimaste per ordine superiore a Villafranca; quella comandata da S. A. Reale il principe Umberto e l'altra comandata dal generale Bixio; e sette divisioni con 176 cannoni rimaste sul Po, sotto gli ordini del generale Cialdini.
La giornata di Custoza non ebbe la grande importanza che, gli si volle attribuire; tanto è vero che il 17 luglio le truppe sotto agli ordini di Cialdini passato il Po, costringevano la guarnigione di Borgoforte ad abbandonare quella forte piazza per ritirarsi in Mantova.
Per i volontari comandati da Garibaldi l'ordine di ritirarsi dalle posizioni conquistate era stato doloroso, ma bisognava ubbidire.
Il generale senza esitare, con la sua abituale rapidità, ordinò alle sue truppe di abbandonare i posti occupati e con tanto valore difesi, e li disponeva fra Brescia e Lonato.[212]
Nella notte del 25 il comandante della flottiglia ordinava ad Elia di sbarcare tutto il materiale di guerra della sua cannoniera e di avvertire di non lasciare a bordo palle esplodenti; poichè dovevasi dar fuoco alla flottiglia e distruggerla.
Elia ubbidì quanto allo sbarco del materiale, che poteva essere stato richiesto dal Generale come necessario alla difesa di Brescia, ma credette di non poter egualmente permettere si abbruciasse la sua cannoniera. Raccomandò ai marinari del "Torrione" di fare buona guardia e, coll'autorità che gli dava il suo grado superiore, ordinò ai comandanti delle altre cannoniere di non dare esecuzione ad alcun ordine, che potesse compromettere la salvezza del naviglio loro affidato. Fatto ciò egli si diresse alla residenza del Capo di Stato maggiore e, trovato il generale Fabrizi ed il colonnello Guastalla, chiese loro quali erano gli ordini per la flottiglia e saputili, domandò carta bianca, ripromettendosi d'impedire che essa cadesse in mano agli austriaci, senza che vi fosse bisogno d'incendiarla e di distruggerla. Sua intenzione era di adoperare il sistema, che ebbe a riuscirgli così bene a Marsala col "Lombardo"[213] di aprire all'ultimo estremo i rubinetti alle macchine per farle affondare. Avuta tale facoltà, mantenne una attivissima sorveglianza per non essere sorpreso dal lato del lago, mentre il colonnello Bruzzesi prendeva le sue precauzioni dal lato di terra, e non essendo accaduto nulla di straordinario, la flottiglia fu salvata con soddisfazione grandissima del generale Garibaldi, che alla notizia avuta della sua distruzione era andato su tutte le furie.
Venuto il giorno dopo a prendere il comando di Salò il generale Avezzana, questo con insistenza pregava Elia di accettare il comando della flottiglia, e sebbene a malincuore, perchè gli doleva lo stato di quasi inazione a cui era condannato, pur nondimeno dovette ubbidire, perchè alle istanze del generale Avezzana vi si aggiunse il comando del generale Garibaldi, che, venuto a bordo della cannoniera Torrione gli faceva elogio per la salvata flottiglia e gli ordinava di prenderne il comando. L'Elia non poteva rifiutarsi e chiese ed ottenne per suo Capo di Stato maggiore il capitano, amico suo carissimo, Alberto Mario.
Ebbe poi delle segrete ed importanti missioni[214] di fiducia d'ordine del generale Garibaldi e da lui personalmente. La prima affidatagli fu quella di recarsi in incognito ad esplorare se erano vere alcune mosse del nemico riferite al Capo di Stato Maggiore, e nel tempo stesso di vedere se era fattibile impossessarsi di un vapore che gli Austriaci avevano in costruzione a Desenzano, ciò che fu impossibile perchè il vapore non era ancora interamente allestito: ecco la lettera con la quale gli dava l'incarico.
"Caro Colonnello,
"Ecco le due guide di tutta confidenza. Ho già detto loro qualche cosa. Quando crederete voi direte il resto. La vettura sarà alla vostra porta tra pochi minuti. Buon viaggio e felice ritorno con più buone notizie. Il sotto Capo di Stato Maggiore. E. Guastalla".
Altre missioni di Garibaldi al Ministero con lettere e con istruzioni riservate l'Elia condusse a termine con soddisfazione del generale.
Come si è già visto la battaglia del 24 non portò conseguenze gravi come sulle prime dava a temere.
Il generalissimo austriaco non si sentì abbastanza[215] forte da arrischiarsi ad altri attacchi dopo la ben contrastata vittoria (se pur vittoria poteva chiamarsi) e, salvo qualche piccola ricognizione, si tenne nel quadrilatero.
Il 1o luglio ricevuto il rinforzo di tre dei cinque reggimenti che si stavano organizzando, il generale Garibaldi, lasciato buon presidio a Brescia ed a Lonato, disponeva il movimento in avanti per riprendere, con nuovo sangue dei suoi, le posizioni che gli era stato ordinato dì abbandonare.
Il giorno 2 di luglio il colonnello Corte ebbe l'ordine di muovere verso Rocca d'Anfo. La sera pernottava a Vestone ed alla mattina riprendeva la marcia. Verso il mezzogiorno veniva avvertito che una compagnia di bersaglieri, comandata dal capitano Evangelisti e sotto la direzione del capitano di Stato Maggiore Bezzi aveva ricevuto ordine di girare attorno alla Rocca e xxxxxdi piombare dalla cima dei monti sugli austriaci che occupavano S. Antonio e le falde orientali di Monte Suello.
Arrivata la colonna in prossimità di S. Antonio venne attaccata dai Cacciatori austriaci, appostati sulle falde del monte e distesi lungo[216] lo stradale. Ma non per questo i nostri rallentavano la marcia. Arrivati sulle alture vi prendevano posizione e piazzati 4 cannoni aprivano contro gli austriaci un fuoco così ben nutrito da obbligarli a ritirarsi sul Monte Suello. Nel fatto mostrarono valore e sangue freddo il tenente colonnello Bruzzesi e il maggiore Mosto; si comportò da valoroso il sottotenente Coralizzi che veniva decorato al valore militare.
A mezzanotte dal 8 al 9 la brigata Corte si mise in marcia per i monti del Tirolo; giunta sull'erta del Monte Poino vi fece l'alto e furono prese disposizioni per il combattimento.
Il 3o reggimento fu mandato in ricognizione verso Storo, ove si sapeva accampato un corpo austriaco forte di 4000 uomini.
Sull'albeggiare del giorno 9 una colonna di 2000 austriaci con artiglieria si mosse contro i nostri attraverso la via che mena a Rocca d'Anfo.
Queste mosse vennero segnalate a Garibaldi che montato tosto in carozza arrivò fra le file dei volontari; egli stesso li dispose pel combattimento mettendoli in avanzata, ben fiancheggiati e protetti dal cannone; giunti i garibaldini a contatto col nemico il generale ordinava senz'altro[217] la carica alla baionetta che eseguita brillantemente sbarragliava e travolgeva a precipitosa fuga, gli austriaci, inseguiti dai nostri fin sotto ad Arzo.
Il giorno 10 gli austriaci vollero prendere la rivincita, ma anche questa volta furono bravamente respinti e, costretti ad abbandonare Arzo si ritirarono su Storo.
Si procedeva allora dal generale Garibaldi all'espugnazione del forte d'Ampola.
La notte del 18 con ardimento rarissimo un battaglione del 9o reggimento, comandato da Menotti Garibaldi, dopo avere marciato più ore in silenzio e con ogni sorta di cautele occupava Monte Burelli e Monte Giove. Colla occupazione di quelle alture il forte d'Ampola rimaneva completamente circondato.
Alle 2 pomeridiane dello stesso giorno il forte si arrendeva senza condizioni.
Anche in Val Camonica ebbe luogo un fatto d'armi molto onorevole pei pochi volontari che vi presero parte.
Il maggiore Caldesi comandante del 1o battaglione del 4o reggimento, aveva preso posizione nella stretta di Incudine sopra Edolo e vi si era[218] afforzato con opere di difesa campale, valendosi di due pezzi di artiglieria del 44o battaglione di Guardia Nazionale Mobile della legione Guicciardi forte di circa 450 uomini, d'un drappello di doganieri e di alcuni carabinieri.
Il 1o luglio giungeva a Breno il luogotenente colonnello Cadolini cogli altri tre battaglioni del 4o reggimento e il 2o battaglione bersaglieri; e la mattina del 2 si recava ad Incudine; visitava le posizioni e dava altre opportune disposizioni di difesa; ordinava un miglior collocamento dell'artiglieria e la costruzione di un ponte nell'Oglio per poter padroneggiare anche il versante sinistro della Valle, prescrivendo al maggiore Caldesi di tenere quella posizione ad ogni costo, e ad ottenere tale effetto gli annunziava l'invio del 2o battaglione bersaglieri.
Predisposto ogni cosa ripartiva per Edolo onde fare avanzare le altre sue truppe. Ma camin facendo gli venne avviso che un corpo di 5 mila austriaci irrompeva pel passo di Croce Domini su Breno. Arrivato ad Edolo spediva ordine telegrafico a Breno perchè i tre battaglioni occupassero subito Campolare nella Valle delle Valli di contro allo sbocco di Croce Domini, e dopo[219] di aver spedito il 2o battaglione bersaglieri ad Incudine e dato ordine al Castellini che lo comandava di porsi alla dipendenza di Caldesi, lasciava Edolo e alla mattina del 3 era a Campolare; visto che nessun nemico era calato da Croce Domini ed avendo saputo che di là del monte eravi buon nerbo di nemici, decise di lasciare a Campolare un battaglione, il 4o, e ricondusse gli altri due a Breno.
Frattanto il maggiore Caldesi aveva collocato il 2o bersaglieri nel Casale di Davena, a mezza via tra Incudine e Vezza, con ordine di assicurare la ritirata alla sua compagnia che stava agli avamposti a Vezza e, se il nemico si fosse avanzato con grosse forze, ritirarsi tutti alla posizione di Incudine.
Nel corso della notte vi fu qualche allarme; si disse al Caldesi che 7 mila austriaci stavano per piombargli addosso, ed egli chiedeva per telegrafo rinforzi al Cadolini mentre ordinava al Malagrida di abbandonare il posto avanzato di Vezza e di ritirarsi assieme al maggiore Castellini su Incudine.
Il Malagrida ubbidì, non così il Castellini che gli ordinava invece di rioccupare la posizione[220] abbandonata; senonchè nel frattempo gli austriaci si erano avanzati, e trovato sgombro il villaggio di Vezza, lo avevano occupato fortemente e piazzati in batteria i loro cannoni. Quando il Malagrida, ubbidendo agli ordini del Castellini si presentava avanti il villaggio, veniva accolto da vivo fuoco nemico; non si scosse per questo il bravo ufficiale, ma ordinò ai suoi di distendersi in catena e di muovere arditamente avanti; intanto sopraggiungevano i rinforzi dei bersaglieri comandati dai capitani Adamoli e Frigerio; il combattimento divenne allora accanitissimo; il nemico si addensava sempre più e il Caldesi visto che la posizione era insostenibile mandava ordini di ritirata. Ma il prode Castellini non volle darsi per vinto. Comandata la carica alla baionetta si slanciò per primo; impetuoso fu l'assalto, ma una grandine di fuoco di fucile e di mitraglia arrestava la foga dei nostri bravi che venivano decimati. Il prode Castellini cadeva colpito nel braccio, nel volto e nel petto; il bravo Frigerio cadeva egli pure colpito per non più rialzarsi. Gli assalitori si ritrassero alquanto per riprendere fiato; erano stanchi si, ma non iscoraggiati; si appostarono rispondendo colpo a colpo; ma, ultimate[221] le munizioni, dovettero cedere e ritirarsi dietro ordine del capitano Oliva, che per la morte del Castellini aveva assunto il comando. Anche il maggiore Caldesi erasi ritirato da Incudine e si era fermato a Cedegolo, dietro ordine del tenente colonnello Cadolini, ove venne raggiunto dall'Oliva coi suoi bravi che nel combattimento impari, avevano mostrato grande valore e fermezza.
Il 10 luglio il tenente colonnello Bruzzesi rafforzato dal 2o battaglione del 9o reggimento e da una batteria del maggiore Dogliotti, cacciava gli austriaci da Lodrone e si spingeva ad Arzo posizione migliore.
Padroni del forte d'Ampola i garibaldini mossero in avanti verso la gola, sulla sommità della quale si trova il villaggio di Tiarno di sopra, mentre più in basso vi è l'altro che si noma Tiarno di sotto.
Avanti a quest'ultimo si apre la stretta valle alla cui sinistra si trova Bezzecca, oltre la quale la valle si stringe ancor più, chiudendosi da monti e dal villaggio di Pieve al di là del quale comincia il Lago di Ledro.
La mattina del 20 due compagnie del 2o reggimento, tre del 7o, un battaglione del 6o ed il[222] 1o bersaglieri occupavano Tiarno di sopra; poco dopo vi prendeva posizione pure il 9o comandato dal colonnello Menotti Garibaldi. Il 5o reggimento si collocava a Tiarno di Sotto, spingendo i suoi avamposti fino a Bezzecca.
Era necessario impedire al nemico che si trovava dietro i monti, d'avanzare per la valle di Concei, giacchè superando Bezzecca avrebbe tagliato fuori il 2o reggimento, respinto probabilmente gli altri alle gole d'Ampola, e ponendosi nelle montagne fra questa e Lardaro, avrebbe minacciato seriamente i fianchi delle due linee di operazione.
L'attacco del giorno seguente provò che tale appunto era il progetto tattico del nemico.
Il generale Haug prevedendo questo disegno piantò il suo quartier generale a Bezzecca, incaricando Pianciani di portare a Garibaldi il suo rapporto.
Il generale Garibaldi arrivava in fretta e poneva il suo quartier generale a Tiarno e subito ordinava che un battaglione del 5o occupasse i villaggi della valle di Concei, e si collocasse nelle case onde meglio respingere l'avanzarsi del nemico. Ordinava che un altro battaglione[223] prendesse buona posizione sul Tratt e sull'altura di faccia a Bezzecca per chiudere lo sbocco verso Pieve; gli altri due battaglioni del 5o pronti al far del giorno per guarnire i monti a dritta ed a sinistra della valle di Concei: queste disposizioni, però, non furono eseguite colla prontezza e coll'esattezza necessarie, per cui il battaglione mandato sul monte di destra, trovata la posizione occupata dal nemico fu sperso e molti restarono prigionieri.
La giornata del 21 cominciava così con triste preludio.
Gli austriaci con grosse forze comandate dallo stesso generale Kühn si accingevano a furioso attacco.
Il generale Haug comprese subito che la sua diritta era insostenibile, sebbene vi avesse fatto collocare dal Pianciani tutto quello che vi era di disponibile: mandava quindi il Pianciani stesso ad informarne Garibaldi e lo incaricava di ordinare a Menotti di portarsi col suo 9o reggimento rapidamente sul monte di sinistra, e che il 2o reggimento avesse avanzato dal Pieve circa un chilometro e mezzo in appoggio della destra. Se questo movimento si fosse effettuato come era ordinato,[224] il nemico ne sarebbe rimasto accerchiato. Ma il 2o reggimento non si mosse e l'esito mancò.
Si dovette però alla fulminea esecuzione della disposizione datagli, e al coraggio insuperabile del colonnello Menotti Garibaldi, se la vittoria finì per essere dei garibaldini.
Il colonnello Chiassi per porre riparo al tardato movimento del 5o ed alla mancata mossa del 2o reggimento si avventò contro il nemico con furia irresistibile; alla carica fulminea il nemico s'arresta, cede ed accenna a ritirarsi in disordine, quando nel momento decisivo l'eroico Chiassi è colpito a morte.
Al vedere caduto il loro comandante i nostri rallentano l'offesa, ondeggiano, incominciano a dare indietro e a disordinarsi. In quel momento giungeva sul posto il generale Garibaldi in carozza, ed abbracciato col suo colpo d'occhio sicuro il campo di battaglia, mandava avviso a Menotti di scendere dall'altura col suo 9o reggimento, per approntarsi a disperato attacco.
In pari tempo ordinava che si raccogliessero gli avanzi del 5o reggimento e con quante altre truppe può avere sotto mano, e coi bersaglieri che avevano fatto prodigi di valore, dava le disposizioni[225] per una disperata e decisiva lotta affine di sloggiare gli austriaci.
Intanto questi non solo si erano resi padroni di Bezzecca, ma, sbucati fuori dal villaggio, avevano coronate le alture della loro artiglieria e si preparavano ad un formidabile attacco contro l'estrema linea garibaldina.
Il pericolo era gravissimo, la strada di Tiarno era tempestata dal nemico e Garibaldi stesso veniva fatto bersaglio ai loro colpi. Le palle guizzavano, rimbalzavano e ravvolgevano in un nembo di polvere la sua carrozza; uno dei cavalli era ferito a morte, una delle guide che la scortava (Giannini) cadde morta, altre hanno feriti i cavalli; i suoi aiutanti volevano strapparlo da quel posto mortale e salvare lui, se non è possibile vincere. Ma Garibaldi aveva sul volto la calma di Calatafimi! "Qui si vince o si muore" e comandava, incoraggiava, spediva ordini, secondato dagli ufficiali del suo quartiere generale, sopratutto da Canzio, dal Miceli, dallo Stagnetti, dal Damiani e dalle guide tra le quali l'Amadei che in tutta quella giornata si era moltiplicato per trovarsi sempre presente dove maggiore era il pericolo; i carabinieri genovesi condotti dal Mosto,[226] sempre primo nei replicati attacchi, seguito dai suoi valorosi Burlando, Stallo, senza cessare di combattere, facevano cerchio attorno al generale per coprirlo dalla furiosa pioggia di proietti che tempestava la posizione.
Intanto il maggiore Dogliotti aveva mandato ordine che si portassero sul posto la batteria di riserva e gli altri pezzi che si erano dovuti ritirare; appena arrivati il generale ordina che al galoppo vadano a piazzarsi su una posizione che esso stesso indica, ed il maggiore eseguisce l'ordine; in un baleno i cannoni sono a posto ed aprono il fuoco convergente su Bezzecca. Le dieci bocche dirette mirabilmente dal Dogliotti produssero il loro terribile effetto. Il nemico sfolgorato dentro Bezzecca, incalzato dal 9o reggimento guidato da Menotti Garibaldi che fa miracoli di valore, dal 7o, dai resti del 5o e da quanti altri eransi ivi raccolti per ordine del generale, incalzano furiosamente il nemico e lo costringono a cedere, e a disperdersi. Per tanto eroismo il colonnello Menotti Garibaldi e la bandiera del suo 9o reggimento venivano decorati della medaglia d'oro al valore militare.
Ma nulla valeva finchè Bezzecca non era presa. Questo il Duce voleva e quanti sono intorno[227] a lui lo comprendono e più che altri, Menotti, Canzio, Missori, Mosto, Damiani, Cariolato, Guerzoni, Bedischini, Miceli, Stagnetti, Amadei, Politi, Tosi, Ficola, Stangolini, Proia, Buratti, Dubois, Bonacci, Gattoni, Popovich, Nani, Lizzani, Giorgi, Fallani, Gatti, Giammarioli, Luperi, Galletti, Restivo ed altri, che formano una falange votata alla vittoria od alla morte; di questa falange si pone alla testa Ricciotti Garibaldi che fa da prode le sue prime armi; il bravo giovanetto degno figlio del padre, afferra la bandiera del 9o reggimento comandato dall'eroico suo fratello Menotti, e con questa in pugno, mentre i cannoni del Dogliotti mandano in fiamme Bezzecca, a testa bassa, lui e tutti i valorosi che si erano stretti attorno al generale, a passo di carica, si slanciano sul villaggio e con lotta terribile, corpo a corpo rompono, sgominano gli austriaci, li mettono in fuga precipitosa e li inseguono colla punta della baionetta alle reni fin al di là di Lesumo.
Così la vittoria, con tanto accanimento contrastata fu violentemente strappata su tutta la linea.
Il 5 luglio, il generale portava il suo quartiere Generale da Rocca d'Anfo a Bagolino.[228]
Il 7 luglio i garibaldini respingevano una forte ricognizione della brigata Thoun, che si era spinta fino a Lodrone, e tre giorni dopo ributtavano brillantemente un secondo attacco di quella brigata, e sotto gli occhi di Garibaldi, la mettevano in fuga.
Intanto la flottiglia del Lago di Garda non stava inoperosa.
La flottiglia austriaca, che poteva considerarsi padrona assoluta del lago perchè molto poderosa, tenevasi tra Bardolino e Garda alla punta di S. Vigilio sotto la protezione di quei forti. Elia con la sua cannoniera "Torrione" si portava a molestarla sotto il tiro dei forti, prendendola a bersaglio col suo cannone, ritirandosi quando vedeva che le navi austriache abbandonavano le àncore per inseguirlo, tenendo avanti il nemico diritta la prua corazzata, ordinando macchina indietro a poco a poco, con la lusinga di poterle attirare sotto i forti di Salò. Tentativi vani!
Il 15 di luglio si addivenne alla formazione regolare delle brigate, come alla proposta del generale Garibaldi portata al Ministero dal colonnello Elia.[229]
Vennero formate così:
| 1a | Brigata | 2o e 7o | reggim. | magg. gen. | Haug |
| 2a | " | 4o e 10o | " | " | Pichi |
| 3a | " | 5o e 9o | " | " | Orsini |
| 4a | " | 1o e 3o | colonn. | brigad. | Corte |
| 5a | " | 6o e 8o | " | " | Nicotera |
Al comando di Salò il ten. gen. Avvezzana.
Capo di Stato maggiore Augusto Vacchi.
Fu ordinato che l'8o reggimento movesse da Vestone per raggiungere a Condino il 6o col quale doveva formare brigata.
Nella stessa mattina del 15 il brigadiere Nicotera aveva occupato Condino col 6o reggimento e l'8a batteria del 5o reggimento d'artiglieria (capitano Afan di Rivera). Nella giornata ricevette l'ordine di portarsi a Cimego; per cui il luogotenente colonnello Sprovieri muoveva a quella volta da Condino col 3o e 4o battaglione del 6o reggimento e una sezione dell'8a batteria.
Il brigadiere Nicotera avevagli ordinato di porre un battaglione a Cimego e coll'altro occupare le alture che signoreggiano il ponte sul Chiese e farvi piazzare i cannoni.
Si aveva notizia che a Cimego non vi erano[230] austriaci, ma passato appena lo sbocco della valle Averta, verso le 10, la colonna Sprovieri fu ad un tratto investita da fucilate dalle alture soprastanti che ferivano alcuni senza che si potessero scoprire i feritori; fu continuata la marcia e nella notte lo Sprovieri giungeva a Cimego ove riuniva il suo piccolo corpo in ordine ristretto.
All'alba del 16 il brigadiere Nicotera mosse da Condino col rimanente della colonna. Nella stessa ora gli austriaci con grandi forze movevano ad assaltare le nostre posizioni avanzate da tre parti convergenti, da Cologna, da Val di Daone, da Pieve per Tiarno e Monte Giove verso Condino, coll'intendimento di attorniare i nostri e distruggerli.
Erano le ore 8 ant. quando cominciò il combattimento. Il brigadiere Nicotera aveva ordinato al 4o battaglione di slanciarsi ad occupare le alture di la del Chiese; prima però che il battaglione giungesse al ponte, l'artiglieria nemica cominciò a fulminarlo e una grossa colonna di austriaci si distendeva di corsa sulle alture di faccia al ponte ed al villaggio di Cimego.
Il maggiore Lombardo comandante il 1o battaglione[231] del 6o reggimento, destinato alla riserva, visto il pericolo che correva il 4o, corre di moto proprio al 3o battaglione che stava allo sbocco del villaggio e gridando "avanti" trasse seco i volontari e primo si lanciò sul ponte ove cadde fulminato. Una palla gli aveva traversato il cuore.
Il Nicotera volle ad ogni costo allontanare il nemico da quelle alture; a questo scopo ordinava al 4o battaglione di scacciarnelo. Si mise alla testa del battaglione il valoroso tenente colonnello Pais-Serra, il quale ordinava si attraversasse il fiume a guado e con grande ardimento, i bravi si slanciano sulle alture sotto il fuoco micidiale del nemico.
I garibaldini fecero sforzi eroici per snidare il nemico dall'elevata posizione, ma dovettero cedere a forze tanto prevalenti e sempre combattendo ritirarsi protetti dall'artiglieria.
Intanto altre masse austriache venivano ad assalire le alture di Narone, per battere la nostra sinistra; il capitano Bennici sostenne con grande valore il combattimento sulla vetta del Narone, ma visto il pericolo di essere avviluppato da forze tanto superiori, dovette ritirarsi[232] colla sua compagnia volante e la 3a compagnia bersaglieri. Il colonnello Guastalla e il maggiore Lobbia dello Stato maggiore, che assistevano al combattimento, visto il pericolo che correvano le compagnie distaccate sulla sponda sinistra del Chiese ordinarono un cambiamento di fronte a destra indietro sempre combattendo. Il generale Garibaldi accorso in vettura mandava un battaglione del 9o reggimento ad occupare Condino ed ordinava all'artiglieria di piazzarsi dinnanzi al villaggio a mezza costa delle alture di Brione; il fuoco di 10 pezzi trattenne il centro e la sinistra degli austriaci. Intanto i generali Garibaldi e Fabrizi provvedevano alla riscossa, e con forze combinate e con grande valore, cacciavano gli austriaci da quelle alture e li mettevano in fuga tale, che più non si arrestarono.
Ormai Garibaldi non temeva più ostacoli, e con le sue mosse progrediva sempre per raggiungere l'obbiettivo dell'azione affidatagli; l'occupazione del Trentino; per cui serrava d'appresso Riva, portava il suo quartier generale a Cologna e incominciava l'investimento di Lardaro.
Padrone delle due valli principali, che [233]dal Garda salivano a Trento, era ormai libero di spiegare tutte le sue forze e di marciare in battaglia contro un nemico, che aveva esperimentato il valore garibaldino. Intanto Medici alla testa di una forte colonna di truppe regolari, si era avanzato vittoriosamente sino a Levico ed a Perzine, per cui la vittoria finale e la presa di Trento era ormai sicura.
Senonchè il mattino del 25 luglio, quando tutto era pronto pel bombardamento di Lardaro giungeva l'annunzio della sospensione delle ostilità, preludio della pace.
Il 10 di agosto Garibaldi riceveva dal generale La Marmora il seguente telegramma:
"Considerazioni politiche esigono imperiosamente la conclusione dell'armistizio pel quale si richiede, che tutte le nostre forze si ritirino dal Tirolo.
"D'ordine del Re".
Quale scossa abbia provato in quel momento il cuore dell'Eroe e dei suoi compagni si può indovinare. Il Trentino perduto, Trieste abbandonata! Ma Garibaldi non tradì neppure con un segno la tempesta che aveva nel cuore, e rispose egli stesso al La Marmora: "Obbedisco".[234]
La campagna per la liberazione del Veneto era finita ed i garibaldini si accingevano a ritornare alle loro case.
Anche la flottiglia del Lago di Garda si scioglieva. Essa, sebbene in condizioni immensamente inferiore alle forze austriache del Lago, seppe compiere il proprio dovere durante la campagna, e se avesse avuto alcuni altri giorni di tempo e ricevuto dal Ministero i cannoni richiesti per armare una zattera ormai a termine di costruzione, avrebbe certo messo tutto l'impegno per vincere la flottiglia nemica e per rendersi padrona del Lago.
Che non mancò al suo dovere lo dicono i due ordini del giorno seguenti del generale Garibaldi e del generale Avezzana comandante divisionale di Salò:
ORDINE DEL GIORNO
mandato al generale Avezzana
Comandante divisionale a Salò
Generale,
"Porgete una parola di lode ben meritata in nome della Patria e del Re ai prodi della nostra flottiglia; essi hanno ben meritato col loro[235] esempio; e sotto il comando di voi, valoroso veterano dell'indipendenza della patria, vedremo presto il Garda libero dalla dominazione straniera.
Salò, 10 agosto.
G. Garibaldi.
Ecco l'ordine del giorno col quale il generale Avezzana, già Ministro della Repubblica Romana nel 1849, dava commiato agli equipaggi della flottiglia.
ORDINE DEL GIORNO
"Gli equipaggi dei volontari che rimasero fino ad oggi a bordo della flottiglia italiana nel lago di Garda, hanno ben meritato della patria. Coraggio nello sfidare il nemico superiore nel naviglio, in macchine da guerra, superiore in uomini. Virtù ed abnegazione negli ufficiali che servirono come semplici militi. Ordine, nettezza nelle Piro-Cannoniere, che il generale Garibaldi affidò alle loro cure.
"Fino al 12 luglio esse furono tre dinanzi al nemico, poi quattro ed in ultimo cinque. Lo affrontarono arditamente nelle sue acque sotto il fuoco delle batterie di terra e gli procacciarono[236] uccisioni e danni. Qui, dove erano i pochi ma valorosi uomini, il nemico non osò mai venire. Unico vanto lo avere bombardato la inoffensiva città di Gargnano e rubato il "Benaco" a quindici miglia dalla flottiglia, che non poteva difendere l'inerme piroscafo mercantile.
"Io ricorderò sempre con militare orgoglio lo avere avuto ai miei ordini il personale degli equipaggi volontari in questa guerra del 1866, forse l'ultima della mia vita.
"S'abbiano tutti gli ufficiali e militi le mie sentite azioni di grazia.
Salò, 21 settembre 1866.
Il luogotenente generale
G. Avezzana"
All'ordine del giorno, il generale Avezzana faceva seguire questa lettera, diretta ad Elia:
Al Colonnello A. Elia
Comandante la flottiglia sul Lago di Garda.
Chi scrive è rimasto sommamente soddisfatto del modo come la S. V. ha disimpegnato il suo compito nel comando delle forze galleggianti sul lago di Garda. Ed aggiunge in verità come V. S. sendo comandante la cannoniera "Torrione"[237] nella calamitosa notte del 26 giugno salvasse risolutamente la sua nave e le altre da prossima rovina, opponendosi ad ordini stati verbalmente impartiti da chi allora comandava la flottiglia. E di poi, insignito da chi scrive e poi confermato dal generale Garibaldi nel comando supremo, s'ebbe in codesto incarico l'elogio palese del salvato naviglio.
Lo scrivente, nell'attestare siffatte verità, offre alla S. V. i sentimenti della sua stima e devozione.
Salò, li 24 settembre 1866.
Il luogotenente generale
comandante divisionale
G. Avezzana
Infine il 28 settembre l'Elia faceva la consegna della flottiglia.
Salò, li 28 settembre 1866.
Il sottoscritto, incaricato dal Ministero di Marina di ricevere la flottiglia sul Lago di Garda affidata provvisoriamente al Corpo dei Volontari italiani, dichiara di aver ricevuto il materiale galleggiante della flottiglia dal colonnello dei Volontari sig. cav. Augusto Elia, presente il generale[238] Avezzana e che ha trovato le cannoniere in ordine e pulizia.
Il comandante
Napoleone Canevaro
Gli ufficiali suoi compagni d'armi nella flottiglia; vollero dare al loro comandante il seguente attestato di affetto:
Al colonnello Augusto Elia
gli ufficiali della Marina Volontaria.
"Radunati oggi per stringerci tutti uniti la mano, permettete, o colonnello, che prima di separarci da voi v'indirizziamo una parola di addio.
"Non è la serva parola di chi adula o di chi esprime un affetto bugiardo, ma è la libera espressione di quanti amareggiati dalle memorie del passato, si confortano nella speranza di un migliore avvenire.
"Dimentichiamo intanto per carità di patria le umiliazioni sofferte sugli insanguinati campi di battaglia e nelle ingemmate aule della diplomazia, e che ci perdonino questo supremo sacrifizio i martiri invendicati di Custoza, di Tiarno e di Lissa![239]
"E noi pure confinati da tre mesi in questa riva, dove l'Eroe del popolo ci destinava a gloriosi avvenimenti, dimentichiamo l'ingrata inazione a cui ci si volle costretti, sfruttando tanta parte di entusiasmo e di generosi propositi.
"Colonnello! Se il sangue delle battaglie non ha battezzato la nostra camicia, voi ed i vostri bravi compagni, sul cui petto brilla la medaglia dei Mille, potrete francamente attestare, come inferiori di numero, di forze e nel difetto di tutto, sapemmo cimentare più volte un nemico, che pur troppo insegnava a chi ci governa come si appresta una guerra, mai a noi come si combatte, e si va incontro alla morte.
"Gli avvenimenti del 1866, non saranno però d'inutile peso nella bilancia dei nostri destini, perchè la democrazia rifulse di una luce più bella sulle alture di Custoza, fra le moschetterie del Tirolo, e in mezzo alle vampe della eroica Palestro!
"Questo è il nostro conforto, Colonnello, e quando tornati alle nostre case deporremo l'incruenta camicia rossa, giuriamo di vestirla quel giorno, in cui il popolo armato insanguinerà[240] nuovamente le vette del Tirolo, e le coste di Istria, perchè qualunque straniero sappia, che quel tremendo confine è il confine dell'Italia, indipendente e libera!
Salò, 21 settembre 1866.
Mario Alberto, Burattini Carlo, Gagliardi Guglielmo, Bandini Temistocle, Bradicich Giuseppe, Viggiani Pompeo, Pegoraro Giuseppe, Martini Narciso, Pedani Tito, Stramazzoni Cesare, Brenno Bandini, Pacetti Luigi, Silvestrini Pasquale, Schiaffino Prospero, Bandini Costantino, Baracchini Andrea, Venzi Cesare, Barbieri Alessandro, Ghiglioni Lorenzo, Bocci Marino, Berardi Colombo, Camin Gaetano, Romani Giovanni, Negrini Mariano.
Intanto che questi fatti si svolgevano in terra un avvenimento dei più dolorosi avveniva nel mare Adriatico.
I migliori ufficiali della marina da guerra invocavano come loro Duce supremo il Galli della Mantica, uomo di grande capacità, e di straordinaria energia, ritenuto una vera tempra d'acciaio, capace di ogni eroismo. Fu invece preferito il conte Carlo Pellion di Persano, che[241] già poteva dirsi vecchio, perchè aveva oltrepassata l'età di 60 anni.
Contro il Persano l'Austria seppe opporre un terribile avversario—Guglielmo Tegetthoff di quarant'anni appena di età; e fu scelto proprio lui, sebbene fosse il più giovine degli ammiragli, perchè lo si sapeva pieno di ardire e dì un coraggio quasi temerario.
La flotta italiana dopo il 24 giugno per la sua potenza era la dominatrice del mare Adriatico; e quella austriaca si teneva rinchiusa in Pola. Vi era tutto da tentare—tutto da sperare.
Fu decisa l'occupazione di Lissa, considerata la Gibilterra dell'Adriatico; e il 18 luglio alle 11 antimeridiane la nostra flotta prendeva posizione dirimpetto all'isola.
Una ricognizione fatta dal D'Amico, capo di stato maggiore del Persano, coll'esploratore "Messaggero" riferiva che la guarnigione dell'Isola era di 2500 uomini provveduta di tutto.
Deciso l'attacco, la flotta venne divisa in tre squadre; una comandata dal vice ammiraglio Vacca doveva attaccare Comisa, difesa da due batterie, e da una casamatta; l'altra sotto gli ordini del vice ammiraglio Albini doveva[242] eseguire uno sbarco nel porto di Manego difeso da due batterie; la terza, comandata dal Persano doveva forzare il porto di S. Giorgio difeso da quattro forti e da due batterie.
Alle 11 1/2 del 19 incominciò il fuoco e senza interruzione durò fino alle 7 1/2 pomeridiane; alle 2 saltava in aria una polveriera nemica; alle 3 1/2 ne scoppiava una seconda e andava all'aria la Torre del Forte e la bandiera che vi era inalberata; alle 5 tutti i forti di S. Giorgio erano demoliti ed i cannoni, ad eccezione di due situati nell'elevata posizione del telegrafo, erano smontati e ridotti al silenzio; l'intrepidezza, il valore degli equipaggi è impossibile descrivere, sebbene a bordo non pochi fossero i feriti e parecchi i morti.
La presa di Lissa era assicurata; ma fu malauguratamente rimandata all'indomani, perchè si ebbe notizia che l'Albini non aveva potuto eseguire lo sbarco.
Alle ore 9 del giorno 20 l'avviso "Esploratore" segnalava la squadra nemica in vista. L'ammiraglio Persano avrebbe dovuto senz'altro assegnare a ciascuna delle navi sotto al suo comando il proprio posto di combattimento, e[243] dare ad esse gli ordini della parte che avrebbe dovuto prendere per ribattere vittoriosamente l'attacco; invece l'ammiraglio Persano alle ore 9 1/2 abbandonava la nave di comando "Re d'Italia" per imbarcare sulla corazzata "Affondatore" accompagnato dal capo di stato maggiore e da due suoi aiutanti di bandiera.
L'onorevole deputato Pier Carlo Boggio che era nella nave ammiraglia "Re d'Italia" quale amatore e come storiografo, all'invito che gli fece il Persano, si rifiutò di seguirlo perchè ebbe subito la percezione che coll'abbandono della nave ammiraglia nel supremo momento del combattimento, si commetteva non solo un gravissimo errore, ma un vero atto colpevole da essere paragonato alla fuga davanti al nemico.
Intanto la squadra austriaca arrivava a grande velocità in linea su due file, ma formata in formidabile cuneo, col proposito di spazzare, rompere ed affondare tutte quelle navi che avrebbe incontrato sulla sua via; in testa a tutte era la nave ammiraglia "Carlo Max".
Il primo e maggiore impeto fu portato dal nemico sulla R. nave ammiraglia "Re d'Italia"—e si capisce!—L'ammiraglio Tegetthoff riteneva[244] che su quella nave stesse il comandante in capo della flotta italiana, e le muoveva arditamente contro. Era un duello tra le due navi di comando—e quello dei due che ne fosse riuscito vincitore avrebbe deciso della vittoria della sua squadra!
Il "Re d'Italia" assalito da poppa, nei fianchi, da prua ebbe spezzato subito il timone per cui rimase senza governo; nella critica e fatale posizione, il comandante Foa di Bruno, uomo dei più valorosi, gli ufficiali sotto ai suoi ordini, gli equipaggi, i cannonieri tutti al loro posto impavidi, rispondevano agli assalitori con bordate, con tiri di cannone, con le carabine—quando—la nave ammiraglia austriaca "Max" le fu sopra a tutta forza di macchina e l'investiva con urto tremendo; con orribile scroscio lo sperone ferrato squarciatole il fianco, le apriva un'enorme breccia sotto la linea d'acqua—e il "Re d'Italia" la bella nave ammiraglia colla bandiera a riva spiegata al vento, sempre eroicamente combattendo s'inclinò—e fra le grida di viva l'Italia da parte del suo equipaggio, e col capo reverentemente scoperto di quello austriaco—sprofondava nell'abisso[245] del mare trascinando nei vortici 700 eroi; primi fra tutti, l'Emilio Foa di Bruno comandante in prima, il deputato Pier Carlo Boggio, il marchese di Malaspina comandante in seconda, il cav. Del Santo sotto capo di stato maggiore, i tenenti Gualterio Enrico, Casanova Giuseppe, Bossano Alfredo, Bozzetto Michele ed Isola Carlo sottotenenti, Olivieri Giuseppe, Palermo Salvatore, Orsini Torello, il conte Fazioli, guardie marine, Verde cav. Luigi medico di bordo; ed il pittore Ippolito Ciaffi. Pochissimi furono i salvati e fra questi il bravo tenente Candiani.
Affondata la creduta nave ammiraglia le corazzate austriache assalgono le navi Italiane "Ancona" la "Palestro" la "San Martino" ed altre: il "Kaiser" si slanciava contro il "Re di Portogallo" ma ne esciva malconcio assai, messo fuori di combattimento ed in fuga, mercé l'abilità e la bravura del comandante Riboty. Nella mischia la "Palestro" venne colpita da granate nella parte non corazzata cagionandole forti avarie.
Sviluppatosi l'incendio il bravo comandante Cappellini fa di tutto per domarlo; ma inutili sforzi! Visto che ogni salvezza della corazzata[246] è ormai impossibile due piroscafi dell'armata italiana "l'Indipendente" ed il "Governolo" sfidando ogni più grave rischio si accostano alla Palestro offrendo salvezza.
L'eroico comandante—chiama a raccolta i compagni—fa ad essi nota l'inevitabile catastrofe—quindi dice: "Chi vuole salvarsi si salvi" Unanime un grido risponde "faremo quello che il comandante sarà per fare" al che il Cappellini risponde "io non abbandono il mio posto" e allora gli eroi tutti a rispondere "vogliamo seguire la tua sorte".
Udita questa commovente decisione il comandante ordina sia alzato il gran pavese. I marinai salgono a riva sugli alberi, sui pennoni, intuonano i canti della Nazione.—Un orrendo scoppio—un ultimo, immenso grido si eleva al cielo "Viva l'Italia viva il Re" e in una nube di fiamme sono tutti avvolti—e i martiri della patria sprofondano nei vortici del mare.
Nel combattimento tutti fecero il loro dovere, gli eroismi di Foa di Bruno e del Cappellini sono immortali; va anche segnalato il valore dei Riboty, degli Acton, dei Del Carretto, dei Del Santo, e l'abnegazione il patriottismo, le[247] virtù militari di tutti gli ufficiali della flotta e degli equipaggi.
Ma a che giova il valore, e a che vale l'eroismo se manca il duce che sappia condurre alla pugna ed alla vittoria?
Il Persano commise due errori gravissimi: il primo di avere abbandonato la nave ammiraglia pochi momenti prima del combattimento. Egli avrebbe dovuto scegliere fin dall'inizio della campagna come nave ammiraglia l'"Affondatore" se la credeva atta a meglio servirlo nel suo piano di battaglia; il secondo è, che egli non seppe adottare un ordine di battaglia rispondente a quello col quale la parte nemica veniva ad investirlo. Colla sua squadra il Persano doveva ordinarsi in due linee ed in forma d'imbuto; lasciare che le navi nemiche entrassero nell'imbuto e quindi assalirle prima a colpi di cannone, a bordate e poi investendole a colpi di sperone.
L'"Affondatore" doveva tenersi sopravento onde potere dominare, dirigere l'azione; ed impegnato il combattimento valersi della velocità della sua nave e delle sue qualità offensive, correre addosso al "Max" nave ammiraglia[248] austriaca, investirla a tutta forza col tagliente suo sprone e colarla a fondo. Così avrebbe certamente manovrato Galli della Mantica. Invece come fu utilizzata questa nave, la più potente del tempo?
L'Affondatore (comandante Martini), mentre le nostre navi "Re d'Italia" "Re di Portogallo" "Ancona" "Palestro" e le altre si trovavano alle prese col nemico e facevano con tanto eroismo il loro dovere, traversata la linea delle corazzate italiane volgeva la prua contro il lato destro del "Kaiser" manovrando per investirlo col suo formidabile rostro. Già il luogotenente Chinca dalla tolda della nave manda il grido "pancia a terra" affinchè il potente urto imminente non faccia trabalzare gli uomini dell'equipaggio; già l'ultima ora è suonata per quel bel tipo delle antiche armate navali, quando ad un tratto, l'"Affondatore" per ordine imperioso dell'ammiraglio Persano comandante le forze navali italiane, piega bruscamente a destra e si allontana dal Kaiser e dal combattimento. Quante lacrime di vergogna e di dolore si saranno versate da quei bravi che formavano l'equipaggio della potente nave! Quanti di quei bravi si saranno morse le dita![249]
L'orgoglio italiano nell'anno 1866 ebbe a patire ben dolorose delusioni.
L'infelice giornata di Custoza che non fu priva di gloria per i nostri combattenti; la terribile catastrofe di Lissa; recavano profondo dolore nel cuore della nazione. E, per di più la Venezia, uno degli obbiettivi del patriottismo italiano, per sfogo di dispetto e di orgoglio dell'imperatore d'Austria, era data allo imperatore Napoleone dalle cui mani doveva riceverla il Re d'Italia!
Nella notte del 4 al 5 luglio il Re Vittorio Emanuele aveva ricevuto il seguente telegramma:
A S. M. il Re d'Italia
Parigi, 5 luglio
"Sire: L'imperatore d'Austria entrando nelle idee espresse nella mia lettera al sig. Drouyn De Lhuys, mi cede la Venezia, dichiarandosi pronto ad accettare una mediazione per ristabilire la pace.
L'esercito italiano ha avuto occasione di mostrare il suo valore. Un maggiore spargimento di sangue è dunque inutile e l'Italia può raggiungere[250] onorevolmente lo scopo cui aspira mediante un accomodamento con me, su cui sarà facile intenderci. Scrivo a S. M. il Re di Prussia per fargli conoscere questo stato di cose e proporgli per la Germania come lo faccio a V. M. per l'Italia, la conclusione d'un armistizio come preliminare alle trattative di pace.
Napoleone"
Questo gravissimo annunzio, pochi giorni dopo una battaglia perduta, sebbene valorosamente combattuta, nel momento di ripigliare le offese con tante speranze e tanto bisogno di un grande successo d'armi, giunse al Re, all'esercito, all'Italia oltre ogni dire sgradito.
Ricevere la Venezia come un dono dalle mani dell'imperatore dei francesi feriva nel più vivo l'amor patrio degli italiani, non solo, ma avrebbe potuto dar motivo a dubbi ingiuriosi sulla fede dell'Italia verso la Prussia sua alleata.
D'altro canto ricusando, e continuando la guerra a dispetto dell'imperatore dei francesi, v'era la possibilità di vederci venir contro la Francia armata nel veneto o altrove! Pure tra la rovina alla quale una tal guerra ci avrebbe condotti e il disonore, nè al quartier generale[251] nè al Re, nè al ministero poteva rimaner dubbia la scelta.
Il Re quindi rispondeva, ringraziando l'Imperatore dei Francesi dell'interesse che prendeva per l'Italia; ma che trattandosi di affare tanto grave doveva consultare il suo governo e il suo alleato al quale era stretto da un trattato.
Intanto il generale Cialdini domandava se poteva invadere senza perdita di tempo il territorio veneto e gittarsi nella provincia di Rovigo.
Il generale La Marmora rispondeva al Cialdini invitandolo ad operare, giacchè egli diceva "per me il peggio sarebbe ricevere la Venezia senza avervi messo piede".
E il generale Cialdini confermava che il 7 di sera avrebbe gettati i ponti e passato il Po.
Per questi fatti l'imperatore Napoleone era adiratissimo, e ci fu poco che la Città regina dell'Adriatico non vedesse sventolare sul campanile di S. Marco e sui forti della sua laguna la bandiera napoleonica ed a suo presidio le truppe francesi.
Per scrupolo di lealtà il barone Ricasoli d'accordo con S. M. il Re e col generale La Marmora si opponeva alla firma dell'armistizio senza averne[252] prima ottenuto l'assenso del Re di Prussia alleato in quella campagna, e l'imperatore Napoleone aveva già ordinato che due navi da guerra con truppe da sbarco "La Provence" e "L'Eclaireur" partissero per Venezia con ordini suggellati.
Ubaldino Peruzzi, visto che al conte Nigra nostro ambasciatore a Parigi non era riuscito di parare il grave colpo, consigliò a Ricasoli di mandare a Parigi il Diamilla Muller conosciuto fin da giovinetto da Luigi Napoleone quando era principe, e che aveva elevate amicizie a Parigi fra le quali quelle di Alcide Grandguillot direttore del giornale officioso "Costitutional" e del generale De Fleury, perchè vedesse di scongiurare questo affronto all'Italia. Questi accettò la delicata, quanto difficile missione e seppe riuscire a risparmiare alla patria una nuova umiliazione e danni non lievi.
La retrocessione dal Veneto si effettuò senza scosse e senza riserve, e la conclusione della pace pose termine ad ogni complicazione.
Unita la Venezia all'Italia, Garibaldi pensava a sciogliere il suo voto a Roma. A tal fine raccomandava[253] agli amici di non indugiarsi, e li incitava a fare i preparativi necessari.
A Firenze erasi costituito un comitato centrale che aveva per capi Cairoli, Crispi, Fabrizi, Guastalla ed altri, tutti animati dal vivo desiderio di dare all'Italia la sua Capitale naturale—Roma.
Dopo le guerre del 1859-1860 le condizioni morali dei liberali romani avevano subito una forte scossa.
I più non accettavano senza discussione la condotta passiva, rassegnata, che dal 1853 veniva loro raccomandata.
L'emigrazione resa più numerosa per i giovani che da Roma erano corsi ad arruolarsi sotto la bandiera dell'unità nazionale, faceva apertamente intendere essere giunto il momento per Roma di cambiare attitudine, e suo dovere di pronunciarsi energicamente per la sua liberazione dal giogo papale.[254]
La vittoria degli alleati sui campi Lombardi—la disfatta dell'esercito ponteficio nelle Marche—la marcia trionfale di Garibaldi nel regno di Napoli—avevano a tal punto entusiasmato la gioventù liberale romana da volere senz'altro che si uscisse dall'inerzia, nella quale l'aveva fatta addormentare il Comitato nazionale.
Ma questo Comitato nazionale romano faceva ogni sua possa per rattenere la brava gioventù dicendo: "La liberazione di Roma è questione difficile—solo la diplomazia può riuscirvi, quindi necessità assoluta di non crearle ostacoli e rimanere tranquilli lasciandone la cura al governo di Torino".
Il partito democratico di Roma, abbenchè stremato, non era del tutto spento. Esistevano ancora non pochi avanzi del 48 e 49 che alla azione del tempo ed alle seduzioni avevano resistito conservando integra la loro fede e i loro principi.
Questi patrioti, insofferenti a tanta sottomissione, s'intesero coi più animosi e migliori della emigrazione e coi capi del partito d'azione; ruppero gl'indugi e organizzarono dei nuclei indipendenti dal Comitato nazionale pronti all'azione;[255] disgraziatamente, però, mancava un'unica direzione.
Il fatto poi di Aspromonte fu lo stimolo ad un azione concorde, e stabilita la fusione dei vari nuclei si costituì un Comitato d'Azione Romano col seguente programma:
"Fare propaganda incessante ed efficace onde indurre il popolo a scuotersi ed a sollevarsi, non fosse altro per dare pretesto al Governo di Torino di portare con maggiore utilità sul tappeto diplomatico la questione romana.
"Raggranellare gli elementi d'azione esistenti in città, organizzarli e prepararli per un dato momento alla riscossa.—Provvedere d'armi la città.—Stabilire mezzi regolari e sicuri al confine per lo scambio della corrispondenza.—Organizzare un servizio di corrispondenza coi giornali italiani ed esteri".
L'impresa era ardua—trattavasi di lottare col prete, coi francesi, col comitato nazionale! Bisognava agire con arditezza e ad un tempo con prudenza poichè le tre polizie, pontificia, francese e quella del comitato nazionale, erano intente a spiare e a sventare le mosse del nuovo centro d'azione.[256]
Contro tutte queste difficoltà lottavano i direttori del partito d'Azione Romano—ed il programma tracciatosi ebbe in parte il suo svolgimento. Un giornale clandestino dal titolo Roma o morte fu istituito e in mezzo a mille ostacoli e peripezie non cessò dalla patriotica sua propaganda, combattendo per tre anni con accanimento le turpitudini del governo dei preti e la condotta del Comitato nazionale che a quello assicurava l'esistenza, consigliando al popolo la inazione.
In questo giornale oltre a patrioti romani, collaboravano Mazzini, De Boni, Asproni, Alberto Mario, Pianciani, Scifoni ed altri. Era direttore il dottore Giuseppe Pastorelli.
Si procedette dal Comitato d'azione all'organizzazione delle forze con forma e carattere proprio. La corrispondenza al di là dei confini fu organizzata con elementi d'indiscutibile sicurezza. Le armi erano state raccolte in luogo da potere essere, a momento opportuno, introdotte in città coll'aiuto di provati patrioti quali il Cucchi, il Guerzoni, l'Adamoli ed altri.
Certo è dunque che il lavoro lento sì, ma costante del Comitato d'azione romano valse a[257] scuotere dall'inerzia la gioventù ed a preparare gli elementi che nella città dovevano prendere parte ad un fatto che doveva affrettare la liberazione di Roma.
L'11 febbraio 1867, il ministro Ricasoli, disapprovato nella perpetua questione del diritto di riunione, aveva sciolto la Camera.
Convocata la nuova, questa non apparendo diversa da quella disciolta, il barone Ricasoli senza attendere alcun voto che lo giudicasse, rassegnava il potere, che veniva raccolto da Urbano Rattazzi.
Si sapeva del nuovo presidente del Consiglio le opinioni su Roma. Egli aveva censurato la convenzione di settembre, e s'era risolutamente opposto alla convenzione Lagrand Dumonceau.
Era pur noto che egli non intendeva fare alcuna concessione alla Chiesa se non quando fosse cessato il potere temporale dell'autorità ecclesiastica ed il governo italiano fosse insediato in Roma.
L'entrata al potere del Rattazzi fece nascere nel partito liberale italiano la speranza che con[258] lui si sarebbe andati a Roma; e il partito d'azione si mise subito all'opera per accelerare l'evento.
Da parte sua il generale Garibaldi inviava al Comitato insurrezionale di Terni il capitano Galliano e il tenente Perelli col mandato di armare quanti giovani fuorusciti romani avessero potuto raccogliere, e con questi, fatta insurrezione nello Stato Pontificio, gettarvi la prima favilla dell'incendio. I rappresentanti del partito d'azione nel Ternano conte Massarucci e Frattini, caldi patrioti e vecchi cospiratori, consentivano di dar mano all'impresa; e il 19 giugno il Galliano ed il Perelli raccolti ed armati centoquattro giovani arditi, tragittata la Nera marciavano per la Sabina. Se nonchè giunti nel punto di sconfinare nei pressi di Ponte Catino e Castelnuovo, una compagnia di granatieri, che si teneva ivi imboscata, circuì la colonna e le intimava la resa.
Questo fatto non influì in ciascun modo a raffreddare l'opera di Garibaldi, chè anzi servì a spronarla. Difatti Garibaldi mandava Cucchi Francesco a Roma per annodare in sua mano le fila della rivoluzione; mandava suo figlio Menotti a sondare[259] il terreno e a stringere patti col Nicotera e con altri nel mezzogiorno; incaricava Acerbi della raccolta dei giovani e delle armi alla frontiera Umbro-Toscana e lo mandava in suo nome a scandagliare le intenzioni del Rattazzi: da quanto ne fu trapelato parve che il Rattazzi non dissentisse dall'idea del generale ed era pronto a coadiuvarlo. Solo dimostrava la necessità che il generale, per acquietare le rimostranze del governo francese e stornare i sospetti del governo pontificio, lasciasse per qualche tempo il continente e si recasse a Caprera.
Intanto nella prima quindicina di agosto il generale aveva dati i suoi ordini e distribuite le parti come alla vigilia di un entrata in campagna; Menotti doveva sconfinare da Terni coll'obbiettivo Monterotondo; Acerbi da Orvieto obbiettivo Viterbo; Nicotera e Salomone da Aquila e Pontecorvo obbiettivo Velletri.
Già il 13 luglio 1867 i comitati riuniti avevano annunziata la loro fusione col seguente manifesto:
Romani!
"Il voto comune, il voto di tutti quelli a cui batte il cuore per l'onore e la libertà della patria, si è realizzato.[260]
"Non più dissensi, non più divisioni; tutte le frazioni del partito liberale si sono data la mano, hanno unite le forze per abbattere per sempre questo resto del governo papale e dare Roma all'Italia.
"Il Comitato Nazionale Romano ed il Centro d'insurrezione fanno quindi luogo ad una Giunta Nazionale Romana la quale assume la suprema direzione delle cose.
"Rallegriamoci di questa santa concordia, e diamo opera a fecondarla con unità di fede e di disciplina, con unità di propositi e di sacrificii. Il fascio romano è ora veramente formato: facciamo che non si sciolga mai più e che presto ci dia la vittoria.
Romani!
"I cittadini rispettabili, che fanno parte della Giunta a cui rassegneremo l'ufficio, sono degni dell'alta missione; ma a nulla riuscirebbero senza il vostro concorso.
"Secondateli adunque, fidenti ed animosi e l'impresa non fallirà.
"Vogliamolo tutti, e ben presto venticinque[261] milioni di fratelli saluteranno Roma Capitale d'Italia".
Il Comitato Nazionale Romano
Il Centro d'Insurrezione.
In quel tempo, invitato Garibaldi ad intervenire al Congresso Socialista Internazionale della pace, che doveva tenersi a Ginevra, vi andò accompagnato da Cairoli, da Alberto Mario, da Ceneri, da Riboli, e da altri amici, e dopo un suo discorso, concretava la sua opinione colle seguenti affermazioni:
1o Tutte le Nazioni sono sorelle.
2o La guerra fra di loro è impossibile.
3o Tutte le querele che sorgeranno tra le Nazioni, dovranno essere giudicate da un Congresso.
4o I membri del Congresso saranno nominati dalle società democratiche dei popoli.
5o Ciascun popolo avrà diritto di voto al Congresso, qualunque sia il numero dei suoi membri.
6o Il papato, essendo la più nociva delle sette, è dichiarato decaduto.
7o La religione di Dio è adottata dal Congresso e ciascuno dei suoi membri si obbliga di propagarla. Intendo per religione di Dio la religione della verità e della ragione.
8o Supplire il sacerdozio dell'ignoranza, col sacerdozio della scienza e dell'intelligenza.
"La Democrazia sola può rimediare al flagello della guerra.
"Lo schiavo solo ha il diritto di far la guerra al tiranno; è il solo caso in cui la guerra è permessa".
A questo colpo inatteso, che urtava contro le idee predominanti nel Congresso, successe un inferno. Garibaldi non attese neppure la votazione, abbandonò il Congresso, rientrò in Italia, e fermatosi un poco a Belgirate, fece ritorno a Firenze.
Intanto le sue istruzioni per la concentrazione delle colonne invadenti il territorio romano erano date e stava per partire egli pure pel luogo dell'azione, quando il 23 settembre in Sinalunga venne arrestato; doveva essere tradotto ad Alessandria. A Pistoia, mentre si era per un momento fermato nel viaggio ebbe tempo di consegnare al Del Vecchio il seguente biglietto da pubblicarsi:[263]
24 settembre
"I romani hanno il diritto degli schiavi, insorgere contro i tiranni.
"Gli italiani hanno il dovere di aiutarli e spero lo faranno a dispetto della prigionia di cinquanta Garibaldi.
"Avanti adunque nelle vostre belle risoluzioni, Romani e Italiani. Il mondo intero vi guarda, e voi, compiuta l'opera, marcerete colla fronte alta e direte alle Nazioni: Noi abbiamo sbarazzata la via alla fratellanza umana, dal suo più abominevole nemico.
G. Garibaldi
Il 27 imbarcato nella Ra nave l'"Esploratore" veniva portato a Caprera dove doveva essere sorvegliato a vista da navi da guerra e dalle loro imbarcazioni.
Intanto che il governo sequestrava Garibaldi, i suoi amici discutevano sul modo di raggiungere lo scopo; se l'accordo nel fine era generale—la liberazione di Roma—vi era discordia sui mezzi di esecuzione: Crispi, Fabrizi, Cucchi, Cairoli, Guastalla, Miceli, La Porta, Oliva, Guerzoni, Adamoli, Damiani, tutta quasi la frazione[264] politica-militare del partito garibaldino opinava che il segnale della riscossa dovesse partire da Roma; Menotti, Canzio, Acerbi e qualche altro, tenendosi più ligi alle istruzioni del generale, volevano che le mosse dovessero essere parallele; il Cucchi, che più di tutti la caldeggiava, dava per sicura l'iniziativa romana.
Mentre avvenivano queste trattative fra i capi del movimento; ad un tratto, all'improvviso per tutti, un circa duecento giovani capitanati dal trentino Luigi Fontana dei Mille, passavano il confine nel Viterbese, si buttavano sopra Acquapendente e dopo una zuffa accanita facevano prigionieri una quarantina di gendarmi pontifici e s'impossessavano del paese.
All'annunzio dell'inopinato assalto di Acquapendente Menotti ed Acerbi credettero non essere più questione di discutere—essere impegnato il loro onore ad accorrere in soccorso degli arditi patrioti—e quindi Acerbi diede ordine alle sue genti di sconfinare.
Il 3 ottobre Menotti Garibaldi rotti gli indugi con pochi compagni e col capitano Tringalli varcava nascostamente il confine. Si diresse a Poggio Catino ove fu accolto con amore fraterno in[265] casa del conte Galeazzo Ugolini. Ma non volle fermarvisi e tosto si mise in moto. A S. Valentino il Sindaco Nardi con venti giovanotti ingrossava il drappello che a Poggio Mirteto accoglieva altri trenta animosi; a Montemaggiore trovava il capitano Fontana con cinquanta circa volenterosi e vi pernottava. Sull'albeggiare la colonna si dirigeva a Montelibretti.
Menotti con circa 80 uomini precedeva, gli altri col Tringali e coll'Ugolini seguivano alla distanza di mezzo chilometro. Giunto Menotti nella macchia di Manocchio si trovò assalito da buona schiera di gendarmi e di zuavi pontifici che lo attendevano in imboscata.
I nostri sebbene sorpresi non si perdettero d'animo; guidati dal valoroso Menotti Garibaldi i bravi volontari si lanciarono sull'inimico; questo dopo breve resistenza preso da sgomento si dava a fuga precipitosa.
Il giorno 6 accampavano i nostri a Carmignano di fronte a Nerola occupata dal colonnello De Charette; quivi la colonna fu raggiunta dal maggiore Salomone che conduceva circa 150 volontari; dal maggiore Valentini di Aquila con altri 100 volontari circa; giungevano pure altri 60[266] baldi giovani guidati da Lodovico Petrini e dal conte Ippolito Vicentini di Rieti; 100 circa da Montopoli sotto gli ordini dei fratelli Rondoni e dell'emigrato romano Ovidi Ercole; arrivava infine il maggiore Fazzari che conduceva oltre 300 volontari da lui formati in un bello e valente battaglione.
Sotto gli ordini di Menotti erano ormai 900 circa volontari. Intanto il collonnello de Charette informato che la colonna che gli stava di fronte erasi molto ingrossata, abbandonava Nerola per Montelibretti.
La mattina dell'8 ottobre, Menotti fece muovere la colonna ed alla sera occupava Nerola; ivi attendeva all'organizzazione della sua truppa ed a provvederla dell'armamento che giungeva da Terni. La mattina del 13 ordinava la marcia su Montelibretti e la colonna vi giungeva verso le due pomeridiane. Si erano avute informazioni che il nemico erasi allontanato, per cui i garibaldini credendosi sicuri avevano formato i fasci d'armi e ognuno per conto suo cercava di provvedere ai propri bisogni ed a ristorarsi del lungo cammino.
D'improvviso una scarica di fucilate avverte[267] i volontari che il nemico è alle porte del paese. Si corse senza ritardo alle armi. Il Fazzari montato a cavallo scorreva le vie animando ed incitando quanti incontrava a formarsi in colonna. Messo assieme un gruppo di circa 50 uomini esce animoso dalla porta e precipita contro il nemico che a passo di carica veniva ad investire il paese.
Era un battaglione di zuavi pontifici, i quali visto Fazzari a cavallo lo accolgono con una scarica a bruciapelo che gli uccide il cavallo e lo ferisce alla gamba; il cavaliere precipita di sella ma non si dà per vinto; ha in pugno il suo revolver, lo scarica addosso a chi ha la disgrazia di avvicinarglisi e sparati tutti i colpi finisce per scaraventare il suo revolver stesso contro i nemici che lo accerchiavano. Questo eroismo incute rispetto agli ufficiali che comandavano i zuavi, i quali invece di finirlo lo lasciavano in custodia di tre dei loro, mentre la massa continuava ad avanzare mantenendo fuoco vivissimo contro i nostri che, sebbene in pochi, tenevano testa.
Intanto Menotti aveva riunito intorno a sè il grosso dei volontari e a passo di carica investe i nemici che fanno resistenza ma infine[268] il valore dei nostri li vince e dei zuavi pochi poterono salvarsi, i più erano rimasti sul terreno morti e feriti.
Nel combattimento molto si distinsero, senza dire del Menotti e del Fazzari, il capitano Tringalli ed i tenenti conte Ugolini Galeazzo e Nani Raffaele, e il sottotenente Campagnoli Aldebrando della colonna Salomone.
Il 13 di ottobre Nicotera esso pure sconfinava con ottocento uomini a Vallecorsa e l'indomani s'avviava a Falvaterra.
Si aspettava che Roma desse qualche segno di vita e Cucchi, Guerzoni, Adamoli, Bossi, Celle, Costa si erano stretti in lega coi membri del Comitato di Azione; ma tutti sentivano che la sollevazione intempestiva nella provincia aveva resa impossibile una sorpresa nella Capitale.
Mentre questo avveniva in Sabina, Canzio e Vigiani pensavano di trarre Garibaldi dalla prigionia di Caprera. Noleggiata una paranzella salparono da Livorno il 14 ottobre, cautamente accostarono alla Maddalena ed a mezzo della Signora Collin, fatto pervenire un biglietto al Generale, proseguivano pel porticello di Brandinchi[269] per aspettarvelo. La notte del 16 ottobre il Generale avventuratosi sopra un guscio di noce, faceva il tragitto da Caprera al punto di ritrovo, e deludendo la vigilanza dei R. Equipaggi, prendeva imbarco nella paranzella, sbarcava a Livorno, ed in sul mezzogiorno del 20 arrivava a Firenze con grande sorpresa del Governo e gioia degli amici.
Il 21 ottobre 1867 veniva diramato il seguente manifesto:
Romani all'armi!
"Per la nostra libertà, per il nostro diritto, per l'unità della patria Italiana, per l'onore del Nome Romano.
All'armi!
"Il nostro grido di guerra sia:
"Morte al papato temporale! Viva Roma Capitale d'Italia. Rispettiamo tutte le credenze religiose, ma liberiamoci una volta e per sempre da una tirannia, che ci separa violentemente dalla famiglia italiana e tenta perpetuare l'inganno, che Roma sia esclusa dal diritto di nazionalità ed appartenga a tutto il mondo, fuorchè all'Italia.[270]
"Da molti giorni i nostri fratelli hanno levato il vessillo della santa rivolta e bagnata del loro sangue la via sacra di Roma.
"Non tolleriamo più che siano soli e rispondiamo al loro eroico appello con la campana del Campidoglio.
"Il nostro dovere, la solidarietà della causa comune, le tradizioni di Roma ce lo impongono.
All'armi!
"Chiunque può impugnare il fucile accorra, facciano di ogni casa un fortezza, di ogni ferro un'arma.
"I vecchi, le donne, i fanciulli elevino le barricate, i giovani le difendano.
"Viva l'Italia!
"Viva Roma!"
Durante la traversata della paranzella da Brandinchi a Livorno Garibaldi redigeva il seguente manifesto:
Da bordo, 18 ottobre 1867.
"Redimere l'Italia e poi morire".
Cari compagni,
"Eccomi ancora con voi, prodi sostenitori dell'onore italiano. Con voi, per compire un dovere,[271] per aiutarvi nella più santa e gloriosa impresa del nostro risorgimento.
"L'Italia s'è persuasa, che non può vivere senza il suo corpo, senza il cuore, senza la sua Roma, che alcuni servili ledendo un diritto e il decoro nazionale, vogliono sacrificare ai capricci d'uno spregevole tiranno.
"Dunque avanti, e costanza soprattutto! Io non vi chieggo coraggio, valore, perchè vi conosco. Vi chieggo costanza. Gli Americani durarono quattordici anni nella lotta gloriosa, che li fece la più potente, la più libera nazione del mondo: a noi concordi bastano pochi mesi per lavare l'Italia dal sudiciume che l'infesta, voglia o non voglia un semplice bastardume ed i suoi padroni.
"G. Garibaldi".
Il 22 partì per Terni. Ivi giunto sapendo che il Governo aveva dato ordine di arrestarlo, in sull'albeggiare del 23, sconfinava a Passo Corese e dava ordine a Menotti, comandante del centro, di riunire tutte le colonne che si trovavano già pronte e di sconfinare senza ritardo. Intanto altre colonne erano in formazione a Terni. E nella notte del 24 Garibaldi telegrafava[272] al Comitato di Firenze: "Occupo Passo Corese e Monte Maggiore con le forze riunite di Menotti". Nel giorno stesso ordinò si investisse Monte Rotondo, che voleva ad ogni costo occupare, ancorchè non avesse alcun pezzo di artiglieria.
La notizia che Garibaldi era entrato nel territorio pontificio, fece accorrere volontari da tutte le parti; anche Ancona eccitata alla guerra da un patriottico proclama non mancò di fare il suo dovere.
Messi assieme pochi fondi, e raccolte delle armi, partiva una colonna di cui veniva affidato il comando ad Elia. Prima però, che questa colonna composta di più di mille ducento volontari fosse armata, si dovette perdere molto tempo a Terni. Infine rotto ogni indugio e sebbene non poche armi mancassero per l'armamento completo, Elia ordinava la partenza e raggiungeva il generale Garibaldi e suo figlio a Monte Rotondo, ove già si combatteva.
La difesa di Monte Rotondo fu accanita. L'attacco incominciato all'alba era durato tutta la giornata; stava per calare la notte ed il fuoco continuava accanito da parte dei papalini; già[273] molti dei nostri erano feriti, fra i quali, Mosto, Martinelli, Uziel; morti il Giovagnoli, l'Andreucci ed altri. "Bisogna finirla" grida Garibaldi—ed ordina di dar fuoco alla porta; verso le otto di sera la porta andava in fiamme e fattavi una apertura i garibaldini vi si precipitano dentro, gli antiboini si rifuggiano nel Castello ed all'albeggiare riprendevano le fucilate; ma visto che i volontari, penetrati nelle scuderie del principe Piombino, che era coi garibaldini a combattere per la liberazione di Roma, si preparavano a dare fuoco al Castello, incendiando il fienile, verso le 9 di mattino si arrendevano, lasciando in nostre mani due cannoni con un centinaio di cariche, circa 300 fucili e poche munizioni.
Nella presa di Monterotondo si comportarono da valorosi, rimanendo feriti, Antonio Lazzari, Emilio Pignocchi, Guerrino Galeazzi, Giovanni Dottavi, Massimiliano Gianforlini, Gennaro Montevecchio, Vincenzo Spadolini, Campagnoli Aldebrando, tutti di Ancona.
Ecco come il generale partecipava la presa di Monterotondo:[274]
Caro Fabrizi
"L'impresa di Monterotondo è certamente una delle più gloriose per questi poveri prodi volontari.
"In tutte le campagne in cui ebbi l'onore di comandarli non li vidi mai sì travagliati dai disagi, dalla nudità e dalla fame.
"Eppure questi valorosi giovani, stanchi ed affamati, hanno compito in questa notte un sanguinoso e difficile assalto, come non avrebbero fatto meglio i primi soldati del mondo. Sono le 4 e siamo padroni di Monterotondo, meno il palazzo in cui si sono rifugiati i zuavi, antiboini e svizzeri.
"Abbiamo in mano molti trofei della vittoria, cavalli, armi e prigionieri.
"Monterotondo, 26 ottobre 4 ant.
G. Garibaldi".
ORDINE DEL GIORNO
"Anche in questa campagna di Roma i valorosi volontari hanno compito il loro glorioso Calatafimi; temporali, nudità, fame quasi da non credersi sostenibili, non furono capaci di scuotere il brillante loro contegno.[275]
"Essi assaltarono una città murata, colle porte barricate e cannoni per difenderla, guernita dagli esperti tiratori che i preti regalano agli italiani da tanti secoli, con uno slancio di cui l'Italia può andare superba!
"Dio benedica questi generosi.
"Monterotondo, 26 ottobre.
G. Garibaldi".
Al Comitato Centrale di Roma:
Cari Amici
"Dopo l'assalto e la presa di Monterotondo ci siamo spinti sino a sei miglia da Roma, ove ci troviamo ora.
"Dei nemici non abbiamo notizie. Se la spedizione francese è vera, spero vedere ogni italiano fare il suo dovere.
"Casina S. Colomba, 27 ottobre.
G. Garibaldi".
Il 24 ottobre Acerbi assaliva Viterbo, ma nonostante il valore spiegato dai suoi, nel quale primeggiò il bravo Napoleone Parboni che l'Acerbi promoveva maggiore, fu necessità desistere dall'attacco.[276]
Il giorno 26 i ponteficii abbandonavano Viterbo e l'Acerbi se ne impadroniva senza colpo ferire. Nella giornata del 24 si distinse anche il capitano Greco, siciliano.
Il Nicotera che aveva per obiettivo Velletri ebbe un serio e micidiale combattimento a Monte San Giovanni, ove cadeva l'eroico Di Benedetto con ben ventidue valorosi compagni; il 28 il Nicotera prendeva la sua rivincita a Frosinone, ove fugava il nemico cagionandogli forti perdite ed il 30 occupava Velletri.
Appena si seppe in Roma che bande di garibaldini erano entrate nel territorio del papa, il governo non ebbe più ritegno. Chiuse alcune delle porte della città; le altre fortemente custodite; sorvegliati gli alberghi e le case; cacciati i forestieri sospetti; infine rigori e vessazioni di ogni sorta; difficile quindi più che mai preparare una sommossa, senza che la polizia non ne venisse a cognizione.
Cucchi Francesco era stato incaricato, con amplissima credenziale di Garibaldi, d'intendersi col Comitato d'insurrezione e coi membri della Giunta Nazionale per promuovere e dirigere il movimento di Roma.[277]
A coadiuvare il colonnello Cucchi erano entrati in Roma, il maggiore Guerzoni il maggiore Adamoli, il colonnello Bossi, il Cella, i quali sfidando ogni pericolo lavoravano indefessamente perchè scoppiasse la scintilla rivoluzionaria ma, nonostante i prodigi d'operosità e d'ardire del Cucchi e dei suoi compagni, i preparativi per l'audace impresa non si erano potuti completare; e, quel che peggio, le armi, senza le quali i congiurati romani si protestavano impotenti a qualunque tentativo, non erasi ancora trovato modo di farle entrare in Roma.
Ma da quelli di Firenze si scriveva al Cucchi "una schioppettata, una sola schioppettata entro Roma e basta"; e la schioppettata fu tirata.
Disegno dei cospiratori era d'assalire il Campidoglio, impadronirsene ed asserragliarvisi. Un drappello di congiurati guidati dal Cucchi e dal Costa Nino era incaricato di questa faccenda. Il colonnello Bossi con altra squadra doveva sorprendere il corpo di guardia di piazza Colonna; Guerzoni con cento uomini forzare Porta S. Paolo e distribuire agli insorgenti le armi depositate nella Villa Matteini. Giuseppe Monti con altri doveva minare e fare saltare la Caserma Serristori,[278] e Zoffetti e altri cannonieri inchiodare le artigliere del Castel Sant'Angelo. I fratelli Cairoli dovevano scendere il Tevere fino a Ripetta, e portare armi che dovevano prendere a Terni. Senonchè, tutte queste imprese audaci abortirono, perchè il Governatore di Roma venutone a cognizione, aveva prese le misure preventive; solo la Caserma Serristori andò in parte all'aria, ma senza scopo, perchè vuota di soldati ponteficii. I fratelli Cairoli con settanta valorosissimi compagni, arrivati all'altezza di Ponte Molle, saputo che i preparativi di sommossa erano falliti, furono costretti a tenersi nascosti durante la notte fra i canneti, ed a cercarsi poi un migliore rifugio appena fatta l'alba. Credevano d'averlo trovato a Villa Glori sui monti Parioli; ma scoperti ed assaliti da truppe cinque o sei volte superiori, dopo eroica resistenza, caduto Giovanni Cairoli, ferito mortalmente Enrico mentre cercava d'assistere il fratello moribondo, la più bella schiera d'eroi, che avesse mai fatto sagrifizio di sè per la patria veniva decimata e dispersa.
Fallito il moto insurrezionale della notte del 22 ottobre, in Trastevere buon numero di arditi popolani si apparecchiavano alla riscossa.[279]
Giulio Aiani patriota e giovane pieno di ardimento, proprietario di un lanificio in via della Lungaretta, aveva dato convegno a quanti erano giovani liberali, forti e coraggiosi in Trastevere, e per quanto potè, raccolse nel suo stabilimento fucili, revolver e munizioni.
In quella casa erasi istituito un laboratorio ove si fabbricavano cartuccie al cui bisogno erano intente alcune giovinette del popolo, addette come lavoranti nel lanificio.
Prossima allo stabilimento eravi l'abitazione di Francesco Arquati, altro vero patriota, molto popolare nel rione di Trastevere. La moglie di lui e le figlie anche esse attendevano alla preparazione delle munizioni, mentre il figlio maggiore dell'Arquati, Pasquale, insieme a Giulio Aiani, percorrevano quel popoloso quartiere per la propaganda alla rivolta, eccitando ad un'ardito movimento i più animosi di quei popolani.
In fatti il 25 ottobre l'opera ferveva nel lanificio Aiani, divenuto focolare di quel manipolo di patrioti, decisi a morire per la libertà di Roma. Fra questi eravi pure Cesare Sterbini, parente del triumviro della repubblica romana nel 1849; quando alle 2 1/4 uno dei giovani che stava di[280] vedetta su una terrazza, dava l'avviso dell'approssimarsi di un corpo di zuavi accompagnati da forte stuolo di gendarmi; fu chiusa e barricata la porta di strada e tutti corsero ad armarsi risoluti all'estrema difesa.
Gli zuavi si slanciano per abbattere coi calci dei fucili la porta della casa, ma dall'alto si tirano delle bombe nelle loro file, e sono ricevuti da fucilata così viva, da costringere la truppa papalina ad abbandonare l'assalto ed a ripararsi nelle vicine vie, ove appiattata, iniziava un vivo fuoco di fucileria contro i patrioti romani.
Al rumore delle fucilate Giulio Aiani che si trovava in casa Arquati corre verso l'uscio per uscirne, ma la casa è in un baleno circondata dagli zuavi e dai gendarmi, che, forzata la porta, si slanciano per le scale; l'Aiani col revolver in pugno si precipita sugli invasori, ma assalito da ogni parte dopo una lotta terribile, sopraffatto dal numero, viene legato e tratto in prigione.
Intanto il combattimento contro la casa Aiani si fa sempre più vivo. Paolo Gioacchini, uomo di 50 anni, capo del lanificio, coi di lui figli Giuseppe e Giovanni incoraggiano alla resistenza e nessuno pensa di arrendersi. Infine il comandante[281] degli zuavi, irritato nel vedere che un pugno d'uomini teneva testa a più di trecento soldati, fa suonare la carica; gli zuavi si lanciano all'assalto della porta, ma per la seconda volta vengono respinti, e molti sono i morti e i feriti. Da due ore si combatteva, quando si vide sopraggiungere altre truppe in rinforzo e la fucilata si faceva più viva.
I tre Gioacchini e Pietro Luzzi lanciano bombe e tirano fucilate dalla terrazza, vengono feriti uno dei Gioacchini ed un giovane trombettiere disertato dalle truppe pontificie. Si combatteva da quattro ore quando agli zuavi riesce di sfondare la porta; la casa è invasa dalla truppa inferocita per la lunga resistenza e fa macello di quanti incontra; Angelo Marinelli, vecchio settantenne, gridava ai giovani di porsi in salvo pei tetti, mentre egli teneva testa agli invasori atterrandone quanti gli si facevano vicini a colpi di accetta, finchè crivellato da ferite cadde per non più rialzarsi; intanto ad alcuni dei difensori era riuscito di mettersi in salvo pei tetti delle case vicine, dove poscia vennero arrestati.
Quelli che non poterono salvarsi non cessavano da combattere sulle scale, sugli abbaini, a[282] corpo a corpo colle daghe, coi pugnali, coi denti, dominante in mezzo a tutti l'eroica donna Giuditta-Tavani-Arquati, che incuora, comanda e combatte, terribile nell'ira nel vedere avanti a se il cadavere del marito e quello del giovinetto figlio, entrambi trucidati; alla fine soccombeva essa pure trafitta da replicati colpi.
Il nome dell'eroica donna e dei prodi caduti con lei dovranno essere ricordati con ammirazione dalle generazioni future e dall'Italia.
Caddero trafitti il padre e i figli Gioacchini, Cesare Bettarelli, Giovanni Rizzo, Enrico Ferrochi, Rodolfo Donnaggio, Francesco Mauro, Augusto Domenicali.
Oltre a questi morirono in prigione in seguito alle riportate ferite Salvatore Raffaeli e Serafino Marconi.
Furono condannati alla pena di morte Giulio Aiani e Pietro Luzzi; ad altre pene Cesare Sterbini, Romano Mariotti, Gaetano Goretti, Giuseppe Leonardi, Pio Crescenzi, Giuseppe Sabatucci, Giovanni Sabatucci, Luigi Domenicali, Ulisse Martinoli, Oreste Martinoli, Costantino Mazza, Luigi Pallocchini, Mariano Magnani, Pietro Calcina, Giacomo Marconi, Paolo Carpanetti, Germano[283] Ceccarelli, Oreste Tedeschi, Lodovico Talucci, Perzio Giuseppe, Del Cassio.
Riuscirono a fuggire alle ricerche della polizia Cesare Benvenuti e Paolo Barabella.
La presa di Monterotondo produsse grande sgomento in tutto il territorio pontificio ed ebbe per conseguenza la ritirata di tutte le truppe papaline al di là dei ponti di Tevere e del Teverone.
Garibaldi non aveva pace se non faceva un colpo di mano su Roma sperando che gli amici nella piazza gli avrebbero facilitata la riuscita e non volle perdere tempo.
Lasciato un battaglione a Monterotondo sotto gli ordini del colonnello Carbonelli, e speditone un altro col colonnello Pianciani a Tivoli, il generale, ordinato ad Acerbi ed a Nicotera di raggiungerlo, muoveva diffilato con tutte le sue forze su Roma.
Il giorno 29 Garibaldi portava il suo quartiere generale a Castel Giubileo spingendo i suoi avamposti oltre a Villa Spada e al Casino dei Pazzi. I pontifici si erano ben premuniti; la porta del Popolo, la Salaria, la Pia e tutte le ville attigue,[284] Torlonia, Patrizi, Lodovisi e Monte Mario erano guernite da pezzi coperti ed occupate da numerose truppe. Garibaldi vide l'impossibilità di un attacco venturoso; passò tutta la giornata a studiare la posizione, e sperando sempre in una insurrezione entro Roma, ordinò che nella notte si accendessero fuochi in tutta la linea del campo.
Ma a Roma l'insurrezione non appena tentata era stata repressa e spenta. Garibaldi con alcuni Carabinieri genovesi sotto gli ordini di Stallo e di Burlando e con alcune guide aveva voluto tentare una ricognizione su ponte Nomentano; incontrata una pattuglia di papalini questa aveva presa la fuga. Dopo una permanenza di un'ora in quel posto, due colonne di zuavi e di antiboini sbucarono, una dal ponte Nomentano, l'altra dal ponte Mamolo tirando contro i nostri. Ma il Generale non volle, che si rispondesse, e siccome egli non aveva voluto fare, che una ricognizione, e lo scopo era raggiunto, nel mezzo della notte ordinò la ritirata su Monterotondo. Egli aveva avuto un messaggio, col quale lo si informava che i francesi sbarcati a Civitavecchia erano in marcia forzata per Roma, e perciò si voleva preparare a riceverli.[285]
Arrivati a Monterotondo mandava il seguente contrordine:
"Al generale Nicotera.
"Per i due messi vostri, che vidi questa mattina vi inviai ordine di occupare Tivoli, e lo stesso ordine vi confermo ora.
"—Qui tutto va bene.
"—Interventi o non interventi, bisognerà compiere l'unificazione della patria.
"A Tivoli troverete Pianciani con un battaglione.
"Scrivetemi subito.
"Monterotondo 31 ottobre.
G. Garibaldi.
Col ritorno a Monterotondo una gran parte di volontari disertarono le loro file per ritornare alle loro case, tantochè alla sera del 2 novembre all'appello neppure la metà delle forze si trovò presente.
Garibaldi, commosso per l'eroica morte di Enrico Cairoli e dei suoi prodi, scriveva il seguente ordine del giorno.[286]
"Volontari italiani!
"La Grecia ebbe i suoi Leonida, Roma antica i suoi Fabi, e l'Italia moderna i suoi Cairoli, colla differenza che con Leonida e Fabio gli eroi furono trecento: con Enrico Cairoli essi furono settanta, decisi di vincere o morire per la libertà italiana.
"Nella notte del 22 al 23 del passato mese, 70 prodi comandati da Enrico e Giovanni fratelli Cairoli, ardirono, pel Tevere, gettarsi fin sotto le mura di Roma, col magnanimo pensiero di portare soccorso d'armi e di braccia al popolo romano combattente.
"A ponte Molle non vedendo i segnali convenuti, sostarono. Giovanni Cairoli spedito in ricognizione riferiva cessata la pugna in Roma. "Ritirarsi o morire". Quei generosi preferirono la morte.
"Si asseragliarono in S. Giuliano, e quivi, uno contro quattro, armati di soli revolvers, questi prodi, operando miracoli di valore, di gloria imperitura coprirono un'altra volta il nome italiano.
"Attaccati da due compagnie di zuavi e antiboini, intrepidamente ne sostennero l'urto. La[287] pugna fu accanita e sanguinosa; ma davanti a quel pugno di valorosi i mercenari del papa ripiegarono. Molti i caduti dei nostri, fra i quali i Cairoli e l'Enrico morto.
"Volontari".
"Tutte le volte che vi troverete a fronte dei mercenari pontifici ricordatevi degli eroi di San Giuliano.
Monterotondo 2 novembre.
G. Garibaldi.
Ordine del giorno al maggiore Eugenio Andruzzi.
"Il maggiore Andruzzi ha il comando dei distaccamenti composti dei Volanti, i quali non devono oltrepassare i 50 uomini cadauno nè essere meno di 30.
"Egli opererà con queste forze sulla destra del Tevere disturbando il nemico in ogni modo e dando al quartier generale ogni notizia di considerazione.
"Esso procurerà di sorprendere i distaccamenti, esploratori, gendarmi e spie, e di non essere sorpreso giammai.
"Perciò le sue marcie saranno più di notte che di giorno.[288]
"Distruggerà vie ferrate, i fili elettrici che possono servire al nemico.
"Dovrà farsi amiche le popolazioni e fregiare di bei fatti e con condotta irreprensibile la nobile missione di servire questa santissima causa.
Monterotondo 2 novembre.
G. Garibaldi.
Il 2 novembre con un ordine del giorno veniva stabilito l'ordine di marcia per la via di Tivoli. Si doveva partire da Monterotondo nelle prime ore del mattino del 3; invece, per non si sa qual contrattempo, s'incominciò la marcia verso le ore 12.
Si erano dal Generale ordinati corpi di esploratori, di avanguardia e fiancheggiatori.
Le posizioni di Palombara, Sant'Angelo, Monticelli erano state occupate da tre battaglioni comandati dal colonnello Paggi, si era quindi tranquilli contro ogni sorpresa; ma non fu così.
Appena oltrepassata Mentana l'avanguardia veniva attaccata dai soldati pontifici.
Da un bosco che si trova a destra della strada che da Mentana va a Tivoli, era incominciato il primo attacco contro un piccolo reparto dei nostri che precedeva la colonna in[289] marcia. Menotti accorse con tre o quattro ufficiali del suo stato maggiore e il suo capo guida Augusto Lorenzini, per riconoscere il nemico, ma non si potè accertate che di una cosa, e cioè che il bosco era fortemente occupato—si sperò che fosse una ricognizione di non grande importanza e Menotti ordinava a Stallo di avanzare col suo battaglione, d'occupare i punti più elevati a destra e sinistra della strada, spingendo le catene per sloggiare il nemico. Intanto sopraggiungevano i battaglioni di Burlando, di Missori, di Mayer che cogli uomini di Stallo si spiegarono a destra per sostenere l'urto delle forze papaline, mentre Menotti pensava alla difesa del centro e della sinistra.
Ben presto si potè constatare che si aveva di fronte tutto intero l'esercito pontificio e Garibaldi spiegava immediatamente le sue forze indicando a ciascuna colonna la posizione da occupare e ordinando un simultaneo contrattacco che fu spinto con bravura e sostenuto gagliardamente contro forze assai superiori per oltre due ore. Ma verso le 3 pom. soprafatti da nuove forze, contrastando palmo a palmo il terreno, i garibaldini furono costretti di abbandonare i[290] pagliai ed indietreggiare fin sotto le case di Mentana.
In quel punto i tiri rapidi e ben aggiustati dei nostri, appostati nelle case che avevano occupato per ordine del generale, e quello dei due cannoni che Garibaldi stesso aveva fatto piazzare in eccellente posizione, arrestano la foga del nemico.
La presenza del generale Garibaldi accompagnato da Fabrizi, da Menotti, da Canzio, da Mario, da Guerzoni e da altri, infonde nuovo ardire nei nostri; il generale ordina la carica alla baionetta—un urrà di gioia saluta il comando—e la carica fu generale, splendida pel risultato. Il nemico abbandona le posizioni, i nostri riacquistano le loro e si procede all'assalto di Villa Santucci, certi ormai della vittoria.
Ma vinti i papalini, altro nemico sconosciuto, fin allora rimasto invisibile, giungeva in quel punto, fresco di combattimento a rimpiazzare i vinti, venendo a fulminare di fianco con fuoco di fila mai interrotto i trafelati garibaldini.
Grandi masse nere si avanzavano intente ad impadronirsi dei dossi delle colline di sinistra coll'obiettivo evidente di tagliare la ritirata[291] su Monterotondo. I bravi garibaldini sparavano le loro ultime cartucce; ma era fuoco sprecato, perchè le nostre palle non arrivavano neppure alla metà della lunga linea percorsa dal nuovo nemico.
La resistenza era ormai impossibile—e Garibaldi visto il pericolo di essere in breve avviluppati, ordinava la ritirata su Monterotondo, che fu eseguita sotto il continuo grandinare delle palle dei soldati dell'imperatore dei francesi.
Giunto a Monterotondo Garibaldi pensò di organizzare la difesa asserragliandone l'entrata. Ma mancavano del tutto le munizioni avendo i bravi garibaldini consumata fin l'ultima cartuccia; quale difesa era possibile?
I prodi difensori del governo teocratico portarono a Roma, trofeo di vittoria, i due cannoni di Monterotondo, non nostri ma del Papa: e fu una mistificazione!
Portarono è vero dei prigionieri—ma anche questi con frode perchè violarono i patti della capitolazione segnata col comandante del Castello, i quali sancivano che tutti i garibaldini che si trovavano nel Castello e nelle case di Mentana dovevano essere compresi nella capitolazione e lasciati liberi di ritornare alle loro case.[292]
Per dare un'idea di come si svolse una parte dell'azione, ecco il rapporto del colonnello Elia al generale Fabrizi:
Rapporto del Comandante la 6a Colonna
al capo di Stato Maggiore del Comando Generale
Generale Nicola Fabrizzi.
Ancona, li 12 novembre 1867.
Generale,
"Rispondo all'invito diretto dalla S. V. a tutti i comandanti di Colonne che si trovarono presenti al combattimento di Mentana, inviandole questo rapporto sulla parte avuta nel combattimento suddetto, dalla 6a colonna da me comandata.
Alle ore 11 1/2 a. m. del 3 corrente mossi da Monterotondo alla testa della Colonna seguendo l'ordine di marcia prescrittami dal Comando Generale con ordine del giorno della sera precedente.
"Le mie forze, molto diradate dopo il ritorno a Monterotondo, si componevano del 18o Battaglione, ridotto a 195 uomini, comandato dal maggiore Perlach Pietro, del 19o comandato dal maggiore Cesare Ghedini forte di 200 uomini,[293] del 20o battaglione comandato da Cesare Bernieri forte di 340 uomini, rimasto a Monterotondo agli ordini del Comandante di quella piazza colonnello Carbonelli.
"Giunto al paese di Mentana verso la 1 p. m. dovetti fare alto essendomi impedita la marcia dai volontari della 3a colonna, che ci precedeva, comandata dal colonnello Valzania, i quali con un'ordinata contromarcia a sinistra passando avanti il nostro fronte si portavano a prendere posizione sulle colline a sinistra del paese. Da qualche ferito, che si vide passare, avemmo conoscenza che ci trovavamo in faccia al nemico e che ai posti avanzati eransi incominciate le fucilate. In quel punto mi venne ordine dal generale Garibaldi, trasmessomi dal suo aiutante capitano Coccapieller, di fare occupare da parte dei miei le case a sinistra di Mentana. Trasmisi l'ordine ai maggiori Perlach e Ghedini ed i nostri vi penetrarono risoluti a respingere ogni attacco del nemico. Vista eseguita tale operazione mi portai presso Garibaldi per ulteriori istruzioni. Egli trovavasi a metà del paese circondato dai vecchi compagni e dai suoi aiutanti, dando ordini pel combattimento. Vedutomi,[294] mi diede ordine di raccogliere le rimanenti mie forze e di spingermi con esse al di là delle case, che formano il lato sinistro del paese di Mentana, se vi si giunge da Monterotondo; ordinai ai miei, che non erano nelle case, di seguirmi in avanzata verso la parte più presa di mira dal nemico. Avevo con me i maggiori Perlach e Ghedini, l'aiutante maggiore Tironi, l'aiutante in seconda Barattini Filippo, l'ufficiale d'ordinanza Falaschini Pietro, il capitano Berti Antonio, il tenente Augusto Marinelli, il mio capo di stato maggiore capitano Boldrini, il capitano Canini dei Mille, il tenente Occhialini ed i sottufficiali Longhi, Zagaglia, Beretta, Melappioni, Berti, Pezzali, Leone Bucciarelli, Saltara, Beducci, Mariotti, Marinelli Luigi, Ferraioli ed i caporali Luigi Padiglioni, Cesare Burattini e l'aiutante del 18o battaglione sottotenente Luigi Carnevali. Si erano pure uniti a me i capitani Grassi e Ballanti. Altri volontari comandati da Salomone[1] e da Frigesy, fra i quali i bravi Buratti e [295] Giammarioli rafforzavano la posizione, fatta segno alle palle nemiche. Ordinai ai bravi che avevo con me, di spiegarsi in catena e rasentando le siepi, fiancheggianti la strada che taglia quei campi e conduce alla villa Santucci, spingersi in avanti nell'intento di sloggiare il nemico dalla villa occupata. I garibaldini rispondevano da bravi al fuoco nemico e gli ufficiali ne li incoraggiavano; eravamo fulminati dall'artiglieria e dal fuoco vivissimo delle carabine; più di un volontario era caduto al mio fianco e già feriti il mio aiutante in primo Tironi, il capitano Antonio Berti che bravamente rimasero al loro posto. La faccenda si faceva sempre più seria; mandai l'aiutante in seconda Burattini, onde riunisse quanti dei nostri potesse e li portasse con sè al fuoco, ma ritornò solo. Si era da ogni parte impegnati e non conveniva fare scendere i garibaldini che occupavano le case; privi di rinforzi ed incalzati[296] dagli Zuavi pontifici fin sotto le case di Mentana, riuniti intorno a me quanti più ne potei, ufficiali e soldati, ordinai una carica alla baionetta; coadiuvati dai nostri, che dalle case tiravano addosso agli assalitori e dal tiro dei cannoni che il Generale aveva fatto piazzare in buon posto, i miei, incoraggiati dagli ufficiali primi ad esporsi, si slanciano contro i papalini e sotto gli occhi di Garibaldi, di Fabrizi, di Menotti, di Ricciotti, di Canzio, di Mario e di altri bravi giunti sul posto in quel punto, mettono in fuga, incalzandoli colla punta della baionetta, gli assalitori. Fu un attacco brillantissimo, tanto che Canzio, che mi era venuto vicino, si congratulò con me pel risultato. Si credette per un momento alla vittoria.
"Ciò avveniva verso le 4 pom.; ma passato poco tempo ci vedemmo più fortemente attaccati in altro punto.
"Il generale Fabrizi, venerando patriota, esperto ed ardito soldato, si era trovato esso pure in quella pericolosa posizione, incoraggiando col suo esempio e sangue freddo al combattimento i nostri, i quali sfiniti da una lotta che durava da quattr'ore incessante, e qualche volta a corpo a corpo, bruciavano sul nemico in fuga le ultime[297] cartuccie. Attorno a Fabrizi stavano gli eroi di cento altri combattimenti, Missori, Guerzoni, Tanara, Bezzi; tutti studiavano le mosse del nemico, che credevano in ritirata; questo invece, cambiata tattica e direzione all'attacco, spingeva forti colonne sulle alture della nostra posizione di sinistra, difesa da Valzania, allo scopo di tagliarci la ritirata su Monterotondo.
"La natura dei tiri, la regolarità e rapidità dei medesimi, il fischio delle palle, tutto aveva cambiato. Non erano più le truppe papaline che si battevano contro i pochi ed estenuati garibaldini, privi ormai di munizioni; stavano di fronte ad essi i primi soldati del mondo che facevano le prime prove dei loro Chassepot sui petti dei patrioti italiani.
"La colonna Valzania stette salda finchè ebbe cartuccie da sparare contro il formidabile assalto; ma poi, sopraffatta da forze imponenti e ridottasi senza munizioni, dovette ripiegare. Abbandonata la posizione di sinistra fu giuocoforza ai nostri di battere con la maggiore celerità possibile in ritirata, per non essere tagliati fuori da Monterotondo.
"Non furono però in tempo di farlo i molti,[298] che trovavansi, per ordine avuto dal Generale, ad occupare le case ed il Castello di Mentana, i quali rimasero prigionieri e fra questi molti del 18o e 19o battaglione appartenenti alla mia colonna.
"Il 20o battaglione, pure facente parte della 6a colonna, rimasto a Monterotondo, fece anch'esso il suo dovere. Il bravo capitano Litta, che lo comandava in assenza del maggiore Bernieri, visto che a Mentana erasi impegnata con calore l'azione, allo scopo di garantire ai nostri la ritirata in caso di rovescio, portò la maggior parte delle sue forze ad occupare il convento dei Cappuccini situato in buona posizione sulla strada che va a Mentana, da dove potè arrestare la foga dei francesi, che si avanzavano seguendo i nostri, i quali poterono ritirarsi con ordine. Giovò non poco l'azione risoluta del capitano Raffaello Giovagnoli, che si trovava al Romitorio, da dove respingeva i ripetuti attacchi del nemico. Egli volle tentare un ultima controcarica alla testa di un centinaio di valorosi, che fecero prodigi. Molti di quei bravi caddero attorno al Giovagnoli colpiti dalle palle dei Chassepot dell'imperatore di Francia; fra quelli che[299] più si distinsero per valore, primeggiò il sottotenente Luigi Coralizzi, che riportava grave ferita alla testa da farlo ritenere per morto.
"Tutti fecero il proprio dovere. Gli ufficiali molto si distinsero per ardire e sangue freddo, nel condurre i volontari al combattimento.
"Non mi è permesso di dare preciso ragguaglio dei feriti e dei morti appartenenti alla mia colonna, stantechè, come già dissi, essendo una buona parte dei volontari rimasti entro le case occupate per ordine del generale Garibaldi, fu ad essi chiusa la ritirata su Monterotondo e caddero quindi prigionieri dei francesi. E potendo avvenire, che per la inesattezza delle notizie, io ommetta di comprendere fra i primi alcuni di quelli che sono ora prigionieri in Roma, mi è forza astenermi dal compilare la nota richiestami dalla S. V. Onorevolissima; però mi riserbo inviarla non appena per via di documenti e di esatte informazioni, sarò giunto a conoscere con sicurezza il vero stato delle cose.
"Frattanto le invio un primo elenco dei feriti e dei morti, che non mi fu difficile di compilare, essendo quasi tutti caduti a me vicini, mentre difendevano la importante posizione affidataci[300] dal generale Garibaldi. Morti, il capitano Grassi di Jesi, i tenenti Vianini Pietro di Alessandria, Mazzoni Giuseppe di Bologna, i furieri Giorgini Francesco di Sinigallia, Pezzoli Augusto di Bologna, i caporali del Frate Valentino di Fabriano, Cappuccini Pietro di Ancona, Luzzi Baldassare di Osimo, Toscani Domenico di Filottrano, Petravecchia Nicolò di Matelica. Feriti i capitani: Tironi Augusto aiutante maggiore, Berti Antonio di Ancona, Canini Cesare dei Mille, Ballanti Gaspare di Corinaldo, Zagaglia Carlo di Jesi; i tenenti Occhialini Serafino, Falaschini Pietro di Ancona, Montanari Giovanni di Bagnacavallo, Campagnoli Aldebrando di Ancona; i furieri Elia Leopoldo di Ancona, Berti Raffaele di Ancona, Pezzoli Augusto di Bologna, Gatti Filippo di Jesi, i sergenti Marchetti Virgilio di Ancona, Fida Camillo di Fabriano, Bernani Cesare di Fabriano; i soldati Marsili Luigi di Osimo, Sileoni Tita di Osimo, Nigretti Federico di Bagnacavallo.
Il comandante la 6a colonna
Col. A. Elia.
Dopo il sanguinoso combattimento e la ritirata, il generale fu per lungo tempo deciso a[301] continuare la resistenza in Monterotondo. Non voleva sentire parlare di ritirata "La nostra bandiera é Roma o Morte. Non siamo andati a Roma dobbiamo morire qui!" diceva. Ma i comandanti di colonna, credettero loro dovere d'insistere nell'interesse della patria, e vollero che l'Elia assumesse l'incarico del tentativo ad essi fallito.
Fu con fatica che Elia poté persuadere il generale, che la vita sua e dei suoi doveva essere conservata all'Italia. Il generale scosso domandò se Fabrizi, Menotti e Ricciotti erano rientrati, ed avendo Elia risposto affermativamente, questi gli diede l'incarico di ordinare la ritirata su Passo-Corese. La ritirata fu eseguita senz'essere punto molestata e si passò la notte sul territorio ancora tenuto dal papa per virtù dell'intervento dei soldati dell'imperatore dei francesi.
Quando al mattino il generale entrava nel territorio italiano, il primo che gli si presentò fu il colonnello Caravà, già suo ufficiale, allora comandante del 4o granatieri di guardia al confine, il quale durante la campagna si era fraternamente interessato, in tutti i modi possibili,[302] permessigli dalla disciplina, de' nostri sbandati e dei nostri feriti. Garibaldi gli porse la mano e gli disse:
"Colonnello, siamo stati battuti, ma potete assicurare i nostri fratelli dell'esercito che l'onore delle armi italiane è salvo".
Eloquente epigrafe di quella campagna, che, nel 1899 ebbe il battesimo di riconoscimento, allorchè per volontà del parlamento fu riconosciuta campagna nazionale.
Dippoi si fece la consegna delle armi da parte dei soldati volontari alle truppe italiane.
Quando i compagni presero congedo dal generale che saliva sul treno per Firenze tutti erano commossi; Elia gli disse:—"Non tarderà altra occasione—ricordatevi di me generale!". Ed Egli tenendogli la mano fra le sue, rispondeva:—"Mi ricorderò di voi, come della mia sciabola".
Mentana può considerarsi come uno di quei casi fatali, che affrettano i destini di una Nazione; come un olocausto inevitabile, necessario! Questo glorioso combattimento, anche una volta dimostrò che gl'italiani si battevano: 4000 garibaldini,[303] male armati, quasi senza munizioni, affamati tennero gagliardamente testa a 5000 papalini ed a 4000 francesi, armati di Chassepot, tenendoli a rispettosa distanza per mezza giornata e facendo pagar cara la loro vittoria.
Sul principio del 1870, scoppiavano una dietro l'altra, le notizie dell'anno terribile; l'antico duello tra Francia e Germania ripreso; il primo esercito francese distrutto a Worth e a Gravelotte; il secondo annientato a Sedan; l'imperatore stesso fatto prigioniero; l'impero caduto e in Francia la repubblica proclamata; gli eserciti di Germania sotto le mura di Parigi.
La Francia, troppo grande per darsi vinta, faceva sforzi eroici per rialzarsi.
Mentre il governo italiano spinto dall'unanime sentimento del partito liberale si apprestava alla conquista di Roma, Garibaldi offriva la sua spada alla repubblica francese. Ma al governo della difesa nazionale non giunse gradita l'offerta, e l'avrebbe respinta se il generale Bordone,[304] amico di Garibaldi, non si fosse assunto l'incarico e la responsabilità di scrivergli che sarebbe stato accolto a braccia aperte dal popolo francese.
Saputo che il generale voleva andare in Francia, Elia, che con molti altri era pronto ad accompagnarlo, gli scriveva che esso e i compagni aspettavano una sua chiamata, desiderosi di seguirlo; contemporaneamente scriveva all'amico Canzio che così rispondevagli:
Genova, 28 settembre 1870.
Mio carissimo Elia,
"Il generale è prigioniero a Caprera e Menotti a Catanzaro, e in Francia non ci vogliono.
"Codesti novelli Bruti, che oggi reggono la cosa pubblica in Francia, vogliono diplomatizzare e non pensano a prepararsi a lotta suprema, che abbia per obbiettivo, la cacciata dell'invasione straniera.
"M'ingannerò, ma essi non servono, come dovrebbero, la Francia e la causa repubblicana.
"Alla generosa e patriottica offerta del generale non risposero ancora; allo slancio dei volontari contrappongono ordini rigorosissimi ai consoli e ai confini donde siamo rimandati.[305]
"Domani avrò lettera dal generale e ordini suoi, che immediatamente ti comunicherò; per ora io ti consiglio a non muoverti.
"Saluto gli amici.
"Aff.mo tuo
"S. Canzio".
E così Elia e gli amici, che sarebbero andati con lui, non si mossero.
Coloro che seguirono il generale Garibaldi tennero alto anche una volta il valore italiano fugando a Digione le schiere degli invasori, vendicando in modo così generoso il fratricidio della repubblica Romana ed il fatto di Mentana.
Nobile sangue italiano fu versato sul suolo francese ed è titolo di gloria il rammentare, che l'unico trofeo che si conserva in Francia di quella guerra disastrosa, è la bandiera del 61o reggimento prussiano strappata sotto un grandinare di palle dai garibaldini, comandati da Ricciotti Garibaldi.
Ecco quello che Garibaldi dice nel suo libro: "Memorie Autobiografiche" della Campagna di Francia.
"Il governo della difesa nazionale, composto di tre onesti individui meritevoli della fiducia[306] del paese, mi accolse perchè imposto dagli avvenimenti, ma con freddezza; coll'intenzione manifesta di volersi servire del mio povero nome, ma non altro; privandomi dei mezzi necessari a che la cooperazione mia potesse riuscire utile.
"Gambetta, Cremieux, Glain-Bizoin individualmente furono con me gentili; ma il primo, più di tutti, da cui avrei dovuto aspettarmi un concorso energico, mi lasciò in abbandono durante un tempo prezioso.
"Nei primi di settembre 1870 fu proclamato il governo provvisorio in Francia, ed io il 6 di quel mese offrii i miei servizi a quel governo; e quel governo stette un mese senza rispondermi; tempo prezioso in cui si sarebbe potuto far molto, e che fu intieramente perduto.
"Solo ai primi di ottobre seppi che sarei stato accolto in Francia, ed il generale Bordone, a cui solo si deve la mia accettazione, venne a cercarmi in Caprera col piroscafo la Ville de Paris, capitano Condray, sul quale giunsi a Marsiglia il 7 ottobre.
"Esquiros, prefetto dell'illustre città e la popolazione entusiasmata mi accolsero festosamente; un telegramma del governo di Tours mi chiamava immediatamente presso di sè.[307]
"A Tours perdetti vari giorni per l'indecisione del governo, e mi trovai sul punto di dovermene tornare a casa, perchè compresi che ero poco gradito; l'incarico che si voleva darmi, quello di organizzare alcune centinaia di volontari italiani che si trovano a Chambery ed a Marsiglia, lo dimostrava.
"Dopo controversie coi signori del governo, mi recai a Dôle per raccogliervi quegli elementi d'ogni nazionalità che dovevano servire di nucleo al futuro esercito dei Vosges.
"I Prussiani marciavano su Parigi dopo Sédan, e naturalmente sul loro fianco sinistro, ove s'addensavano le nuovo reclute della Francia, essi dovevano tenere dei fiancheggiatori, e questi più volte comparvero sino nei dintorni di Dôle, ove tenevo pochi uomini in via d'organizzazione, poco equipaggiati, e, quel che è peggio, per molto tempo male armati; il nostro contegno, comunque, fu energico, prendendo posizione a Mont Rolland prima, e poi nella Foret de la Serre, dimodochè Dôle rimase inviolata per tutto il tempo che noi vi soggiornammo.
"Da Dôle ebbi ordine in novembre di portarmi colla mia gente nel Morvan, minacciato[308] dal nemico, assieme all'importante stabilimento metallurgico del Creuzot.
"Io scelsi Auton per porvi il mio quartier generale; l'arrivo degli Italiani di Janara e di Ravelli, di alcuni Spagnoli, Greci, Polacchi, e di alcuni battaglioni di mobili cominciò a rialzare l'effettivo del nostro piccolo esercito, perchè avemmo alcuni pezzi da montagna, due batterie di campagna e alcune guide a cavallo; la maggior parte d'italiani.
"Si organizzarono tre brigate; la prima comandata dal generale Bossack; la seconda dal colonnello Delpeck che poi passò sotto gli ordini del colonnello Lobbia, e la terza comandata da Menotti; la quarta brigata sotto il comando di Ricciotti, si componeva da principio di sole compagnie di franchi tiratori, operanti in colonne volanti, e sull'ultimo della campagna venne accresciuta con alcuni battaglioni di mobilizzati. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito fu il generale Bordone, che in occasione di mia infermità supplì me stesso in ogni circostanza; Capo del mio quartier generale fu il colonnello Canzio, sinchè prese il comando della quinta brigata alla quale aggiunsi la prima, dopo la morte del generale[309] Bossack; comandante dell'artiglieria fu il colonnello Olivier.
"I due nostri squadroni di guide furono comandati dal Forlatti; il dottore Timoteo Riboli fu capo dell'Ambulanza; comandante di piazza presso il quartier generale il tenente colonnello Demag; capo del genio il colonnello Gauklair.
"Con tale organizzazione alquanto improvvisata, movemmo verso la metà di novembre per Arnay-le-Duc e la Valle dell'Ouche che scende a Dijon, ove si trovava l'esercito prussiano di Werder che minacciava la vallata del Rodano, e che teneva i suoi avamposti verso Dôle, Nuits, Soubernon, taglieggiando con delle scorrerie tutti i paesi circonvicini.
"Il sedicente esercito dei Vosges, forte di circa ottomila uomini, marciava dunque contro l'esercito vittorioso di Werder di circa ventimila uomini con molta artiglieria e cavalleria.
"I nostri tiratori impegnarono subito varie scaramuccie di non grande rilievo, eccettuata la brillante impresa di Ricciotti su Châtillon sur Seine, e quella d'Ordinarie. Nella prima, i franchi tiratori della quarta brigata eseguirono una magnifica sorpresa, la quale è narrata nell'ordine del giorno seguente:[310]
ORDINE DEL GIORNO
"I franchi tiratori dei Vosges, i cacciatori dell'Isêre, i cacciatori delle Alpi (Savoiardi), il battaglione del Doubs, ed i cacciatori dell'Hâvre che sotto la direzione di Ricciotti Garibaldi han presa parte all'affare di Châtillon, hanno ben meritato della Repubblica.
"In numero di quattrocento essi assalirono circa mille uomini, li sconfissero, fecero loro centosessantasette prigionieri, fra cui tredici ufficiali, presero ottantadue cavalli sellati, quattro vetture d'armi e munizioni e il carro della posta. I nostri ebbero sei morti e dodici feriti, assai più i nemici. Raccomando i prigionieri alla generosità francese.
"Arnay-le-Duc, 21 novembre 1870.
G. Garibaldi".
"Eravamo alla metà di novembre e nulla si era ancora da noi operato d'importante; qualche cosa conveniva fare.
"Misurarsi in un attacco di giorno contro l'esercito di Werder che occupava Dijon, sarebbe stata una stoltezza, si poteva fare un tentativo di notte. Di notte la diversità delle armi spariva,[311] giacchè anche in Francia c'eran toccati i soliti ferracci, e questi nelle tenebre potevano sembrare fucili ad ago, con cui erano armati i nemici; oltre che io avevo per massima che non si deve sparare in un attacco di notte, massime da militi nuovi.
"La mattima del 26 novembre, essendo io montato a cavallo a Lantenay per riconoscere quell'altipiano, mi trovavo con lo Stato Maggiore su quelle alture, quando una colonna di più migliaia di prussiani con le tre armi, uscita da Dijon, avanzavasi per la strada maestra verso noi.
"Ordinai a tutte le forze che si trovavano nel villaggio di Lantenay di salire sull'altipiano, e le collocai di mano in mano che arrivavano nei loro posti di battaglia, a destra e sinistra della strada per cui giungevano, lasciando sulla stessa strada alcuni battaglioni in colonna come riserva, e per una carica decisiva, in caso che il nemico si spingesse sino alle nostre linee. La maggior parte della terza brigata, che formava il nerbo delle nostre forze, occupava la sinistra schierata sull'orlo del bosco, con le sue linee di tiratori in fronte sul ciglione della collina che dominava il bosco stesso. Le riserve nella strada appartenevano esse pure alla terza brigata.[312]
I carabinieri genovesi erano collocati all'estrema sinistra, e la nostra artiglieria composta di una batteria di campagna, da 4 rigata e di due batterie da montagna, si era collocata alla sinistra dei genovesi in posizione dominante tutte le altre.
"Sulla nostra destra eranvi i franchi tiratori di Lhost che furono poi rinforzati da quei di Ricciotti. La poca cavalleria composta di trenta cacciatori e di alcune guide, s'era collocata in fronte del centro nostro in una depressione del terreno. Si aveva una forza di cinquemila uomini in tutto.
"Nel combattimento di Lantenay, 26 novembre 1870, non prese parte nè la prima nè la seconda brigata. La prima, perchè nel giorno anteriore, verso Fleury in conseguenza di quel combattimento, erasi ritirata su Pont de Pany. La seconda era in marcia ed arrivò il 27 a Lantenay.
"Il reggimento Ravelli della terza brigata, composto d'italiani, era pure assente, trovandosi verso l'Ouche.
"Occupato Paque dal nemico, io feci avanzare due pezzi della nostra artiglieria sostenuti da alcune linee di tiratori, che cacciarono con pochi tiri il nemico dal villaggio.[313]
"Mentre ciò succedeva, i Prussiani avevano fatto gran mostra delle loro forze schierandole sulle dominanti alture di Prenois. Mentre il loro battaglione si ritirava con precipitazione da Paques, appena sostenuti da alcuni pezzi, non fecero avanzare la superba linea che stava in riserva—"Dunque essi non sono in gran forza!" ecco il ragionamento che io mi feci subito—"Non vengono? ebbene andiamo noi a trovarli".—Mi decisi quindi di attaccarli, e marciammo risolutamente contro il nemico, colla stessa ordinanza di battaglia con cui lo avevamo aspettato nelle posizioni nostre.
"I nostri franchi tiratori di destra caricarono la sinistra nemica bravamente, minacciando di avvolgerla. La terza brigata avanzava in ordine perfetto, colle sue linee di bersaglieri al fronte, seguita da colonne di battaglioni così serrate da destare invidia ai soldati i più agguerriti.
"Io andavo superbo di comandare tale gente contemplando la bell'ordinanza su di un campo di battaglia vero, e tanta intrepidezza da parte dei miei giovani fratelli d'armi.
"Le artiglierie nemiche collocate sulle alture di Prenois, fulminavano le nostre linee, come sanno[314] fare i pezzi prussiani; eppure non si scorgeva nei centri la minima esitazione; nessuna ondulazione nelle linee, ammirabile il loro contegno; l'energia, la fermezza e la fredda bravura delle truppe repubblicane, scossero l'impassibile intrepidezza dei vincitori di Sédan; e quando essi videro che non si temevano le loro granate, ma si avanzava coraggiosamente e celeramente alla carica, cominciarono la loro ritirata su Dijon. Due sole nostre compagnie che avevano fiancheggiato il villaggio sulla destra in sostegno della nostra cavalleria, caricarono insieme un battaglione di riserva prussiana, che con due pezzi d'artiglieria era rimasto indietro, per proteggere la ritirata, cagionandogli forti perdite. Si distinsero in quella carica il colonnello Canzio ed il comandante Boudet, che entrambi ebbero morti i cavalli.
"Lo spirito dei miei militi era stupendo; eravamo stati sì felici nella giornata che io presi la risoluzione di tentare un colpo disperato, che riuscendo avrebbe potuto rialzare le sorti della sventurata repubblica e forse obbligare il nemico ad abbandonare l'assedio di Parigi, vedendosi minacciato sulle principali sue linee di comunicazione.[315] Ma quali mezzi aveva posti in mia mano il governo della difesa? Io rabbrividisco pensandovi! Era troppo presumere, sperando una vittoria! Però in una notte piovosa della fine di novembre pensai di fare un tentativo, confidando che in caso di non riuscita avremmo avuto tempo sufficiente per ritirarci: decisi l'attacco. L'inaspettata aggressione produsse in Dijon una qualche confusione; ma, sia detto in onore della Germania, i numerosi corpi ivi stanziati, scaglionaronsi prontamente nelle forti posizioni di Talant, Fontaine, Hauteville, Daix e ci ricevettero con una grandine tale di fucilate, come non vidi mai l'eguale.
"I miei giovani militi tennero testa e compirono quanto si poteva compiere in tale circostanza. I posti esterni dei prussiani furono assaliti uno dopo l'altro, conquistati e distrutti malgrado una fiera difesa.
"La mattina i nostri cadaveri si trovavano ammonticchiati sui cadaveri dei nemici, la maggior parte di questi forati da bajonette, giacchè l'ordine era di non sparare.
"Giunti, sotto Talant, il fuoco nemico era troppo formidabile per poterlo superare e si dovette[316] ripiegare a destra ed a sinistra della strada maestra, per scansare i tiri diretti che la solcavano orribilmente e facevano strage.
"Il nostro assalto alle posizioni di Dijon cominciò verso le sette pomeridiane; era molto buio e tempo piovoso. Sino alle 10 ebbi molta fiducia di riuscire; ma scorsa quell'ora i capi della mia avanguardia mi fecero sapere essere inutile persistere nell'assalto, essendo spaventosa la resistenza del nemico ed impossibile fare avanzare la nostra gente. Con reluttanza mi dovetti conformare alle asserzioni dei miei fidi e dovetti ordinare la ritirata che per essere di notte potè effettuarsi senza perdite. Il nemico non si mosse dalle sue posizioni e noi non fummo disturbati.
"Luogo di concentramento di tutti i corpi in ritirata del sedicente esercito dei Vosges su Autun.
"Il 1o decembre il nemico, imbaldanzito dalla nostra ritirata, venne di sorpresa ad attaccarci ad Autun. Collocate le loro artiglierie sulle alture di Saint Martin cominciarono a fulminarci—Era verso il mezzogiorno.
"Feci collocare i nostri diciotto pezzi in posizione dominante quella nemica e questi serviti[317] con ardore e bravura dai nostri giovani artiglieri, tempestarono di projetti l'avversario e lo obbligarono dopo più ore di combattimento, a portare indietro i propri pezzi.
"Alcune compagnie di franco tiratori ed alcuni battaglioni di mobili lanciati sul fianco sinistro dei Prussiani, completarono la giornata, ed il nemico fu obbligato a ritirarsi.
"A Autun servimmo di cortina e protezione ai due movimenti di fianco che si operarono da Chagny a Orleans dal generale Crousat, e dal grande esercito della Loira, comandato dal generale Bourbaky verso l'est. In conseguenza del movimento del generale Bourbaky, i prussiani abbandonarono Dijon, e noi l'occupammo con alcune compagnie di franchi tiratori e dipoi con tutte le nostre forze".
Prima di abbandonare Autun il generale consegnava a suo figlio Ricciotti il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
"Partendo da Autun devi pigliare la direzione di Sémur e di Montbard per turbare le comunicazioni del nemico, il quale occupa Troyes e Auxerre, e di quello che occupa Dijon.[318]
"Potendo arrivare a Montbard, Châtillon, Chaurmont, Neufcháteau, sulla gran linea delle comunicazioni dell'inimico, la quale va da Strasburgo a Parigi, l'operazione diventerà molto più ardua e più importante.
"All'uopo di compiere con successo tale missione ci vogliono militi ad hoc, cioè uomini forti ed agili; quanti nol fossero debbono rimanere ad Autun nei depositi, ove serviranno di nocciolo per l'istruzione dei nuovi franchi tiratori.
"Sorpassati gli avamposti del nostro esercito verso il nord, i tuoi movimenti hanno sempre ad effettuarsi di notte.
"Che l'aurora ti trovi sempre imboscato preferibilmente nei lembi dei boschi, sempre pronto a sorprendere gli esploratori nemici, i loro corrieri, o le loro vettovaglie, e sempre a portata dei boschi e delle montagne, per assicurarti la ritirata.
"Non essendo punto possibile il trar carri e muli con munizioni di riserva, ciascun milite deve curare diligentemente le proprie cartuccie, epperò sparare di rado e bene.
"Ti raccomando severissimamente un buon contegno cogli abitanti, i quali devono amare e[319] stimare i militi della repubblica. Amati dagli abitanti si avranno facilmente buone guide, il che non deve mai mancarti, come pure esatte informazioni delle posizioni del nemico, delle sue forze, ecc.
"Giunto sulle linee di comunicazioni di lui, urge distruggervi le vie ferrate e i telegrafi.
"Venendoti fatto di distruggere quella da Strasburgo a Parigi, sarebbe un vero colpo di mano.
"Mi riprometto da te ogni notizia che possa interessarmi, sia mediante telegrafo, sia in qual'altro modo che ti sarà possibile.
"Ottocento uomini sono troppi per tenerli tutti uniti; bisogna dunque suddividerli, e non adoperarli uniti, che quando si tratti di un fatto serio.
"Epperò tu devi a tal'uopo munirti di buone carte dei luoghi e dei dipartimenti che occupi, le quali tu domanderai alle autorità municipali.
"Incalzato, o inseguito da forze superiori, spartirai i tuoi in tanti piccoli distaccamenti, i quali inganneranno il nemico, pigliando direzioni diverse, e ai quali tu indicherai un punto di ricongiungimento.
"Autun, 11 novembre.
G. Garibaldi"
[320]Questo dispaccio è di una grandissima importanza storica, giacchè si è tentato di accusare Garibaldi di non avere prestato il suo concorso all'armata dell'est comandata dal generale Bourbaky, mentre le mosse eseguite da Garibaldi, sostenute da combattimenti, provano il contrario.
I fatti furono i seguenti:
Il generale Bourbaky, comandante l'armata dell'est (quello che passò in Svizzera con 120,000 soldati francesi) si era mosso per accorrere in aiuto di Belfort, piazza fortificata fra il Doubs e l'Oignon nei Vosgi; mossa ardita che avrebbe invertite le sorti della Francia, se questa manovra fosse riuscita.
La stampa francese volle censurare il generale Garibaldi nientemeno di tradimento, per avere permesso, secondo essa, al corpo del generale Manteuffel di intercettare la linea d'operazione.
Importa notare: che la marcia del generale Menteuffel avvenne nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1871, giorni di sanguinosi combattimenti per l'esercito dei Vosgi forte di 20.000 combattenti italiani, spagnoli e francesi, trattenuti dalla forze imponenti del generale Kettler.
[321]Il giorno 24 fu impiegato a riordinare le truppe alquanto scompaginate dai combattimenti. Il giorno 25 di primo mattino il colonnello Baghina partiva con gli ordini ricevuti alla testa di 12 compagnie ed un mezzo squadrone di cavalleria alla volta di Auxosnne, e la sera del 26, il Monte-Roland, chiave di Dôle cadeva in potere delle truppe comandate dal Baghina, per il qual fatto la via di ritirata a sud-ovest era aperta all'armata del Bourbaky.
Questo avveniva per le disposizioni strategiche e previdenti di Garibaldi, mentre la divisione comandata dal Crenier villeggiava inoffensiva tra Gray, Vesoul e Montebouzon, senza utilità alcuna per la Francia.
E il generale Garibaldi continua così:
"Il movimento del generale Bourbaky ben ideato era d'impossibile esecuzione, perchè le condizioni di quel grande esercito erano assolutamente disastrose.
"Venti giorni di più di organizzazione o di riposo, passata la terribile stagione della neve e dei ghiacci di gennaio, quel numeroso e giovane esercito avrebbe potuto ravvivare le speranze[322] della Francia esausta e prostrata: invece esso fu sprecato e distrutto in modo orribile.
"Il movimento di Manteuffel parallelo a quello di Bourbaky, per ingrossare le forze di Werder e degli assedianti di Belfort, mi era noto: e io avrei fatto tutto il possibile per arrestarlo nella sua marcia di fianco. Mi vi provai, ed ero uscito da Dijon col nerbo delle mie poche forze per attaccare il nemico a Is-Sur-Till, lasciando al comando della città il generale Pellisier; ma le forti colonne che mi stavano di fronte mi persuasero a ripigliare le primitive posizioni: nondimeno due delle mie quattro brigate, la seconda e la quarta, operavano sulle comunicazioni del nemico, congiuntamente a tutte le compagnie dei miei franchi tiratori.
"Deciso di difendere Dijon, la mia prima cura fu di continuare le opere di fortificazione che erano state incominciate dai Prussiani.
"Le posizioni di Talant e Fontaine che dominano la strada principale che va a Parigi, furono le prime ad essere coronate da opere volanti e vi si collocarono a Talant due batterie di campagna da 12 e due da 4, a Fontaine una batteria di 4 di campagna ed una di montagna[323] dello stesso calibro. Altre batterie da 12 si collocarono in altre opere innalzate a Montemuzard Monthappè, Bellair, e in altre posizioni nella cinta di Dijon, per tener lontani i fuochi del nemico in caso di attacco, che io mi aspettavo da un giorno all'altro.
"Difatti il 21 gennaio il nemico ci attaccò dalla parte di ponente.
"Con forti posizioni, coperte da muri e ripe, con linee di tiratori a destra e a sinistra della strada maestra, e con trentasei pezzi di artiglieria collocati sulle formidabili posizioni di Talant e Fontaine, la nostra difesa riuscì brillantissima. La formidabile colonna che ci venne dalla parte di Parigi poteva ben chiamarsi una colonna di acciaio! Furono appena bastanti a fermarla i nostri trentasei pezzi infilanti la strada e varie migliaia dei nostri migliori tiratori, distesi dietro i ripari. L'attacco fu veramente formidabile; io vidi in quel giorno soldati nemici, come mai avevo veduti migliori. La colonna che marciava sulle nostre posizioni dal centro, era ammirabile di valore e di sangue freddo. Essa ci giungeva sopra, compatta come un nembo a passo non accelerato, ma uniforme, con un ordine ed una pacatezza spaventevoli.[324]
"Questa colonna, battuta da tutte le nostre artiglierie in infilata e da tutte le linee di fanteria in avanti di Talant e Fontaine lateralmente alla strada, lasciò il campo coperto di cadaveri, e per varie volte riordinandosi nelle depressioni del terreno, essa ripigliava l'attacco, collo stesso ordine e pacatezza ammirevole.
"Che famosi soldati!
"Molto valore mostrarono pure i nostri in quella memoranda giornata e furono veramente degni dei nemici che ci assalivano.
"La battaglia durò dalla mattina sino al tramonto, con quanto accanimento fosse possibile da una parte e dall'altra e senza vantaggio marcato di nessuno. Al tramonto noi eravamo padroni delle nostre posizioni ed il nemico stava nelle sue.
"Il 22 l'attacco si ripetè con eguale accanimento; la valanga dei prussiani era sì grande che fummo minacciati d'esserne sepolti.
"Verso la metà della giornata, ci minacciarono di un attacco su Fontaine, e v'inviarono alcuni battaglioni, fingendo un assalto, ma subito dopo comparvero a settentrione sullo stradale di Langres in due colonne, e con altre forti colonne[325] di fiancheggiatori da Levante verso Montmuzard, a Saint-Apollinaire.
"L'attacco sulla via di Langres fu formidabile, degno del terribile esercito che ci stava di fronte; quasi tutti i nostri corpi piegavano, meno la quarta brigata che si sostenne fortemente in una fabbrica di nero animale, munita di un chiuso, ove si eran praticate delle feritoie. Alcune centinaia di militi della terza brigata in formazione, già decimata nel combattimento del 21, sostennero pure l'urto in uno stabilimento contiguo più indietro e si riunirono poi alla quarta. Questi corpi rimasero per un pezzo avviluppati dal nemico, per la ritirata della nostra ala destra.
"Avendo il nemico collocate le sue artiglierie sulla prima collina che domina Pouily e Dijon a tramontana e tirando con quella maestria a cui ci avevano assuefatto i prussiani, smontarono in poco tempo tutti i nostri pezzi del centro collocati sullo stradale e lateralmente, rispondendo con qualche tiro da parte nostra i due pezzi di Montmuzard, e due del Montechappè ed altri due che si collocarono su di una strada obliqua allo stradale sulla destra, quando si vide l'impossibilità di tenerli nella prima posizione, fulminata dalle artiglierie nemiche.[326]
"Verso il tramonto la nostra situazione era delle più critiche; i prussiani padroni del campo, minacciavano di assaltare la città. Ai nostri corpi che si ritiravano si procurava di assegnare posizioni più indietro presso la cinta, con buoni recinti alcuni dei quali muniti di feritoie; ma invano: questi presi da panico non pensavano che mettersi in salvo, spargendo l'allarme in città e lo spavento dovunque.
"La nostra estrema sinistra, formata per la maggior parte della terza brigata, e situata a Talaut e Fontaine, alla vista della ritirata del centro, aveva spinto i suoi franchi tiratori sulla destra nemica, e marciava risolutamente per sostenerlo; sull'imbrunire alcuni corpi di mobilizzati sulla nostra destra, spiegandosi energicamente su Pouilly, obiettivo principale del campo di battaglia, ricacciarono il nemico dal terreno conquistato, e lo respinsero sino al di là del Castello. In tal modo la quarta brigata, cui si doveva l'onore della pugna, venne sbarazzata dal nembo nemico che l'aveva avvolta da un pezzo; anzi, onore maggiore, nel respingere i reiterati assalti del 61o reggimento prussiano, e combattendo corpo a corpo, essa pervenne[327] a togliergli la bandiera che, eroicamente difesa e sepolta sotto un monte di cadaveri, fu con altrettanto ardimento conquistata dai nostri, che la vollero trofeo del valore italiano.
"Io mi sono trovato presente a pugne ben micidiali, ma certamente, poche volte ho veduto sì gran numero di cadaveri ammonticchiati su piccolo spazio, come ne vidi in quella posizione a tramontana, occupata dalla quarta brigata e da parte della quinta.
"Nelle prime ore della notte il nemico era in piena ritirata, e per vari giorni ci lasciò tranquilli a Dijon avendo sgombrato pure i villaggi circostanti che furono occupati da noi.
"Le notizie dell'armistizio, e poscia della capitolazione di Parigi, e finalmente l'emigrazione dell'esercito di Bourbaky in Svizzera, cambiarono la faccia delle cose.
"Il nemico, libero dall'assedio di Parigi e dell'esercito dell'Est passato in Svizzera, cominciava ad ammassare su di noi forze imponenti, e, malgrado tutte le opere di difesa da noi eseguite, esso avrebbe finito per ischiacciarci ed attorniarci, come aveva fatto a Metz, a Sedan, ed a Parigi.[328]
"Per ordine del governo di Bordeaux dovevasi trattare coi Prussiani per l'armistizio, ed il generale Bordone capo del mio stato maggiore, si recò più volte al campo nemico; ma il risultato della sua missione fu, che per noi non vi era armistizio.
"Dal 23 gennaio al 1o febbraio ci tenemmo come meglio si potè nella capitale della Borgogna in tutte le nostre posizioni. Il nemico aveva capito che per scuoterci occorrevano grandi forze, e ne accumulava molte, tanto che alla fine di gennaio, le sue colonne occupavano con grandi masse il nostro fronte, e cominciavano a stendersi per avviluppare i nostri fianchi. L'esercito di Manteuffel, libero di quello dell'est di Bourbaky, scendeva verso la vallata del Rodano, e minacciava la nostra linea di ritirata.
"Il 31 gennaio si cominciò a combattere verso la nostra sinistra dal mattino, e si continuò sino a notte avanzata. Il nemico ci tastava su vari punti, prendendo posizioni al di fuori di Dijon per un attacco generale. Alcuni corpi prussiani mostravansi nella valle della Saone, minacciando di prenderci a rovescio per la nostra destra.[329]
"Non v'era tempo da perdere. Noi eravamo l'ultimo boccone, che avidamente solleticava il grande esercito vincitore della Francia, e voleva farci pagare cara la temerità di avergli contrastato per un momento la vittoria.
"Ordinai la ritirata in tre colonne: la prima brigata comandata da Canzio, a cui s'era aggregata la quinta, doveva scendere parallelamente alla strada ferrata di Lione, proteggendo l'artiglieria pesante e il nostro materiale che marciavano in vagoni. La terza brigata con Menotti s'incamminò per la vallata dell'Ouche verso Autun. La quarta preso la via di Saint-Jean di Losne, per la sponda destra della Saone verso Verdun. Il quartiere generale partì in via ferrata dopo avere fissato a Chagny il punto centrale della riunione dell'esercito; i vari altri corpi e compagnie di franchi tiratori distaccati dalle brigate, furono pure dirette al punto di convegno.
"Tutto fu eseguito col migliore ordine possibile, grazie all'attività del capo di stato maggiore, del comandante generale d'artiglieria colonnello Olivier, e dei comandanti dei corpi, senza essere molestati dal nemico.[330]
"Da Chagny il quartier generale passò a Chalons sur Saone, poi a Courcelles".
Dopo la vittoria di Lantenay e la ritirata di Dijon, il generale Garibaldi emanò il seguente proclama:
Ai prodi dell'Esercito dei Vosgi.
"Voi avete certamente la coscienza d'avere compiuto il vostro dovere. Dopo d'aver valorosamente combattuto un nemico superiore di forze per due giorni, voi non abbandonaste il vostro posto d'onore ad onta delle fatiche, delle privazioni e dei rigori di una stagione orribilmente piovosa e fredda.
"Il vostro coraggioso esempio servirà alle giovani milizie che hanno abbandonato il loro posto per inesperienza, e insegnerà loro d'ora innanzi a tenersi più compatte e più costanti, nella missione onorevole che la Francia repubblicana ha loro affidata.
"La grande repubblica Americana combattè quattordici anni contro i suoi oppressori e sul principio della lotta le sue milizie non erano più agguerrite delle nostre.
"Nel 1789 i quattordici eserciti che presero[331] le armi in Francia, erano nuovi alle pugne, e fino a Fleurus, Walmy e Iammapas essi pure furono respinti dagli stessi eserciti che noi combattiamo, e tuttavia finirono per riuscire vittoriosi in tutta Europa.
"Onore a voi dunque, miei prodi di Commarin, che, servendo la santa causa della repubblica, sapeste mostrare ai vostri giovani compagni la via del dovere e della vittoria.
Commarin, 29 novembre.
G. Garibaldi"
E dopo ciò, documento storico importantissimo, ecco l'ultime disposizioni che il generale Garibaldi impartiva al Baghina—prova dì quella serenità di spirito e di quella fierezza di carattere che non ebbero i comandanti francesi.
Commendateur Baghina
Auxonne
"Restez sur les positions a fin de constater occupation et de me reinseigner exactament sur sa situation. Conseigne sévère aux avantpostes, aucune communications sous quelque preteste que ce soit avec ennemi.[332]
"Ligne de demarcation bien determinée par les villages De Peintre, Chevigny, Rainaus, Biarne, S. Vivon, on vous pouvez piacer vos détachement.
Dijon 30 Janvier
G. Garibaldi.
La capitolazione di Parigi essendo un fatto compiuto, e l'armistizio trasformato in preliminari di pace, dopo d'essere stato il generale eletto deputato all'assemblea di Bordeaux, egli decise 1'8 febbraio di recarsi in quella città coll'unico intento di portare il suo voto alla repubblica, lasciando Menotti provvisoriamente al comando dell'esercito.
"Tutti sanno come fui accolto dalla maggioranza dei deputati, all'assemblea; certo quindi di non potere far più nulla per quel grande e sventurato paese che ero venuto a servire nella sciagura, mi decisi di recarmi a Marsiglia e di là a Caprera, ove giunsi il 16 febbraio 1871."
La caduta dell'impero francese ci apriva la via di Roma; gli animi ritornavano all'antica speranza di dare la sua capitale alla nazione:[333] Ma il governo titubava; ecco alcune lettere che danno luce a quel fatto storico della più grande importanza per l'Italia:
Carissimo amico Elia
Ancona
"È urgente per l'esistenza e l'avvenire d'Italia che si trasporti la capitale a Roma, senza dilazione.
"Riunite meeting ed agitate per questo l'opinione pubblica colla parola e colla penna.
"Il governo è ben disposto, ma indeciso.
"Siano nostri amici personali, o nò, fate capire ai democratici di costà ed ai semplici nazionali, che oggi non c'è un minuto da perdere in faccia alla situazione europea. Bisogna spingere il governo a Roma e subito. Si gridi Roma capitale d'Italia immediata, dalle Alpi ai due mari.
Vostro
L. Frapolli".
Ed in Ancona, città altamente patriottica, si ebbero meeting e agitazione, concordi tutti i partiti.[334]
Firenze, 4 settembre 1870.
Amico col. Elia,
Ancona.
"Giovedì sera, tutte le vette dell'appennino, da Tenda ad Aspromonte, devono essere illuminate da fuochi.
"Pensate all'esecuzione per la parte vostra sui punti circostanti prominenti. Ceneri e Saffi pensano per in su. Parlatene con Pichi. Verso Chieti abbiamo i nostri. Pensate per Sinigaglia.
"Viva Roma.
Vostro
L. Frapolli".
Firenze, 5 settembre 1870.
Amico,
"Le truppe italiane sono partite per Roma; fra ore Roma sarà la capitale effettiva d'Italia.
"Moltiplicate i fuochi per giovedì sera. Saranno fuochi di gioia.
Vostro
L. Frapolli".
Firenze, 7 settembre 1870
Amico!
"A Roma si va. Se c'è qualche ritardo è di ore e per ostacoli materiali. Non vi lasciate sviare[335] dalle notizie dei malevoli. Fate riunioni, dimostrazioni, fuochi dovunque. Se domani sera saremo in Roma sarà gioia. Se no incitamento! A Roma si va, l'Europa è concorde. Viva l'Italia!
Vostro
L. Frapolli".
E a Roma si andò per la breccia di Porta Pia e il sacro voto dei liberali italiani omai era compiuto.
Il 7 settembre 1870 il Ministro degli Affari Esteri spediva una circolare con la quale si rendevano noti i pericoli che minacciavano la patria e la chiesa, concludendo con queste parole:
"S. M. il Re, custode e depositario dell'integrità e dell'inviolabilità del suolo nazionale, interessato come sovrano di una nazione cattolica a non abbandonare alla mercè di qualche sorpresa il capo della chiesa, prende, come è suo dovere, con fiducia in faccia della cattolicità e dell'Europa, la responsabilità del mantenimento dell'ordine nella penisola e della tutela della Santa Sede.—Il governo di S. M. non può[336] aspettare a risolversi, avvenimenti che conducano all'effusione del sangue tra i romani e le forze straniere.—Noi occuperemo pertanto, allorquando le nostre informazioni lo dimostrino opportuno, i punti necessari per la sicurezza comune, lasciando alle popolazioni la cura della loro propria amministrazione".
Fu quindi ordinato che fossero pronte le truppe destinate all'occupazione di Roma, sotto il comando del generale Cadorna.
Dato l'ordine, le truppe italiane dopo di avere occupato Viterbo, Civita-Castellana, Frosinone, Civitavecchia e le terre dell'Agro, il giorno 17 settembre il 4o corpo d'armata si mosse su Roma; da altre parti muovevano le divisioni Bixio e Angioletti, e tutte queste truppe furono disposte intorno alla città in modo da accerchiarla.
Nella mattina del 20 settembre fu ordinato l'attacco. La Porta Pia veniva sfondata a colpi di artiglieria, e accanto ad essa, aperta una breccia nella cinta delle mura. Ottenuto questo risultato, fu ordinata la sospensione dei fuochi d'artiglieria e le truppe furono mandate all'assalto. I battaglioni dei bersaglieri e di fanteria si avventano a passo di carica sulla barricata della porta
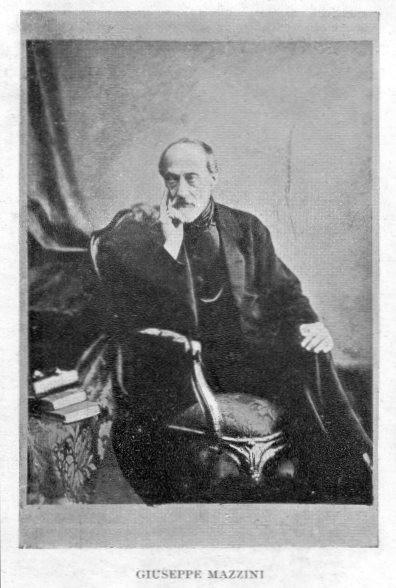
e dentro l'apertura della breccia, non arrestati dalla mitraglia e dal fuoco di fucileria dei mercenari pontifici che facevasi sempre più vivo ed intenso. Mentre questo avveniva a Porta Pia, il generale Bixio, dopo essersi impadronito di villa Panfili e del Casino dei quattro venti, aveva affrontato e sperso il nemico a Porta S. Pancrazio.
L'ingresso delle truppe italiane fu accolto con segni di vivissima gioia e di entusiasmo da parte del popolo di Roma.
Il giorno 2 di ottobre si procedeva al plebiscito che riusciva imponente, poichè i voti affermativi sommarono a 135,291 mentre i negativi furono 1507 soltanto.
Non erano trascorsi due mesi da questo avvenimento felice per la nazione italiana, che la Casa di Savoia riceveva un grandissimo attestato della fiducia che godeva in Europa.
Le Cortes di Madrid assicurate del consenso di Vittorio Emanuele e del principe reale, proclamavano Amedeo duca d'Aosta Re di Spagna.
Il 3 di dicembre giungeva a Firenze la deputazione che portava al nuovo Re la fausta notizia.[338]
Al palazzo Pitti erano presenti al ricevimento i grandi dignitari dello Stato, i ministri della Corona e la rappresentanza delle due Camere del Parlamento Nazionale.
Al discorso del signor Ruiz Zorilla il Re rispose con brevi parole, accordando all'amato figlio il consenso di accettare il glorioso trono a cui lo chiamava il voto del popolo spagnolo.
Il Duca d'Aosta, con voce commossa significava la sua accettazione, e l'atto solenne, che proclamava Amedeo Re di Spagna, veniva rogato; e poco appresso egli si recava alla capitale del suo regno, animato da sentimenti liberali e d'amore pel popolo che lo aveva prescelto a suo Re.
Ma ben presto si manifestarono nelle provincie spagnole ed anche nella stessa capitale segni di non dubbia ribellione.
Il 18 luglio del 1872 si attentava alla vita del giovane Re ed a quella della regina ed i due sposi furono miracolosamente salvi.
Mentre assieme alla regina attraversava in carozza una delle più popolose vie di Madrid, vennero tirate addosso ai reali parecchie fucilate.
Non si sgomentò per questo il figlio di Vittorio Emanuele e continuò nella incominciata[339] impresa di ricondurre la pace, imprimendo un regime liberale, fra quelle popolazioni.
Ma i torbidi crebbero talmente di gravità che Amedeo di Savoia, vedendo di non poter governare senza venir meno alla costituzione, piuttosto che mancare al suo giuramento o far versare in una lotta civile sangue spagnolo, decise di rinunziare spontaneamente alla corona.
E così fece: e il dì 11 febbraio 1873 ritornava, non più Re di Spagna, ma principe di Savoia acclamato in seno alla patria sua.
Il 10 di marzo 1872 moriva a Pisa, quasi profugo nella sua patria che amò tanto, dopo quasi mezzo secolo di lotte titaniche e di ineffabili amarezze, Giuseppe Mazzini.
Fin dal 1835 egli aveva incominciata la sua vita di agitatore col nobile scopo di vedere l'Italia libera tutta, libera per sempre, pronto a dare il suo concorso a chiunque avesse assunta la santa impresa del riscatto nazionale. A tale effetto istituì la grande associazione della Giovine[340] Italia, a riscontro della Società dei Carbonari ridotta all'impotenza per difetto di capi.
Nel finire del 1831 pubblicava la famosa lettera a Carlo Alberto.
In essa, istigava il Re di Piemonte ad iniziare l'impresa dell'emancipazione nazionale, dipingendogli lo stato dell'Italia, gli ideali e le speranze del popolo italiano; suggerendo al Re quello che doveva fare per la nazione.
Coi suoi scritti tenne vivo l'amore della patria. Col lavoro indefesso di 17 anni, dal 31 al 48, col suo apostolato di fede e d'amore, si acquistò la simpatia non solo degli Italiani ma dell'Europa, che vide in lui, l'incarnazione dei tempi nuovi e l'apostolo della redenzione.
Quando Pio IX salì al Pontificato, Mazzini levava un'altra volta la voce ricordando al Papa le sventure d'Italia ed invocando il suo intervento per farle cessare.
Caduto in Francia il Regno di Luigi Filippo nel febbraio del 1848, radunati quanti più potè esuli che si trovavano a Parigi; fondava l'Associazione nazionale italiana a scopo unitario.
L'Italia si svegliava colla gloriosa rivoluzione di Palermo, Messina e Catania e colle 5[341] giornate di Milano, seguite dall'eroica Brescia, dai moti dell'Italia centrale e dall'intimazione di guerra all'Austria da parte di Carlo Alberto.
Nella guerra del 48 seguì la legione dei volontari capitanati da Garibaldi, finchè sfinito di forza dovette rifugiarsi a Lugano.
Alla notizia dolorosa della rotta di Novara l'assemblea Romana elesse un triumvirato che pensasse alla difesa della proclamata repubblica e Mazzini fu eletto triumviro con Saffi e Armellini.
Contro Roma si erano unite Austria, Spagna, Francia e il Re di Napoli, ma la gloria di distruggere la repubblica Romana, che seppe difendersi con tanta gloria, doveva spettare tutta alla repubblica francese.
Mazzini credette sempre essere indispensabile all'Italia l'unione di tutti i suoi figli per diventare e conservarsi libera, gloriosa e potente; e quando nel 59 fu intimata dal Re Vittorio Emanuele la guerra contro l'Austria, egli dichiarava che si univa al concetto di Garibaldi, perchè anteponeva ad ogni cosa, l'unità della patria; il che era la base dei suoi principi.
Nel campo liberale Mazzini era considerato[342] lo spirito della rivoluzione, Garibaldi la forza. Senza Garibaldi l'unità d'Italia forse non si sarebbe fatta; ma senza Mazzini, che fece iniziare i moti di Sicilia, Garibaldi non avrebbe accettata l'impresa dei Mille e non sarebbe sbarcato a Marsala.
La morte di Mazzini lasciò un vuoto profondo nel cuore degl'Italiani; poichè molti riconobbero troppo tardi qual'uomo egli era; quale l'opera spesa disinteressatamente per la patria redenzione; le lotte alteramente sostenute fra la santa ribellione e la ancor più santa abnegazione—l'impulso dato in ogni tempo alla causa nazionale. Con Mazzini si spense il cuore animante alla rivoluzione, il grande mezzo che portò l'Italia da Torino a Roma—e alla sua memoria la venerazione che gli si tributò è inferiore a quanto egli meritasse, a quanto, senza pompa e senza lenocini, gli tributa dal cuore il risorto popolo italiano.[343]
Il Re Vittorio Emanuele II nel 31 dicembre del 1870 entrava per la prima volta in Roma per recarvi generoso soccorso; il Tevere uscito dal suo letto, apportava desolazione e ruina.
Nel 2 luglio del 1871, accolto prima in Campidoglio dal plauso, dalle benedizioni e dall'esultanza di 30 milioni d'Italiani, prendeva gloriosamente possesso del Quirinale, nuova sua Reggia, pronunciando le memorabili parole "ci siamo e ci resteremo".
Roma italiana, dopo la sua proclamazione a capitale del risorto paese, accolse nel Quirinale parecchi sovrani e principi esteri venuti a visitare il Re Vittorio Emanuele, riconoscendo con tale atto il nuovo regime costituzionale: l'imperatore Don Pedro del Brasile, il re ed il principe di Danimarca, il principe Federico Carlo di Prussia, l'arciduca Nepomuceno d'Austria, il re e la regina di Grecia, il principe di Galles, il duca di Edimburgo ed altri. Tutti ebbero a lodarsi delle festose accoglienze, e l'ammirazione d'ognuno fu grande e completa per le particolari[344] doti di pensiero e di cuore del nuovo Re d'Italia.
Nel 1873 Re Vittorio visitò Vienna e Berlino, accolto con entusiasmo che sembrò delirio—egli ovunque personificava il popolo italiano risorto a vita novella, ed il Re galantuomo sapeva rappresentare un popolo che aveva diviso e divideva le sue aspirazioni.
Nel febbraio 1874 giunse in Italia la notizia della morte di Nino Bixio, il soldato intrepido, temerario, di animo bollente e dell'inerzia sdegnoso. L'ardore di operosità che lo divorava l'aveva spinto, quando non era più richiesta l'opera delle armi, a correre in lontane regioni per schiudere nuova via al commercio italiano, ed in selvaggie ed inospitali contrade la morte crudele, che egli aveva tante volte affrontata sul campo di battaglia, lo fece sua vittima.
Morendo egli pensò alla patria, alla sua famiglia che raccomandò al Re. E non fu vana la raccomandazione.
In data 14 febbraio 1874 il Re indirizzava da Napoli—ove pervennegli la notizia—il seguente telegramma al Ministro Minghetti:
"Ricevetti ieri il rapporto che Ella mi manda
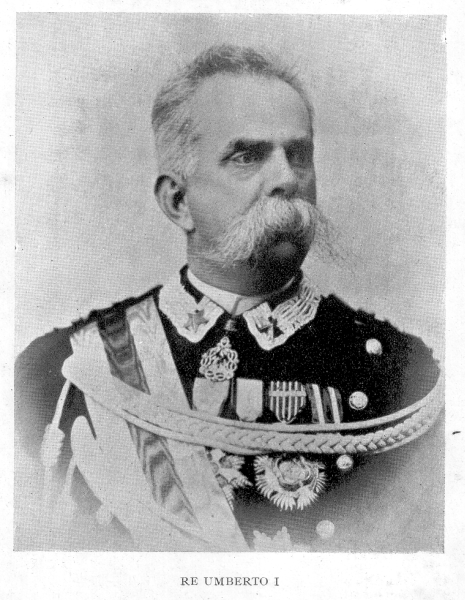
sulla morte del povero Bixio. La prego di fare per parte del Governo quello che si potrà per la famiglia. Io pure son disposto aiutare. Faccia il piacere di dirmi, dopo che Governo e ordine mauriziano avranno fatto la loro parte, con qual pensione creda che io possa contribuire".
Il 5 aprile 1875 l'imperatore Francesco Giuseppe restituiva a Venezia la visita fattagli da Re Vittorio a Vienna, e sull'ottobre l'imperatore Gugliemo di Germania giunse a Milano ospite del Re, accolto con un entusiasmo veramente commovente.
Intanto Re Vittorio dava impulso al riordinamento della vita pubblica italiana, prendendo viva parte al rinnovamento della vita nazionale, conscio e compreso dei suoi doveri di cittadino e di Re. E come alto fosse in lui questo sentimento lo dimostrano le parole da lui profferite nel discorso della Corona il 20 novembre 1876:
"Da 6 anni celebriamo in Roma la festa dell'unità nazionale. Dalla integrata unità avemmo frutti di gloria e prova di sapienza civile. Molto si è fatto, molto rimane a fare. Rimane l'opera che vuole maggiore pazienza[346] e lavoro e maggiore concordia d'intento; quello di consolidare tutto l'edificio governativo, e dove occorre, correggerlo. A questo non si può riuscire che con una gara sincera di operosità e di costanza. Io vi addito la via e sono certo che anche in queste battaglie pel riscatto civile, la mia voce troverà risposta di nobili sacrifizi e di gloriose vittorie".
Il primo gennaio 1878, Vittorio Emanuele ricevette, senza dare il benchè minimo sospetto di sofferenza, le deputazioni del Parlamento, i grandi dignitari dello Stato e molte altre rappresentanze, ed a tutti ricambiò con volto lieto gli auguri pel nuovo anno.
Alla sera si recò al teatro Apollo; nel tornare a casa si lagnò d'un gran caldo e fece abbassare i cristalli della carrozza. Giunto nelle sue stanze volle che il primo cameriere aprisse le finestre; si fece portare dell'acqua ghiacciata ed accese un sigaro, si mise a fumare sul davanzale della finestra.
Il giorno 2 andò a Castel Porziano per iscuotersi "come egli disse" e ne ritornò verso il mezzogiorno, chè il malessere andava crescendo.
Il giorno 3 ricevette al Quirinale il presidente[347] del Consiglio dei Ministri per la firma dei decreti.
—"Vede, Depretis", gli disse: "contrariamente alle mie abitudini ho fatto accendere il fuoco, perchè sento un grande freddo—. La scorsa notte l'ho passata male".
—"Bisogna curarsi, Maestà!
—"Mi curo; mi astengo dall'andare a caccia; del resto se di notte non mi sento bene, di giorno la va meglio".
Ciò detto si diede a firmare.
Aveva letto un decreto che collocava in aspettativa per motivi di salute un impiegato. Rivolto a Depretis, gli disse sorridente:
—"Anche io avrei bisogno di un po' d'aspettativa per l'eguale ragione.
—"Maestà—gli rispose il Ministro alquanto turbato, ma seguendo lo scherzo del Sovrano—per i Re i motivi di salute non sono sufficienti per avere l'aspettativa".
Il Re tacque e continuò a firmare.
Il 4 di mattino, il Re aveva dato le disposizioni di partenza per Torino, ma la debolezza lo costrinse a cedere al male e a rimettersi a letto; fece chiamare il medico. Il Saglione, comprese[348] subito che la cosa era grave, ma non diede a capir nulla al Re; soltanto domandò ed ottenne che fosse consultato un altro medico. Si telegrafò al Professore Bruno in Torino e fu chiamato l'on. Baccelli.
La mattina del 5 vi fu aumento di febbre prodotto dalla polmonite. Al tocco, arrivato il Dottore Bruno, si tenne consulto. I tre dottori si trovarono d'accordo nella diagnosi della malattia ed ordinarono una dose di chinino come disinfettante e una buona emissione di sangue, mediante salasso. Il Re era recisamente avverso a farsi aprire la vena: ma il professore Baccelli disse risolutamente:
—"Maestà, la nostra responsabilità innanzi a Voi e al paese, è troppo grande, perchè noi si faccia uso di tutti i nostri diritti. Vostra Maestà sarà Re finchè vuole; ma in questo momento i re siamo noi e Vostra Maestà è nostro suddito".
Vittorio Emanuele sorrise, sporse il braccio e si prestò al salasso; dopo del quale si sentì un po' meglio.
Il quinto giorno della malattia si sperava in una crisi benefica. Da Firenze venne chiamato il professore Cipriani, da Pisa il professore Landi, ma la crisi benefica non venne![349]
Nella mattina del giorno 9 i medici avvertirono un forte peggioramento. Gli ufficiali di servizio furono mandati ad avvisare i principi reali, i ministri e i grandi dignitari della Corte.
Il professore Bruno ebbe incarico di chiedere al Re, se era disposto a ricevere i conforti della religione.
Il Re calmo, si volse al medico e gli disse:
—"Ma dunque la malattia è ben grave?
Il dottore riprese che si trattava di una precauzione—e il Re replicò, "Facciano pure".
Il Re prese il viatico con grande serenità di spirito e disse:
—"Io speravo di morire sul campo di battaglia: ma pazienza!—Muoio almeno in questa Roma, in mezzo al mio popolo".
Dopo il Viatico passarono avanti al Re, affranti dal dolore, i ministri e i dignitari e il Re li salutò tutti.
Al figlio suo disse queste testuali parole:
—"Mio Umberto—caro figlio mio—ti raccomando fortezza, amore alla patria e alla libertà".
Il principe che era inginocchiato accanto al letto, assieme alla principessa Margherita piangente,[350] giurava al padre suo che non avrebbe dimenticati i suoi ultimi comandi e i suoi doveri.
Verso le 11 Vittorio Emanuele—il Grande Re—il Padre della Patria—entrava in agonia, che durò pochi minuti. Quando il prof. Bruno disse: "Il primo Re d'Italia è morto" fu uno scoppio unanime di pianto.
E così il dì 9 gennaio 1878 in Roma, nel palazzo del Quirinale cessava di vivere, dopo breve malattia, il Gran Re a cui l'Italia deve la sua unità, la sua indipendenza.
La morte di Lui fu cagione di lutto per la intera nazione e del più vivo dolore per ogni buon italiano.
I suoi funerali furono imponenti—Tutta Italia fu largamente rappresentata; e sulla sua tomba al Pantheon, asilo supremo della sua pace immortale, si scrissero le parole—vere—eloquenti—nella loro brevità:
A VITTORIO EMANUELE II
PADRE DELLA PATRIA
E il Pantheon rimarrà sempre luogo di pellegrinaggio per i veri e sinceri patriotti.
Vittorio Emanuele fu fedele mantenitore delle[351] franchigie concesse al popolo da Carlo Alberto; e mai s'oppose ai progressi richiesti dai nuovi tempi di civiltà e dal bene del paese; supremo fine dei suoi desideri. Nella storia del regno di Vittorio Emanuele si racchiude la storia d'Italia di trent'anni; giacchè alla grand'opera della redenzione egli si era accinto fin dai primordi del suo regnare e mai si arrestò, mantenendo le libertà giurate, ricevendo nel piccolo Piemonte gli esuli d'ogni parte d'Italia, resistendo alle minaccie ed alle prepotenze straniere e, giunto il momento desiderato, sguainando la spada per l'indipendenza ed unità della patria.
La memoria di Vittorio Emanuele sarà sacra in eterno nel cuore degli Italiani.
Fu fortuna per la patria nostra, da poco sorta a nazione, che Umberto I successore al Gran Re nel trono d'Italia fosse degno figlio del Gran Genitore, e che le sorti della nazione non corressero con lui nessun pericolo, sapendosi come immenso fosse in lui l'amore all'Italia e il sentimento di volerla prospera e grande.[352]
Della morte di Vittorio Emanuele Garibaldi fu inconsolabile.
Esso da tempo viveva a Caprera intento a trarre qualche partito dalla parte dell'isola suscettibile ad essere coltivata.
Nel 1875 apriva la campagna per la sistemazione del Tevere.
Nell'inviare al tenente colonnello Domenico Cariolato l'appello agli Italiani per la sottoscrizione ai grandi lavori del Tevere, così gli scriveva:
"Mio caro Cariolato,
"Vi accludo l'appello che io faccio agli Italiani per la sottoscrizione a favore dei lavori del Tevere. Sarebbe utile che la prima firma fosse quella del Re, ma temo che anche in quest'opera umanitaria vorranno ficcarvi la politica. Minghetti mi si è dimostrato favorevole, ma temo che altri metteranno i bastoni fra le ruote, e si farà in modo che il Re non firmi.[353]
"Parlatene a Dezza e venite presto a Villa Casalini. Sempre vostro
G. Garibaldi"
Roma, 10 gennaio 1876.
Era intento a questo nobile scopo ed a quello non meno nobile e grande della bonifica dell'Agro Romano, quando avvenne il triste fatto del trattato del Bardo. Garibaldi ne fu colpito più di ogni altro patriota perché lui non si aspettava dalla Francia quest'atto che umiliava l'Italia.
Palermo si preparava in quei giorni a festeggiare la data della ricorrenza dei Vespri Siciliani, e, invitato a recarsi nell'Isola da lui tanto amata, acconsentiva a fare il faticoso viaggio sebbene sofferente di salute e sebbene sconsigliato dai figli e dagli amici.
Lasciata Caprera, sbarcava il 21 di gennaio a Napoli ricevuto con delirio da quella popolazione che non l'aveva più riveduto dopo il 1860. Sente il bisogno di un po' di riposo e va a passare giorni tranquilli per circa due mesi nella villa del sig. Maclean a Posillipo.
Da Napoli si dirige in Calabria; riposa una[354] notte a Catanzaro, segue poi il viaggio, parte in vettura, parte in ferrovia; pellegrinaggio per lui micidiale, accolto dovunque passa con vera frenesia; arrivato allo stretto, ricevuto a Reggio da quel popolo delirante, passa alla sua Messina che s'accalca per salutarlo, per toccarlo, per baciarlo come se fosse cosa santa, e il 28 marzo entra a Palermo. Non è possibile dire delle deliranti accoglienze di quella popolazione, essendo più facile immaginarle, che descriverle.
A quel popolo, che freneticamente lo acclamava e voleva sentire la sua parola, diceva:
"Ricordati, o popolo valoroso, che dal Vaticano si mandavano benedizioni agli sgherri, che nel 1282 cacciasti con tanto eroismo.
"Forma quindi nel tuo seno, dove palpitano tanti cuori generosi, un'associazione Emancipatrice dell'intelligenza umana, la cui missione sia quella di combattere l'ignoranza e svegliare il libero pensiero".
Il 31 marzo, anniversario del terribile eccidio, il Generale per le tristi condizioni di salute non potè assistere alla grande cerimonia: e l'indomani[355] suo figlio Menotti alla folla radunata sotto le sue finestre, leggeva un'addio affettuoso del padre, nel quale si protestava figlio di Palermo, e il 17 aprile sul Cristoforo Colombo ripartiva per Caprera.
Tra l'aprile e il maggio lo stato di salute del Generale erasi fatto più grave, e la notte del 1o giugno i telegrammi si correvano l'uno dietro l'altro. Garibaldi è aggravato, Garibaldi è moribondo!
Nelle prime ore del mattino del 2 giugno lo stato del Generale appariva disperato, il respiro diveniva sempre più lento ed affannoso, e si vedeva che il terribile momento della sua scomparsa dal mondo era pur troppo vicino. Da Menotti furono mandati avvisi telegrafici a Canzio ed a Ricciotti. Fu pure telegrafato al dottore Albanese; ma ormai non poteva più giungere a tempo.
L'abbandono delle forze faceva a tutti comprendere che la catastrofe era imminente. Egli si spegneva tranquillo; solo si vedeva che avrebbe desiderato la consolante notizia dell'arrivo del dottore Albanese, di Ricciotti, di Canzio e Teresita.
Nel meriggio—due capinere vennero a posarsi[356] sul balcone aperto della camera del Generale, cinguettando—La moglie signora Francesca, temendo disturbassero l'ammalato fece un gesto per allontanarle; ma il Generale con un fil di voce soave, sussurrò: "lasciatele stare, sono forse le anime delle mie due bambine che mi portano l'ultimo saluto. Quando non sarò più mi raccomando di non abbandonarle" e non disse più altro. Solo più tardi chiese del suo piccolo Manlio. Volle vedere il suo cielo, il suo mare, e placidamente fra le braccia della dolce famiglia presente, alle 6 e 22 pomeridiane esalava la sua anima grande!
Alla notizia—Garibaldi è morto—l'Italia sussultò—e si sentì sbigottita dall'immensità della perdita. La Nazione si mise in lutto come nel funebre giorno della morte di Vittorio Emanuele.
Il Re Umberto scrisse di proprio pugno a Menotti, figlio del Generale, così:
"Mio padre m'insegnò nella prima gioventù ad onorare nel generale Garibaldi le virtù del cittadino e del soldato.
"Testimone delle gloriose sue gesta, ebbi per lui l'affetto più profondo, la più grande riconoscenza e ammirazione.[357]
"Mi associo quindi al supremo cordoglio del popolo italiano, e prego d'essere interprete delle mie condoglianze, condividendole coll'intera nazione.
Umberto"
Sentimenti veramente patriottici e gentili, degni del figlio del Gran Re, padre della patria.
La morte del generale veniva constatata dal certificato seguente:
Caprera, 3 giugno 1882.
Signor Sindaco
Maddalena
"Ieri (2) alle ore 6 pomeridiane è morto in Caprera, al suo domicilio, il generale Giuseppe Garibaldi in seguito a paralisi faringea. Dichiariamo che la tumulazione del cadavere può farsi dopo 24 ore della morte.
"In fede ci sottoscriviamo
Prof. Albanese
Dott. Cappelletti".
Due uomini nel secolo nostro lasciarono questa terra accompagnati da universale consenso di laudi e di dolore: Vittorio Emanuele e Garibaldi;[358] perchè essi soli incarnarono due dei più straordinari avvenimenti della storia: un Re fedele alla libertà, che oblia la tradizione della sua stirpe, e mette in pericolo il retaggio dei suoi figli per la redenzione di un popolo; un popolano che si eleva, per virtù propria fino alla potenza di Re, ma per ritornare al suo modesto focolare scevro di qualsiasi ambizione, sagrificando gli ideali della sua anima alla suprema felicità della patria! Inchiniamoci alla memoria di questi Grandi!
Composta la salma del Generale il dottore Albanese inviava questo telegramma perchè fossero note le supreme disposizioni del Generale:
"Garibaldi spirò ieri sera; lasciò un'autografa disposizione in data 17 settembre 1881, così concepita:—"Avendo per testamento determinato la cremazione del mio cadavere, incarico mia moglie dell'eseguimento di tale volontà, prima di dare avviso a chicchessia della mia morte. Ove ella morisse prima di me io farò lo stesso per essa. Verrà costruita una piccola urna in granito che racchiuderà le ceneri sue e mie. L'urna sarà collocata nel muro, dietro il[359] sarcofago delle mie bambine e sotto l'acacia che lo domina".
Ecco poi testualmente la lettera del generale al dottore Prandina:
Caprera, 27 settembre 1877
Mio carissimo Prandina,
"Voi gentilmente vi incaricate della cremazione del mio cadavere e ve ne sono grato.
"Sulla strada che da questa casa conduce verso tramontana alla marina, alla distanza di trecento passi a sinistra, vi è una depressione di terreno limitata da un muro.
"In quel canto si formerà una catasta di legno d'acacia, lentisco, mirto ed altre legne aromatiche. Sulla catasta si poserà un lettino di ferro e su questo la bara scoperta, con dentro gli avanzi miei, adorni della camicia rossa.
"Un pugno di cenere sarà conservato in un'urna di granito, e questa dovrà essere posta nel sepolcreto che conserva le ceneri delle mie bambine Rosa e Anita.
Vostro sempre
G. Garibaldi"
Ed a queste sue istruzioni scritte ne aggiungeva altre verbali: al Prandina diceva.[360]—
"Voglio essere bruciato: bruciato, non cremato, capite bene. In quei forni che si chiamano Crematori non ci voglio andare: voglio ripeto essere bruciato all'aria aperta..... e voi Fazzari sarete il mio liberto.
"Farete una catasta di legna, dell'acacia di questa isola, stenderete il mio corpo vestito della camicia rossa sopra un lettino di ferro; mi deporrete nella catasta con la faccia rivolta al sole e mi brucerete; le ceneri le deporrete dietro la tomba di Anita—Così voglio finire—"
E non fu bruciato!—Le sue osse sono sepolte nella sua granitica Caprera—isola sacra alla patria.—Ma il suo spirito aleggia in ogni angolo d'Italia che tanto amò e per la quale tanto fece perchè fosse libera e grande! Tale l'ideale di tutta la sua vita gloriosa! E che così fu, lo prova questa sua dichiarazione.
"Io non ebbi mai altro che uno scopo— quello dell'unità italiana—quindi il mio programma del Ticino fu lo stesso a Marsala, ad Aspromonte ed a Mentana".[361]
Ricercare ora quali furono i moventi che ci spinsero all'occupazione di Massaua, sarebbe opera vana!
L'Italia, divenuta nazione, credette che il suo prestigio sarebbe aumentato, se al pari delle altre potenze si fosse lanciata in qualche impresa coloniale e il governo italiano vi si decise incoraggiato all'occupazione, dall'Inghilterra che temeva di vedere altra nazione inalberare a Massaua, da un momento all'altro, la propria bandiera.
Del resto l'idea di aprire nuovi sbocchi al nostro commercio sorrideva, e l'opinione pubblica si mostrò favorevole all'iniziativa, sopratutto in Lombardia ove fiorivano a questo scopo delle Società, e si pubblicava un giornale caldo fautore dell'espansione coloniale, e s'incoraggiavano e si organizzavano spedizioni africane.
E difatti quando al principio del 1885 un giornale officioso ne dava il primo annunzio l'opinione pubblica, lo accolse con segni di compiacimento, e salutava pochi mesi dopo con entusiasmo, la partenza dei nostri bersaglieri per Massaua.[362]
Disgraziatamente allo slancio con cui l'Italia aveva iniziato la conquista di colonie africane, non corrispose la preparazione necessaria.
Due erano le politiche da seguirsi dopo l'occupazione avvenuta il 4 febbraio 1885.
Una, quella di limitarsi a tenere Massaua come porto di sbocco alle regioni interne, attendendo dal tempo l'occasione di assoggettarle moralmente, l'altra, di fare addirittura una guerra a fondo, impossessarsi dell'Abissinia, assoggettarla per poi irradiare la nostra influenza nelle ricche regioni del Sud, assicurandoci le vie commerciali.
Invece, dei due sistemi, non ne abbiamo seguito decisamente nessuno.—Siamo andati al caso—per una via di mezzo che ci portò a continui successivi conflitti, ed infine al disastro.
Rimanendo a Massaua col porto naturale dell'Abissinia del Nord in nostre mani, potevamo chiedere ed ottenere compensi commerciali in cambio dei favori che si sarebbero potuti rendere al Negus, agevolando il commercio del suo paese; ma dal momento che ci inoltravamo nell'interno, bisognava farlo con ogni precauzione e con tutta la preparazione perfetta tanto da poter avere la sicurezza di non temere sconfitte.[363]
Venne pur troppo, per nostra eccessiva fiducia la catastrofe di Dogali e la strage dei nostri soldati e del colonnello De Cristofaris che li comandava; fatto che, non ostante l'esito sfortunato, contribuì più di una vittoria e far rispettare nel Tigrè e farne ammirare l'eroismo dell'esercito italiano.
E, sotto la dolorosa impressione di quest'eccidio l'opinione pubblica fu concorde nello spronare il governo alla guerra o nell'approvarlo quando decise la spedizione di S. Marzano. Ma il triste fatto non valse ad aprire gli occhi al governo il quale, invece di lasciare mano libera ai comandanti le forze che si mandavano laggiù, volle esso stesso fissare i limiti dell'azione; ostacolandone tutte le iniziative e mal provvedendo alle loro richieste, sempre esitando dinanzi alla idea di assumere la responsabilità di una politica e di un'azione decisiva. E così siamo andati avanti a forza di piccole iniziative, le quali hanno dato sterili risultati, e finirono coll'obbligarci a dei sacrifici che necessariamente dovevano diventare non solo necessari ma urgenti, e quel che è più doloroso, non dovevano essere più sufficienti per salvarci da immane catastrofe.[364]
Quanti disinganni! quante amarezze, questo procedere ha costato ai nostri bravi ufficiali, a incominciare dal Saletta al Gene al Di San Marzano, al Lanza al Cagni per finire al Balbissera; i quali animati dal desiderio di portare di fronte al nemico la balda nostra gioventù con la speranza di ricondurre le nostre truppe vittoriose in Italia, per gli ordini che si mandavano da Roma si trovarono delusi, obbligati a mordere il freno, perchè con essi veniva loro impedito lo sviluppo alle operazioni militari, nei momenti più indicati dalle circostanze.
Il generale di San Marzano, più degli altri impaziente d'impegnare l'azione, quando nel 1888 l'esercito del Re Johannes era in isfacelo così da dovere levare il campo ed iniziare la ritirata in condizioni disastrose, dovette provare il dolore più grande della sua vita—egli—valoroso militare di tutte le campagne dell'indipendenza— compresa pur quella di Crimea—allorchè ricevette i telegrammi da Roma che paralizzavano ogni sua iniziativa.
E non abbiamo neppur saputo cogliere nè avvalerci della bella opportunità che il caso ci offriva.[365]
L'improvvisa morte del Negus Giovanni poteva metterci in condizioni tali da essere noi gli arbitri degli eventi. Invece aperta la successione al trono, abbiamo commesso il più grande, il più fatale degli errori. Quello cioè di spendere tutta la nostra influenza per aiutare l'assunzione al trono imperiale del Re dello Scioa, inimicandoci a morte i nostri vicini del Tigrè che dovevamo tenerci amici e strettamente a noi vincolati, col favorirli in tutti i modi, aiutando con tutte le nostre forze l'elezione del Mangascià, il più legittimo pretendente alla successione del Negus, e di questo servirci, e servirci delle popolazioni, ostili per tradizione agli scioani, per garantire la frontiera della nostra colonia e tenere a rispettosa distanza il Re dello Scioa.
Richiamato in Italia il corpo di spedizione comandato dal generale conte Asinari di San Marzano, venne lasciato come comandante a Massaua il generale Baldissera, il quale diede all'opera sua una spiccata impronta personale. Egli ebbe un esatto concetto della situazione e previde le gravi difficoltà che sarebbero sorte per il fatto dell'abbandonata politica Tigrina per[366] quella Scioana. Fu lui che iniziò l'organizzazione delle truppe indigene che fecero tanta buona prova sotto gli ordini di Arimondi ad Agordat ed a Coatit. E fu sotto Baldissera che la colonia da Massaua a Saati e Ua-à si estese senza difficoltà e senza spese sull'altipiano.
Affabile con tutti, sopratutto coi suoi ufficiali, non transigeva mai quando si trattava di un dovere da compiere. In servizio, quando aveva dato un ordine, un comando, voleva essere rapidamente obbedito.
Il giorno della occupazione di Saati il comando superiore aspettava di essere assalito dagli Abissini. Furono dati gli ordini per l'attacco. Il generale Baldissera, fedele agli ordini del comando, fece occupare le posizioni più avanzate; diede tutte le disposizioni per una energica azione. Ad un maggiore dei Bersaglieri destinato ad occupare una posizione importante disse colla sua voce sempre calma—soltanto queste parole: "Se fosse attaccato... Lei maggiore muore qua... Ha capito? siamo intesi! O la croce di legno... o la croce di Savoia..." e via di galoppo.
Baldissera—fiero soldato, intelligentissimo[367] ufficiale—fu lui che fece sventolare la bandiera italiana all'Asmara e a Cheren, e fu peccato che egli pure fosse sacrificato alla politica Scioana e per questo fosse obbligato a chiedere il rimpatrio.
Il generale Baldissera veniva rimpiazzato dal generale Orero.—Al nome di questo generale, valoroso ufficiale—è legato il ricordo della marcia su Adua, fatta con tale ordine e rapidità da destare l'ammirazione generale— l'accoglienza ad Adua fatta alle nostre truppe fu entusiastica.
Ma per non offendere le suscettibilità Scioane si dovette abbandonare Adua e ripassare il Mareb!
Invano i capi Tigrini, il clero, il popolo esortavano gl'italiani a rimanere. "Noi saremo con voi" dicevano: invano ci si raccomandavano dal momento che noi non volevamo essere i loro governanti, di riconoscere per loro Re Mangascià sottraendoli alla minaccia di essere governati dallo Scioa—l'ordine era di ritirarsi e di restare per Menelik e il generale Orero e le truppe da lui comandate ubbidirono, e il generale, disgustato esso pure—domandò di ritornare in Italia.[368]
All'Orero successe il generale Gandolfi, un altro dei nostri migliori generali. Giunse a Massaua nel giugno del 1890 quando la politica Scioana era all'apogeo.
Contando su di una pace durevole dopo il trattato d'Ucciali, il Crispi capo del governo, volle dare all'Eritrea un ordinamento civile, formato, oltre che dal governatore, da altri tre funzionari con incarichi speciali ai quali diede il nome di Commissari Coloniali; ma tale organizzazione non fece buona prova, perchè la colonia non era ancora a quel punto nel quale all'ordinamento militare si poteva, come avvenne dippoi, sostituire un'organizzazione civile.
Fu sotto il generale Gandolfi che ebbe luogo la famosa intervista sul Mareb con Mangascià e cogli altri capi tigrini, nella quale furono solennemente giurati i patti che dovevano assicurare la quiete e la tranquillità della colonia, e fu in conseguenza di questi patti che vennero dati gli ordini da Roma per la ritirata delle nostre truppe, dalle migliori provincie Eritree del Seraè e dell'Oculè Cusai.
A rimpiazzare il generale Gandolfi fu destinato il generale Barattieri, che all'età di 17 anni[369] aveva fatto parte della gloriosa schiera dei Mille, uno dei più caldi fautori della politica di espansione coloniale.—Amicissimo di Zanardelli e di Cairoli, sotto l'aureola simpatica di essere trentino fu eletto deputato di Breno, collegio, che gli rimase sempre fedele.
Durante i primi anni del suo governo, passati in un periodo ininterrotto di pace e di tranquillità, diede opera all'ordinamento civile della colonia.
Verso la fine del 1893 ritenendo che la pace sarebbe perdurata, venne in licenza in Italia lasciando il comando delle truppe e le funzioni di governatore nelle mani del colonnello Arimondi,—un valoroso. Questi il 22 dicembre 1893 con un suo telegramma al Ministro della guerra annunciava la vittoria d'Agordat combattuta contro i Dervisci. Trofeo della vittoria, 72 bandiere lasciate in mano dei nostri, una mitragliera e circa 800 fucili. I dervisci lasciarono sul terreno più di mille morti, mentre le nostre perdite furono di tre ufficiali ed un sottufficiale morti, di un ufficiale ed un sottufficiale ferito, e di circa 225 indigeni fra morti e feriti.
Il Re mandava il giorno stesso al colonnello Arimondi il seguente telegramma:[370]
Colonnello Arimondi,
Agordat.
Mando a lei e alle truppe d'Africa le più vive felicitazioni per la vittoria d'Agordat. L'Italia che si associa al mio plauso, rende con me un sacro tributo ai valorosi che morirono per la gloria della nostra bandiera.
Umberto.
A questo telegramma il colonnello Arimondi rispondeva così:
"Ministro Guerra,
Roma.
"Il plauso del Re fu per tutti il premio più ambito".
Il colonnello Arimondi fu promosso al grado di maggior generale per merito di guerra.
Il generale Barattieri ritornato a Massaua, preoccupato dall'eventualità di qualche non gradita sorpresa da parte dell'Abissinia, fece noto al governo il vantaggio che si sarebbe ritratto dalla occupazione di Cassala, non soltanto al nord ma anche al sud della colonia, sia per il maggior prestigio che questo colpo di mano ben riuscito avrebbe dato alle nostre forze di fronte[371] agli abissini, sia perchè togliendo ai dervisci quell'importante punto di concentramento, si allontanava il pericolo di dover fronteggiare contemporaneamente due nemici posti agli estremi limiti della colonia.
In data 12 giugno il ministro degl'esteri barone Blanc telegrafava al Barattieri.
"Il Governo del Re lascia lei giudice di prendere quelle disposizioni che crede più opportune per agire su Cassala".
E il Barattieri prendeva le sue disposizioni per l'attacco.
Il 16 di giugno di sera, dà l'ordine di marcia che, trattandosi di sorpresa, deve essere fatta nel silenzio il più assoluto, con raccomandazione agli ufficiali di tenere sempre in mano le truppe— e la marcia fu eseguita in ordine perfetto, e secondo le disposizioni date.—Sul fare del giorno le nostre truppe erano in vista del campo di Cassala.
Alle ore 7 l'avanguardia apriva il fuoco contro la cavalleria nemica, la quale si gettava contro il nostro fianco sinistro, ma è costretta a ripiegare; l'avanguardia seguita dal grosso continuò ad avanzare, finchè giunta a 400 metri dai dervisci[372] schierati, apriva il fuoco a salve, sia contro essi, sia contro la cavalleria; i nemici rispondevano con fuoco ben nutrito, ma infine, vedendo che non vi erano apprensioni sui fianchi e per le spalle, il generale Barattieri diede l'ordine di un colpo simultaneo di tutte le forze, che mise in sfacelo il nemico, obbligato a lasciare il campo ed a ritirarsi a corsa sfrenata.
Fin dal luglio il generale Barattieri informava il governo che egli temeva prossima—e cioè nel dicembre del 1894 o nel gennaio 1895—una levata di scudi di tutta l'Etiopia contro di noi.
Difatti il primo sintomo che al generale diede modo di giudicare giusto, fu la ribellione di Batha-Agos, la rottura dei fili e quindi l'interruzione del servizio telegrafico, e l'arresto a tradimento del tenente Sanguinetti, nostro residente a Saganeiti.
Il maggiore Toselli informato del tradimento, con marcia rapidissima la mattina del 16 arrivava con tre compagnie a Mahraba, poco distante da Saganeiti, e subito apriva trattative con Batha-Agos per la restituzione del tenente[373] Sanguinetti; intanto ristabiliva la linea telegrafica. Disponeva in complesso di circa 1500 uomini e di una batteria da montagna, ed aveva stabilito di dare l'attacco a Saganeiti, forte posizione, la mattina del 18 settembre, quando si accorse che i ribelli l'avevano sgombrata. Deciso ad inseguire i ribelli, il maggiore Toselli senza por tempo in mezzo, occupa Saganeiti e continua senza riposo la marcia nella speranza di disperderli e di arrivare in tempo a salvare la compagnia di Halai isolata e che correva il più grave pericolo.
Ad Halai frattanto la compagnia sotto gli ordini del capitano Castellazzo, con grande valore sosteneva da ore un ineguale combattimento contro le orde di Batha-Agos forti di 1600 uomini; mentre i ribelli avvolgevano da tutte le parti il piccolo forte presidiato da circa 200 uomini, una viva fucilata rovesciava il fronte del combattimento. Era l'avanguardia della colonna Toselli che entrava in azione colle compagnie dei capitani Folchi, Olivari e Gentili e dava tempo alla compagnia Galli di guadagnare il ciglio con una sezione d'artiglieria.
I nostri rianimati pel soccorso aumentarono[374] il fuoco al grido di Savoia! e poco appresso il maggiore Toselli con tutte le forze si slanciava all'attacco. Alle 18 era già notte e il nemico, sfuggiva dietro le rupi e giù per le chine precipitando. Le perdite dei nostri, 11 ascari morti e 22 feriti; le perdite del nemico furono notevoli assai.
Fra i morti Degiac Batha-Agos ed il suo parente bascià Musgnen.
Il tenente Sanguinetti poté sottrarsi alla triste fine che i seguaci di Batha-Agos gli minacciavano, per l'assistenza del suo interprete Gare-Sghaer, bravo giovane indigeno che gli si mostrò fido fino alla morte.
Dopo la ribellione di Batha-Agos non era più possibile dubitare sulle intenzioni ostili di ras Mangascià. Il generale Barattieri non perdè tempo; concentrò un corpo di operazione ad Adi Ugri, e chiamò sotto le armi la milizia mobile che diede ottimi risultati; fatto ciò, al generale sembrò il miglior consiglio quello di marciare su Adua. La colonna rifece la strada percorsa dal generale Orero, e anche questa volta come allora, le popolazioni accorsero sul passaggio delle nostre truppe festeggiandole ed insistendo che vi rimanessero a proteggerle.[375]
Le nostre truppe nell'imminenza d'un attacco che pareva certo, presero posizione sull'altura di Fremona; ma nè ras Mangascià, nè ras Agos osarono cimentarsi; e si ritirarono avviandosi, apertamente ostili, per altra direzione.
Il Barattieri che aveva ottenuto l'effetto morale voluto, abbandonò Adua e ritornò ad Adi-Ugri.
Verso l'8 ras Mangascià concentrò tutta la sua gente al di là dei nostri confini. Il giorno 12 decise di passare la frontiera per entrare sul'Oculè-Cusai, dove ogni villaggio è una fortezza naturale e da dove chi vi si annida può sfidare impunemente qualunque nemico.
Barattieri decise di prevenire il nemico nella posizione di Coatit mentre questo stava per addentrarsi nei monti. Ed a Coatit avvenne la battaglia che ha dato nuova gloria ai nostri ufficiali, che ha provato una volta ancora la saldezza delle nostre truppe e dei loro ordinamenti. Alla sera dell'11 il Generale ordinò di passare l'indomani mattina il Mareba, dirigendosi sopra Adis-Adi. Quivi la colonna che doveva marciare su Coatit fu formata così:
Avanguardia: Toselli con sei compagnie e le[376] bande dell'Oculè-Cusai; Grosso: la compagnia del battaglione Galliano, una batteria su 4 pezzi, quattro compagnie dello stesso battaglione, il battaglione Hidalgo di cinque compagnie; Salmeria, e le bande del Seraè in retroguardia.
Da Adis-Adi le truppe si mossero alle 9; il Toselli aveva ordine di occupare Coatit, e possibilmente prima di notte prendere contatto col nemico. Difficile, faticosa fu la marcia. La colonna giunse a Coatit che fu trovato sgombro, senza che il nemico avesse avuto sentore dell'ardita marcia.
La notte passò senza novità, senza nessun allarme. Alle 3 del 13 il generale ordina al maggiore Galliano di muovere, per schierarsi a sinistra del maggiore Toselli; al maggiore Hidalgo ordina di seguire in riserva.
Tutti sono al loro posto e il movimento offensivo si inizia allo spuntare dell'alba, ore 6, coll'avanzare di tutti convergendo a destra, perno l'artiglieria; successivamente i battaglioni Toselli Galliano e le bande Sanguinetti e Mulazzani; nel centro, a rincalzo, in posizione coperta il battaglione Hidalgo con quattro compagnie, avendo dovuto lasciare la quinta nella posizione e con[377] l'incarico sopra indicato; direzione di marcia, un poggio conico sulla cui sommità sorge un Tecul. Tutto procede con ordine. Poco dopo le sei i due battaglioni di prima linea hanno le compagnie parte schierate, parte coperte in buona posizione e allo spuntare del sole la batteria Ciccodicola da un altura maestrevolmente scelta, lancia il suo primo Shrapnel contro il campo nemico; mentre il quartier generale, con bandiera spiegata va a fissarsi sul poggio conico sovraindicato.
È evidente una grande agitazione nel campo nemico. Malgrado la sorpresa, con molta prontezza e slancio, a gruppi sempre più fitti vengono innanzi, superando con destrezza ammirabile buroncelli ed impedimenti, mascherando il numero, offrendo pochi bersagli, affittendosi sempre più dietro i ripari.
Il fuoco di fucileria si apre su tutta la linea colle avanschiere del 3o e del 4o battaglione, le quali, malgrado l'impeto che le spinge all'attacco, si mantengono in pugno agli ufficiali come ne sono prova i frequenti fuochi a salva. Le compagnie manovrano con calma serena, facendo moderatamente uso del tiro e schermendosi convenientemente. Lo slancio non scema la disciplina che manifesta la sua superiorità.[378]
Mentre l'azione si accende sempre più viva si scorge da parte dei tigrini un movimento girante alla larga, ciò che gli è permesso dal gran numero di forze, superiori assai alle nostre, dalla perfetta conoscenza dei luoghi e dalla maestria abissina nei movimenti avviluppanti. Dal comando furono mandati ordini urgenti alle bande di volgersi a sinistra in direzione del poggio di Adi Auei, ed alle compagnie non impegnate del 3o battaglione, di muovere verso le alture per interrompere l'aggiramento che andava sempre più accentrandosi stringendosi.
Fu dato ordine ai maggiori Toselli e Hidalgo di arrestare l'avanzata verso il campo del Ras delle compagnie impegnate; ripiegare dalla destra verso sinistra le compagnie non impegnate volgendo il fronte a Nord Est e Nord donde veniva l'accerchiamento; concentrarsi infine sopra la posizione di Coatit. I cannoni furono pure avviati verso Coatit per sostenere il cambiamento di fronte a sinistra; e il comando stesso mosse dal poggio verso Coatit, esposto nel percorso al bersaglio di una forte colonna nemica, la quale fu bravamente respinta dagli ascari; caddero vicini al generale Barattieri, il tenente[379] Sanguinetti colpito tre volte di palle, il tenente Castellani, il sergente Bertoja, il porta bandiera e molti ascari. Ma verso le undici dal ciglio che limita al Nord lo spianato di Coatit, il generale poteva ordinatamente disporre le truppe per un efficace difesa della località e l'accogliere le forze per un contrattacco, coadiuvato potentemente dal generale Arimondi.
Tutto il corpo d'operazione era sottomano unito e pronto a qualsivoglia azione, con un morale altissimo.
Il nemico dalle alture che aveva occupato continuava un vivo schioppettìo a grandi distanze senza recare ai nostri, gravi danni.
La notte del 13 al 14 passò tranquilla; il nemico salutò l'alba del 14 con intensa fucilata che pareva volesse preludiare ad un attacco generale. Nel meriggio si videro nuvoli di tiratori coronare l'altura e scendere giù nel burrone, scagliando una punta a sinistra cioè all'angolo Nord-Ovest della posizione di Coatit; la batteria lanciò qualche colpo contro i nuclei nemici che volsero in fuga ed incendiò l'erba secca per una notevole estensione.
Distribuiti viveri e munizioni, raccolti indizi[380] di depressione da parte del nemico il generale risolse per l'alba dell'indomani (15) di dare l'attacco contro l'altura a Nord di Coatit. All'uopo l'artiglieria prima dell'alba doveva essere pronta a battere la cresta dell'altura della quale aveva misurato la distanza. Il 4o battaglione con manovra libera e tattica abissina, doveva scendere stormeggiando nel vallone e risalire l'altura avviluppandola sotto la protezione del fuoco d'artiglieria; le bande nel fianco destro aggirando, dovevano puntare sopra Adi-Auei per minacciare e colpire fianco e tergo dei tigrini. Il 2o e 3o battaglione dovevano aspettare ordini per appoggiare l'attacco.
Ma nella notte Ras Mangascià pensò bene di ritirarsi coi suoi verso Senafé.
Avutone il Barattieri notizia alle 3 1/2 del mattino del 15, diede gli ordini opportuni per l'inseguimento del nemico—questo durò fino a Senafé—ma non fu potuto raggiungere e le truppe abissine si dispersero.
Dopo la sconfitta di Coatit e la disastrosa ritirata da Senafé, Ras Mangascià, mentre faceva proteste di amicizia e mostravasi al generale italiano animato dal desiderio di pace, cercava[381] d'altra parte di raccogliere soldati, ed avendo posto il campo coi suoi a due giornate da Adigrat, era di ostacolo alla pacificazione della regione. In tale stato di cose l'occupazione di Adigrat, capitale dell'Agame, per parte nostra s'imponeva.
Nella metà di marzo Barattieri intimava a Mangascià di disarmare; e siccome invece di disarmare egli continuava a dare molestie, il generale decise di varcare il confine ed occupava militarmente Adigrat.
Intanto le informazioni che venivano dallo Scioa confermavano sempre più la notizia che Menelik era deciso di portare forte aiuto a Mangascià. Nel suo rapporto al Ministro degli Esteri il governatore dell'Eritrea informava dello stato delle cose, concludendo che bisognava essere pronti ad una grossa guerra pel prossimo dicembre.
E fu in seguito a tali notizie che il Ministero, non essendo d'accordo sulle misure da prendersi, reputò opportuno di chiamare il governatore in Italia col seguente telegramma:
Roma, 8 luglio
"Il governo desidera conferire verbalmente sulla situazione preveduta pel prossimo autunno.[382] La preghiamo prendere disposizioni opportune per una sua breve assenza dalla Colonia".
Crispi-Blanc-Mocenni.
Prima di lasciare la Colonia il generale disponeva che a vigilare le regioni occupate, il maggior Toselli ponesse la sua dimora nell'Agamè e che il maggior Amelio si stabilisse nel Tigrè dominando Adua dal colle di Fremona. Tutto disposto il governatore, ubbedendo agli ordini del governo, s'imbarcò per l'Italia.
Verso la fine di settembre ebbero luogo delle scaramuccie al di là dei nostri confini fra partigiani nostri e gruppi di fedeli a Mangascià il quale seguitava a raccogliere armati. Era evidente la necessità da parte nostra di attaccare Mangascià prima che potesse ricevere gli sperati aiuti dallo Scioa.
Il governo Eritreo ai primi d'ottobre chiamò sotto le armi la milizia mobile e decise di prevenire la minacciata invasione.
Il generale Barattieri era ritornato al suo posto.
Si era saputo che Ras Makonnen, aveva espulso dall'Harrar gli italiani e si era mosso[383] col suo esercito per raggiungere il Negus; che Ras Mikael era pronto col suo esercito e che Ras Oliò s'era avanzato fino al sud del Lago Ascianghi. Non c'era tempo da perdere; una sconfitta inferta a Mangascià poteva ancora trattenere Menelik e persuaderlo ad evitare un conflitto; così fu creduto dal comando.
Il giorno 4 di ottobre il generale Barattieri mosse da Adigrat con quattro battaglioni indigeni, col battaglione Cacciatori d'africa e coi reparti del genio e dell'artiglieria.
L'ordine di marcia in avanti fu accolto con entusiasmo nel campo.
Il Toselli fu distaccato col suo battaglione in colonna volante, con incarico di sorprendere sul fianco Mangascià in ritirata.
Il nostro corpo d'operazione invase l'Enderta. Circa 1700 tigrini avevano occupato la forte posizione di Debra-Ailà; mosse a quella volta con rapida e faticosa marcia il maggiore d'Amelio col suo battaglione, attaccò vivamente la posizione malgrado la difficoltà del luogo e della difesa e ne determinava la sconfitta e la fuga del nemico, facendo numerosi prigionieri.
Il maggior Toselli la sera dell'8 informava[384] il generale di avere occupata la posizione alle spalle del nemico che si trovava al sud di Debra-Ailà e che la mattina seguente avrebbe proceduto all'attacco.
Ricevuta questa notizia verso notte Barattieri ordinava alle tre dì mattino si riprendesse la marcia. Alle 11 i nostri entravano in Antalo senza avere incontrato il nemico. Si sentiva un vivo fuoco di fucileria ed esaminata la posizione si vide che si combatteva sulle alture di Debra-Ailà.
L'assalto di quella forte posizione era stato iniziato dalle bande comandate dai bravi tenenti Sapelli e Lucca; quando queste furono spinte sui fianchi il maggiore d'Amelio fece avanzare due compagnie di Ascari, mentre l'Artiglieria sloggiava il nemico delle alture.
Dopo un quarto d'ora di fuoco accelerato, il battaglione indigeno muoveva all'assalto della montagna, mentre Barattieri faceva avanzare il battaglione dei cacciatori italiani, sostenuti dal 3o battaglione indigeno. In breve i nostri forzarono il ridotto dell'Amba e il fuoco cessava. Il nemico, sbaragliato si dava alla fuga, mettendosi in salvo per sentieri impraticabili.[385]
Finito il combattimento il battaglione d'Amelio, che si distinse in modo particolare, rimase sulla forte posizione conquistata con una batteria; le altre truppe ritornarono ad Antalo, ove Barattieri pose il suo quartier generale.
Il generale Arimondi avuto notizie che Mangascià si era diretto verso il Vogherat si mosse da Antalo per inseguirlo, così pur fece il maggior Toselli; sorpassata la catena di Tagarrà, raggiunse il campo del Ras che lo aveva abbandonato poco prima; lo inseguì ancora, ma si cercò invano di raggiungerlo; allora riunitosi Arimondi col Toselli presero la via di Amba-Alagi.
Dopo questi fatti il Makonnen mandò proposte di pace d'incarico del suo sovrano; ma queste non erano che inganni per guadagnar tempo e per addormentare il governo italiano e il comando dell'Eritrea. Si sapeva invece che Menelik raccoglieva forze poderose, che unite a quelle di Makonnen formavano già un corpo rispettabile di circa cinquantamila uomini.
Mentre questo si preparava nel campo nemico, al comando di Massaua, mancando un servizio di sicure informazioni, nulla si sapeva, e così il governo e il governatore dell'Eritrea, continuarono[386] ad andare innanzi nella convinzione che il Negus non si sarebbe mosso, e che non si trattava di altro che di minaccie. Insomma si credeva ad una eccellente situazione, quando già ingenti masse si riunivano al lago Ascianghi e si facevano allo Scioa gli ultimi preparativi per la gran guerra di esterminio degli italiani.
A confermare il comando nella sua credenza, il 3 dicembre un dispaccio ufficiale annunziava che ras Makonnen aveva chiesto un convegno al generale Barattieri "per trattare la pace". Perfido inganno—che ribadiva nel nostro governo una fallace illusione, il cui risveglio doveva essere fatale e tremendo. E questo risveglio non doveva pur troppo ritardare.
Il giorno 9 dicembre veniva comunicato alla Camera dei deputati un dispaccio del generale Barattieri col quale informava che la colonna Toselli era stata improvvisamente attaccata ed avviluppata ad Amba Alagi da tutto l'Esercito Scioano. Si riteneva che l'ordine mandato dal generale Arimondi di ritirarsi, non gli fosse pervenuto.
Che il generale Arimondi avanzatosi per sostenere il Toselli era arrivato alle ore 16 a mezza[387] strada fra Macallè e l'Amba nella posizione di Aderat; ivi incontrate le colonne nemiche aveva impegnate con esse combattimento ed aveva poi concentrate tutte le sue truppe col massimo ordine a Macallè; che lasciato Macallè fortemente presidiata e munita, si era messo in marcia per Adagamus assieme agli ufficiali Bodrero, Pagella e Bazzani.
Infine concludeva che mancavano notizie del Toselli.
L'annunzio del doloroso avvenimento produsse una impressione enorme.
Ecco le informazioni che si ebbero sul combattimento ove si coprirono di gloria coloro che vi presero parte.
Il maggiore Toselli aveva fin dal giorno precedente disposta la sua difesa, sempre con la certezza che il generale Arimondi gli avrebbe portato soccorso.
Aveva ordinato che le bande di ras Sebath e di Degiac Alì, 350 fucili, tenessero il colle a guardia della strada Falaga all'estrema sinistra; che le Compagnie Issel e Canovetti tenessero la sinistra con una centuria avanzata verso la chiesa[388] di Atzalà; che la batteria Angherà, scortata dalla compagnia Persico tenesse il centro; che le bande dell'Oculè Cusai, 350 fucili, tenessero le colline sovrastanti; che lo Sceicco Thalà con 340 fucili stesse sulla destra a difesa del Colle di Togorà-Maggia; che le compagnie Ricci, Bruzzi e la centuria Pagella stessero in riserva. L'attacco non si fece attendere.
La colonna di ras Oliè con una mossa rapida frontale avvolgente impegnò l'ala estrema sinistra: ras Sebat preso di fianco e di fronte dovette ripiegare, lasciando le due compagnie Issel e Canovetti scoperte e costrette a cambiare la fronte, pur sempre trattenendo il nemico incalzante. Intanto dal Colle di Bootà sbucavano imponenti le colonne di ras Mikael e di ras Makonnen, circa 15,000 fucili, dirette per la via principale verso il centro della posizione. La nostra ala sinistra, sebbene stremata, con brillanti contrattacchi teneva in rispetto forze venti volte superiori. Erano morti i tenenti Molinari e Basale, e ferito il tenente Mazzei.
A Toselli premeva tenere ancora quella posizione che proteggeva la strada diretta di Antalo, donde sperava veder giungere la colonna Arimondi[389] e slanciò a sinistra la compagnia Ricci; questi si avanzò e impegnossi a fondo. Il nemico dovette ripiegare incalzato sul fronte; frattanto la batteria apriva squarci nella pesante colonna scioana, ma questa riordinandosi e rafforzata da nuove bande continuava ad avanzare.
Giungeva allora (9,45) l'avviso di Volpicelli che un'altra forte colonna comandata da ras Alula e da ras Mangascià, tentava girare la destra tendendo al Colle di Togorà; anche da quella parte si facevano vive le fucilate. Toselli, non vedendo giungere gli sperati aiuti, decise di restringere la difesa e di tenersi addossato all'Amba; mandava quindi ordini a Ricci, a Canovetti, a Issel di eseguire un ultimo contrattacco e la ritirata sotto l'Amba; alla sezione Manfredini ordinava di proteggerli. Intanto la colonna principale scioana avanzava sulla batteria, nè valevano a trattenerla i tiri spessi e ben aggiustati e le salve della centuria Persico.
Toselli allora ordinava che le salmerie s'incolonnassero sulla via di Togarà ed il movimento cominciò regolarmente: a sostenere il movimento al nord dell'Amba, Manfredini ebbe ordine di spostarsi colla sezione da quella parte.[390]
Appena gli scioani si accorsero del cessare del fuoco della batteria, irruppero rincalzando l'assalto; fu un momento terribile; la strada strettissima sovrastante a un precipizio, era ingombra di muletti carichi di feriti; Manfredini con sangue freddo e valore inarrivabile riusciva a mettersi in batteria, Pagella si distendeva con pari valore a protezione della colonna affollantasi; sventuratamente lo Sceicco Thalà aveva ripiegato in disordine.
Le bande del Volpicelli erano disfatte; l'altura era coronata dalla gente di ras Alula che con fuoco accelerato a meno di cinquanta metri, infliggeva perdite enormi. I nostri ascari rispondevano al fuoco in ritirata; la compagnia Brizzi disfatta, non potè fare argine alle grosse colonne di ras Makonnen e di ras Oliè che irrompevano prendendo i nostri alle spalle. I sudanesi del tenente Scala, piuttosto che cedere i pezzi, rovesciarono i muli, i cannoni e le munizioni nel precipizio.
Manfredini mitragliava a cinquanta passi; ma il numero esorbitante degli scioani rese impossibile ogni ulteriore difesa. Allora cominciò la[391] discesa del dirupo precipitosamente per proseguire il movimento su Macallè.
L'ultimo a muoversi fu Toselli; conservando la sua calma, disposto come era a sagrificare la sua vita, dava ordini affinchè il danno fosse il minore possibile; erano rimasti intorno a lui pochi ufficiali: Angherà, Persico, Bodrero, Pagella e i suoi più fidi e valorosi soldati. Tutti erano sfiniti; e la piccola schiera andò man mano assottigliandosi nella discesa, colpiti a dieci passi di distanza. Giunto sulla strada di Antalo, Toselli, da vero eroe ordinò a Bodrero di raccogliere i pochi rimasti e condurli a Macallè. Egli, si voltò sereno verso il nemico, sfidandolo in attesa della sua sorte.
Bodrero, ubbidiente agli ordini del suo superiore, riordinò la colonna, trattenne i dispersi e li portò ad Arimondi che si trovava ad Aderà e nulla sapeva del combattimento; con Bodrero si salvarono Pagella e Bazzani.
Il giorno dopo il combattimento, Makonnen, ordinò solenni funerali alla salma del maggior Toselli, del quale ammirava il valore. Tutta l'Italia ha sentito per quest'Eroe un fremito di compianto e di orgoglio.[392]
L'assalto all'Amba Alagi fu dato improvvisamente come sempre, ed a tradimento, mentre pendevano trattative di pace ingannatrici.
Tant'è vero che avendo ras Mangascià investito alcuni dei nostri posti avanzati, il maggiore Toselli se ne lagnò con Makonnen, e questi rispondeva che Mangascià aveva operato di sua testa, contrariamente agli ordini da lui dati.—Vero esempio di fede abissina!
Il generale Arimondi raccolti i superstiti di Amba Alagi si ritirò su Adigrat lasciando per presidio a Macallè il maggiore Galliano col 3o battaglione indigeni, una compagnia dell'8o, quattro pezzi da montagna, due sezioni del genio, una stazione di carabinieri, in complesso 31 ufficiali, 176 uomini di truppa bianca, 1150 di truppa indigena.
Il 16 decembre questa nostra posizione avanzata era investita da 30,000 combattenti, gli assalti si susseguirono agli assalti, sempre valorosamente e brillantemente respinti.
Il giorno 8 di gennaio il nemico si avanzava arditamente fino all'angolo morto di due burroni, occupando l'acqua della quale si alimentava il presidio di Macallè; nella notte furono dai nostri respinti due furiosi attacchi.[393]
Le truppe nemiche che muovevano contro per annientarci e ricacciarci al mare eransi andate sempre più ingrossando fino ad arrivare alla cifra di 70,000 fucili, 10 mila lancie, più la cavalleria Galla ed altri piccoli riparti disseminati nelle vicinanze; in tutto oltre centomila combattenti. I nostri non avevano da apporre che circa 8000 soldati bianchi e 11,000 indigeni.
E si noti—che il generale Barattieri aveva previsto che nel novembre e dicembre la colonia sarebbe stata investita da tutta l'oste Tigrina e Scioana; per cui era da prevedersi che i nostri si sarebbero trovati di fronte ad un esercito di circa centomila uomini ben armati, della cui resistenza e valore avevano dato prove.
E allora perchè non si è provveduto a tempo in conformità dei bisogni e delle previsioni pur troppo esattamente avveratesi? Perchè il generale Barattieri che aveva preveduto il formidabile attacco non si preparò per tempo a bravamente respingerlo? Se non si voleva fare un agglomeramento di truppe nella colonia prima del bisogno, perchè non si provvedeva in Italia quanto occorreva per la preparazione di una grossa guerra, onde alla chiamata dei rinforzi[394] a momento opportuno, e che il governo non avrebbe dovuto lesinare, tutto fosse pronto? E preparata bene ed a tempo, non sarebbe stata una utilissima diversione quella di uno sbarco di nostre truppe ad Assab ed una spedizione all'Aussa che avrebbe trovato favore presso i Dancali—come così bene era stata progettata dal generale Pittaluga? Era cosa alla quale bisognava pensarci per tempo, e, presa una decisione, attuarla prima che le nostre poche truppe della colonia fossero impegnate a fondo. Non si può negare; fu grande la imprevidenza e ne fu scontato il fio!
Mentre i nostri a Macallè sostenevano con eroismo giorno e notte furiosi assalti, il Makonnen continuava per incarico del Negus di chiedere la pace; proposte che il Barattieri comunicava al governo. Messaggiero di tali proposte era certo signor Felter persona di fiducia del Barattieri, il quale aveva trasferito il suo quartiere generale ad Adagamus.
Il 17 gennaio il Felter si presentava al Barattieri portatore di un'offerta da parte di Menelik, garante Makonnen—di lasciare uscita libera con armi, munizioni di guerra, bagagli e[395] senza condizioni di sorta le nostre truppe da Macallè per raggiungere Adigrat.
Al Galliano fu dato l'ordine di lasciare il forte—dopo di essersi pienamente assicurato che tutte le garanzie sarebbero state completamente osservate.
Sembrò da prima che questo fosse un fatto da tenersi in conto ed atto a predisporre il governo italiano ad un trattato di pace onorevole per ambo le parti; invece si verificò che la concessione del Negus non era che un'astuzia di guerra; le forze comandate dal Galliano non dovevano essere che un ventaglio aperto per coprire la marcia delle orde Scioane verso Adua e per impedire alle truppe della colonia un attacco di fianco durante la marcia.
Rese libere le truppe del presidio di Macallè il giorno stesso nel quale venne segnalato al comando generale lo spostamento della gran massa dell'esercito nemico, Barattieri ordinava di levare il campo da Adagamus per occupare una posizione atta a mantenere il contatto delle forze della colonia con quelle del nemico; per cui dopo una marcia di 12 giorni, il 13 di febbraio il generale diede ordine di schierare i suoi battaglioni[396] sulle alture di Sauria, dominante la posizione di Mai Gabetà ed Adua occupate dal nemico.
Nella notte del 13 disertavano dal nostro campo le bande di Ras Sebath e di Degiac Agos Tafari di circa 600 fucili—questa diserzione fu il segnale dell'insurrezione nell'Agamè, per cui il Barattieri fu obbligato a pensare di garantire alle nostre truppe la linea di rifornimento; al quale effetto dovette distaccare dalla brigata Arimondi il colonnello Stevani con tre battaglioni, una batteria e due compagnie di indigeni, e nel tempo stesso chiamare da Adi-Ugri a Mai Maret il colonnello Di Boccard con tre battaglioni; per queste disposizioni le forze combattenti rimanevano ridotte a circa 14,000 fucili con 50 cannoni. Si aveva però il vantaggio che la posizione di Sauria era ottima per la difesa, convenientemente fortificata, coi fianchi ben appoggiati e difficilmente aggirabili; infine le nostre truppe, sebbene sensibilmente diminuite di numero, si trovavano in condizione da potere respingere qualsivoglia attacco. Nel frattempo il nemico vista la forte posizione dei nostri dopo di avere per un momento pensato ad attaccarli[397] si dileguava dietro i monti di Genedapla e finiva per ritirarsi nella conca di Adua.
Vi era quindi tutto da guadagnare nel rimanere nella forte posizione che l'immensa oste Scioana aveva permesso ai nostri di occupare senza molestie; si doveva renderla quanto più possibile inespugnabile ed attendere di essere assaliti, provocando anche il nemico con delle avvisaglie e con avvedute ricognizioni. Coll'attendere si suscitava il malcontento e la discordia nel campo nemico; gli Scioani avrebbero consumato le provvigioni che avevano tratte seco e sarebbero stati costretti di levare il campo e ritornarsene da dove erano venuti. È notorio che perfino un ufficiale russo, il capitano d'artiglieria Zviaghin, membro di una Commissione del suo governo presso Menelik e che aveva studiato con molta diligenza e con la maggior benevolenza lo stato di guerra dell'esercito etiopico, aveva dovuto sentenziare, che questo esercito doveva forzatamente ritirarsi, prima che le riserve delle vettovaglie che gli uomini portavano con se fossero esaurite.
Si è voluto invece precipitare—con 14,000 uomini si è preteso di portare vittoria su 80 a[398] 100,000 valorosi; tutta gente che aveva mostrato di sapersi battere; svelta nei movimenti, pratica di ogni palmo di terreno, avvezza per istinto agli accerchiamenti; e come doveva essere—si è andato incontro ad un immane disastro.
Colpa imperdonabile l'ebbe anche il governo. Presa la decisione di mandare al Comando generale il Baldissera, il governo aveva il dovere assoluto, imprescindibile, di subito informarne il Barattieri, ordinandogli contemporaneamente di mantenersi nella difensiva.
Il Barattieri invece d'accordo cogli altri generali Dabormida, Arimondi, Albertone, Ellena, decise di muoversi la notte del 29 febbraio da Sauria per marciare verso Adua—obiettivo l'occupazione della forte posizione costituita dal monte Semaiata e da monte Esciasciò.
L'ordine di marcia era il seguente:
Colonna destra, generale Dabormida—2a brigata fanteria—battaglione di milizia mobile—Comando 2a brigata di batteria, colle batterie 5a 6a e 7a.
Colonna del centro, Arimondi—1a brigata fanteria—1a compagnia del 5o battaglione indigeni—batterie 8a e 11a.[399]
Colonna di sinistra, Albertone—Quattro battaglioni indigeni—Comando della 1a brigata di batteria e batterie 1a 2a 3a e 4a.
Riserva, Ellena—3a brigata fanteria—3o battaglione indigeni—Due batterie a tiro rapido e compagnia genio.
La colonna di destra doveva seguire la strada colle Zalà, colle Guldam, colle Rebbi Arienni; la centrale e la riserva la strada da Adi-Dichi, Gundapta, colle Rebbi Arienni; la colonna di sinistra la strada Sauria, Adi-Cheiras, colle Chidane Maret; il quartier generale doveva marciare in testa alla riserva.
Ordine a tutti di mantenere il collegamento—e il corpo di operazione si mise in moto. Si marciava di notte in terreni sconosciuti ai nostri—era possibile non avvenisse qualche disguido?
La colonna Albertone arrivava al colle Chidane Maret alle 5 1/4; secondo le istruzioni avute vi si doveva stabilire, cercare il contatto colla destra ed aspettare ordini; invece il comandante desideroso della gloria di venire primo alle mani col nemico, commise il grande errore di rimettersi in marcia; cosicchè all'albeggiare giungeva[400] alle falde di Abba-Carima, mentre il 1o battaglione indigeni (maggiore Torrito) in avanguardia si trovava a circa 3 chilometri spinto più avanti; per cui avanguardia e colonna Albertone della sinistra, si erano allontanate di gran lunga dalle altre brigate e prive di ogni contatto.
Difatti alle 8 1/4 il battaglione indigeni (Torrito) avanguardia Albertone, fu il primo ad essere attaccato da forze preponderanti e nonostante la più disperata difesa fu rotto e posto in fuga; nel medesimo tempo le alture di Abba-Carima e l'Amba Scellodà si videro coronate da numerosissimi stormi di nemici, che investirono la brigata Albertone, isolata ad una distanza di sei chilometri e nell'impossibilità di essere soccorsa.
Il generale Albertone non si smarrì; lottava con la sua brigata contro forze dieci volte superiori e ne faceva strage, ma minacciata di aggiramento alla sua sinistra gli ascari non tennero più, e volsero il tergo al combattimento e si diedero alla fuga; invano gli ufficiali tentarono di fare argine, di arrestarli per ricondurli al combattimento, essi stessi venivano travolti da quella valanga.
Frattanto al colonnello Brusati era riuscito[401] di stendere sulla sinistra di monte Belah due battaglioni del suo reggimento, e sebbene la brigata indigena continuasse a combattere efficacemente non impressionata dalla fuga degli ascari, pure il generale Barattieri alle 7 1/4 credette opportuno di mandare all'Albertone l'ordine di ritirarsi sotto la posizione della brigata Arimondi. Alla brigata di riserva era dato ordine di rinforzare la sinistra di Arimondi.
Ma la brigata Albertone era sempre più furiosamente attaccata da forze, contro le quali era impossibile lottare, in guisa che alle 11 era completamente avvolta e i reparti venivano colpiti dal fuoco nemico sul fronte, sui fianchi e di rovescio. Dopo avere subito perdite enormi, dopo avere perduto la maggior parte degli ufficiali, le truppe indigene cominciarono a ritirarsi prima alla spicciolata poi a grossi reparti; queste prive dei loro ufficiali, perfino dello stesso generale Albertone di cui non si aveva più notizie, non si poterono più riordinare e la rotta fu completa e convertita in fuga spaventosa.
Ne avveniva quindi che fuggiaschi e sterminate colonne nemiche che inseguivanli alle reni[402] erano sopra alla brigata Arimondi, che si ordinava in posizione di resistenza e di contrattacco.
Invano il bravo colonnello Brusati tentava coi suoi di fare argine; invano il valoroso colonnello Galliano aveva schierato il 3o battaglione indigeni all'estrema sinistra per arrestare i fuggenti e tener testa all'irrompente nemico, tutti gli sforzi di questi eroi e dei loro ufficiali furono inutili; i battaglioni scossi dallo spettacolo che si manifestava ai loro occhi, malgrado gli sforzi dei loro comandanti, dei loro bravi ufficiali, malgrado l'esempio di serena bravura che dava il battaglione 9o (bianco), malgrado le batterie che facevano fuoco vivissimo, si davano alla fuga.
Frattanto gli ascari in fuga, tirandosi dietro forti masse di scioani, scuotevano le truppe delle brigate Arimondi ed Ellena che non avevano modo di spiegarsi e di prendere posizione. Mentre il generale Arimondi impartiva ordini alle batterie, le orde scioane, girando sul fianco sinistro, irrupero in massa addosso alla colonna e coronate le cime di monte Belach, facendo fuoco d'inferno sui nostri soldati bianchi e neri che si affollavano nell'insenatura, ne facevano strage.[403]
Il prode Arimondi e il di lui aiutante di brigata ai quali erano stati portati via i muletti non poterono togliersi dalla disastrosa posizione e rimasero accerchiati.
Il generale Barattieri, visto che nè i bersaglieri, nè gli alpini avevano potuto tener testa e che tutte le alture si coprivano di nemici, chiamato a sè il colonnello Stevani si dirigeva verso il colle Rebbi Arienni, incontrava per la via il colonnello Nava e Vandiol del 16o battaglione, e disponeva per la ritirata verso il vallone.
Ma il tumulto cresceva colle ondate dei sopravenienti inseguiti e col grandinare delle palle. Era uno spettacolo da squarciare il cuore! Quanti valorosi ufficiali caddero non è possibile dire. A fianco di Barattieri cadevano il colonnello Nava e il tenente Chigi. Quando Barattieri giunse nella convalle presso Rebbi Arienni vi trovò il generale Ellena. Ivi chiamò a raccolta; fu raggiunto dal tenente colonnello Musini, dal tenente Marchiori degli alpini, dal capitano Bedini, dal tenente Partini, dal tenente colonnello Violante, dal tenente Ribotti, dal capitano Grassi e da altri e riuniti qualche centinaio di truppe fra alpini, bersaglieri ed altre armi si organizzò la[404] resistenza per far possibilmente arrestare la foga del nemico.
Mentre questo succedeva alle brigate Albertone, Arimondi ed Ellena ecco quel che avveniva alla brigata Dabormida.
Verso le 6 la testa della brigata si fermava sul ciglio del colle Rebbi Arienni. Il generale Dabormida dopo di avere mandato avviso al comando che occupava il colle senza avere potuto mettersi a contatto coll'Albertone, proseguiva oltre solo accompagnato dal capitano Bellavita suo aiutante di campo e dal tenente Piva suo ufficiale d'ordinanza, allo scopo di formarsi una idea del terreno sul quale avrebbe dovuto operare, mentre la brigata prendeva formazione di ammassamento sul colle; intanto che il battaglione De Vito di avanguardia marciava più innanzi per vedere di trovare il contatto colla brigata Albertone.
Il generale Dabormida ritornato dalla sua esplorazione, visto il generale Barattieri che stava alquanto più indietro gli andò incontro e s'intrattenne a parlare con lui impensierito di non avere nuove dell'Albertone; a poca distanza l'Arimondi s'intratteneva coi colonnelli Airaghi e[405] Ragni sullo stesso argomento giacchè tutti ne erano grandemente preoccupati.
Verso le 7 la brigata Dabormida riprese, pian piano, nell'ordine di prima, la marcia in avanti, mentre il comando supremo rimaneva sul colle, dirigendosi per la valle che va a Mariam Sciavitu e ad Adua.
Il campo di battaglia della brigata Dabormida si divideva in tre parti; alture di sinistra, fondo della vallata, alture di destra, e il generale dava ordini alle truppe di prendere posizione sulle alture.
Non appena i nostri ebbero raggiunto la sommità delle alture scorsero dense truppe nemiche dirette ad occupare una specie di sprone che da Monte Derar va verso Adua; un altro forte nucleo nemico con reparto di cavalleria Galla si dirigeva verso il Vallone. La compagnia Sermani all'appressarsi del nemico si era spiegata ed aveva aperto il fuoco; il maggior De Vito ordinava alle sue truppe di occupare celeremente il controforte prima che vi arrivasse il nemico; come un onda nera, i bravi indigeni si precipitano giù pel burrone, l'attraversano e ansanti risalgono l'altura agognata; Tola e Ferrero[406] hanno raggiunto la posizione appena in tempo per aprire il fuoco sul nemico che sale dall'opposto versante; erano le 9, il combattimento era impegnato su tutta la fronte, dalla cresta principale, lungo tutto il controforte, fino al fondo della vallata; la compagnia del Chitet è obbligata a ripiegare, per cui il battaglione del De Vito già colpito a morte, e minacciato sull'ala destra. Frattanto il nemico ingrossa, il fuoco raddoppia e semina morte: molti ufficiali sono caduti, i reparti tentennano e all'estrema sinistra hanno incominciato a ritirarsi; il tenente Gaslini si getta con un pugno di bravi fra i nemici, cade, ma la compagnia Longo riprende il suo posto; il nemico ingrossa, investe con una pioggia di piombo e gl'indigeni si ritirano e si sbandano; la precipitosa ritirata poco mancò non travolgesse i reparti del 3o reggimento; ma appena fu sgombrata la fronte le truppe comandate dal colonnello Ragni, prima col fuoco e poi colla bajonetta arrestava la foga del nemico, respingendolo sul dorsale dello sprone.
Nel frattempo il colonnello Airaghi avanzava colle sue truppe calme ed ordinate, con le batterie in battaglia scortate dal 14o battaglione; si[407] erano appena messi in batteria i pezzi, che il nemico si lanciava con urli feroci all'assalto; le nostre truppe non si mossero, aprirono il fuoco a ripetizione e l'artiglieria alla mitraglia; un fuoco micidiale: la carica è rovesciata, il nemico si ritira in disordine decimato, e il fuoco andò rallentandosi e parve languire; erano verso le 12 e il generale ed il colonnello Airaghi credettero buono il momento per un attacco offensivo onde scacciare il nemico dalle posizioni e diedero gli ordini necessari. La brigata fu disposta con una calma con una regolarità di un'esercitazione in tempo di pace; le truppe sulle alture di sinistra agli ordini del colonnello Ragni; quelle nel piano al comando del colonnello Airaghi; tutte con le catene e sostegni; più indietro la riserva; l'artiglieria al centro comandata dal Zola; tutti con ordine ammirabile pronti all'attacco con un morale elevatissimo.
Si vedeva però nel generale qualche cosa che lo contrariava—una nube offuscava la serenità del suo volto—non aveva potuto dar mano all'Albertone, non aveva avuto nessuna notizia della brigata Arimondi colla quale aveva perduto il contatto, nè alcuna dal Comando supremo e questo lo angustiava.[408]
Il generale più tardi ordinò uno sbalzo più innanzi per tastare il nemico, ma questo non si mosse, soltanto raddoppiò il suo fuoco e mise in batteria sullo sprone delle alture del tucül alcuni pezzi d'artiglieria dai quali non trassero alcun effetto.
Mentre così procedeva il combattimento della brigata Dabormida sulla fronte verso Adua, alle sue spalle, nella vallata succedente al Rebbi Arienni avveniva il tragico esodo della colonna Arimondi—arrestata nei suoi movimenti dai fuggiaschi della brigata Albertone, inseguiti alle reni da una massa imponente di nemici—veniva essa pure travolta e decimata prima che avesse potuto spiegarsi e prendere posizione per una energica difensiva.
Non è possibile descrivere gli atti di valore—gli eroismi dei nostri ufficiali per sbarrare la via ai fuggiaschi—per arrestare le irrompenti—enormi masse nemiche.—Il colonnello Brusati alla testa del suo reggimento riuscì di tener testa e di fermare per alcun tempo la nera fiumana, ma minacciato da avvolgimento fu costretto a ripiegare—nel farlo ordinava a se il resto della brigata e dopo di avere tentato[409] un'estrema resistenza, ne formava una colonna che guidò con fermezza ed intelligenza, radunando le truppe disperse e facilitandone la ritirata. Per il suo eroismo, per la sua ammirevole condotta, veniva decorato della Croce all'Ordine militare di Savoia.
Della rotta della brigata Arimondi di questo tragico fatto—nulla si sapeva nella colonna Dabormida, e certamente non fu avvertita neppure dal battaglione De Amicis del 4o reggimento Brusati, che dalle 10 si era schierato sull'altura dominante il colle d'accesso alla vallata, posizione che gli era stato ordinato di occupare per proteggere il fianco della brigata Arimondi e per cercare il contatto colla brigata Dabormida, altrimenti quel battaglione non si sarebbe limitato a rimanere in quella posizione per proteggere le spalle della brigata Dabormida, ma si sarebbe fatto un dovere di avvisarne prima il Dabormida, poi di accorrere senz'altro in aiuto della brigata alla quale apparteneva il suo reggimento.
E il De Amicis non stette a lungo inoperoso; visto la Brigata Dabormida impegnata nella valle sottostante, persuaso che la sua presenza nell'altura[410] non aveva più scopo, perchè sulla destra della direttrice di marcia un'altra brigata aveva impegnato il combattimento, scese dal colle per correre in appoggio ai combattenti; però aveva appena lasciata l'altura che alcuni cavalieri Galla si mostravano sul colle abbandonato; il De Amicis vide subito la necessità di ritornare sull'abbandonata posizione ed a passo di corsa si mosse per rioccuparla; sotto il fuoco nemico il battaglione potè raggiungere un recinto murato, ed ivi trincerarsi.
Nel frattempo il generale Dabormida inteso il fuoco di fucileria sull'altura occupata dal De Amicis mandava ordine al maggiore Rayneri di mandare la sua 1a compagnia a scorta dell'artiglieria, e col resto del battaglione portarsi a rinforzare le truppe del De Amicis, scacciare il nemico e liberare la brigata da qualsiasi minaccia da tergo; l'aiuto giunse in tempo e il nemico potè essere respinto nella sottostante vallata proveniente dal Rabbi Arienni; e fu fortuna che anche il 13o battaglione valendosi di altro recinto in muro a secco assieme al 5o battaglione, poterono occupare solidamente le due alture a tergo e resistervi fino a sera, senza[411] di che la brigata Dabormida avrebbe visto precipitarsi alle sue spalle la maggior parte del grosso del nemico che ritornava dall'avere rotte e disperse le altre due brigate, ed avrebbe avuto preclusa ogni via di ritirata.
Dopo il mezzogiorno fra le truppe del Dabormida e le scioane sul fronte d'Adua si ravvivava la fucilata; la nostra artiglieria si era piazzata sullo sprone delle alture dei tucül. Ad ogni colpo di Shrapnel si scorgeva un rapido sbandarsi degli scioani attraverso le roccie e i rovi; quelli diretti verso lo sbocco della vallata facevano solchi profondi nelle folte colonne nemiche, coperte da alta erba. Il colonnello Airaghi rompe gl'indugi; alla testa del suo reggimento lancia le truppe nel piano ad un primo poi ad un secondo assalto; ed il colonnello Ragni che dal mattino si è trovato sulla linea del fuoco, appoggia gli sforzi del suo collega, quantunque gli aspri fianchi delle alture da dove combatte, gli renda impossibile di mandare avvisi e ricevere ordini.
Ma lassù nelle alture il nemico tiene fermo, e quantunque nel fondo della valle si fosse ritirato, grandi masse riaprono in tutto il fronte[412] un fuoco micidialissimo, per cui i nostri bravi sono costretti a ritirarsi dalle posizioni avanzate guadagnate poco prima, e il nemico riprende le proprie. Le perdite sono gravi assai, fra altri sono caduti i capitani Casadei, Sini, Messaglia, il tenente Vitali, i due tenenti medici Miccichè e Lombi, e molti altri.
I nostri battaglioni hanno ordine di accelerare il fuoco; le batterie secondano mirabilmente; fanno due sbalzi in avanti; ma il nemico non si muove nè dalle alture nè dal fondo della vallata; un centinaio di metri divide i nostri dalla fronte nemica che fa un fuoco d'inferno; le artiglierie rombano con fragore indemoniato; la tromba squilla il pronti per l'assalto; il generale Dabormida come se si trovasse ad una parata, con a fianco il colonnello Airaghi, seguito dagli ufficiali del comando oltrepassa a cavallo la linea di fuoco—in tutti corre un fremito—un urlo tremendo si leva, "Savoja, Savoja!" e dal primo all'ultimo, a denti stretti, con ardore feroce, con l'arma in pugno si slanciano all'assalto; l'urto fu terribile—irresistibile, perchè il nemico ne è rovesciato, costretto a volgere le spalle e darsi confusamente alla fuga—le trombe suonarono alt e fuoco e[413] una scarica a salva investe la terga del nemico. Era la vittoria! e un grido proruppe unanime. "Viva l'Italia! Viva il Re!"
Ad un tratto, potevano essere le 14, un grosso rumore di fucileria da tergo gela il sangue degli eroici combattenti. Grossi stormi di cavalieri galla si videro scendere dal colle e dietro la cavalleria un nero nembo di fanteria. All'imminenza di un attacco da tergo il bravo generale Dabormida non perdette l'ammirabile sua calma giacchè non avrebbe potuto supporre che tutto il resto dell'esercito fosse scompaginato, e già rotto e lontano: urgeva provvedere perchè il De Amicis e Rayneri tenessero fermo nella loro posizione; e questi rimasero saldi come torri fin all'ultimo; l'azione di questi due battaglioni fu veramente eroica e provvidenziale.
Si sa già che cosa era avvenuto: battuta la colonna Albertone che si era distanziata dagli altri corpi e messa nell'impossibilità di essere soccorsa, il nemico dieci volte superiore ai nostri inseguendo gli indigeni in fuga capitarono precipitosamente sulla brigata Arimondi che stava prendendo posizione, la scompagina, la rompe e mette in fuga e colla stessa rapidità piomba sulla[414] brigata Ellena di riserva e sgomina e disperde pur questa. Atti eroici furono compiuti dalla brigata Arimondi, altrettanti e pure eroici dalla brigata Ellena ma, questi non riuscirono a frenare la valanga impetuosa delle enormi masse nemiche che inseguendo i fuggiaschi tutto travolgevano e rovesciavano.
Rotte, sgominate le tre brigate Albertone-Arimondi-Ellena, poste in fuga e lanciate alle loro calcagne arditi distaccamenti e grossi reparti di cavalleria galla, tutto il grosso dell'esercito abissino si rivolse dove ancora si combatteva con tanto eroismo da obbligare più volte forze assai superiori alla ritirata; e da quel momento la situazione della brigata Dabormida diveniva disperata. Bisognava prepararsi ad un'ultima e disperata difesa la gloriosa brigata si lancia contro il nemico su tre fronti. Il generale Dabormida a cavallo a capo scoperto e coll'elmo nella mano destra, si lancia avanti a tutti, il colonnello Airaghi lo segue con la sciabola in alto, eroicamente eccitando i suoi bravi alla pugna!
Un urlo tremendo!—e disperatamente le nostre truppe si precipitano sul nemico che non indietreggia, impedito a retrocedere dalla massa[415] enorme che gli si accalca addosso e l'obbliga ad avanzare—ma la lotta a corpo a corpo è terribile—tanto è il furore dei nostri—tanta è la strage che seminano intorno a loro che la massa scioana ne è scossa, ondeggia ed è costretta a cedere terreno.
Lo spazio necessario per la ritirata è aperto—ma quanti prodi seminati per la via sanguinosa! Pel prode generale fu un momento ben triste quando rivoltosi al colonnello Airaghi gli disse "Airaghi bisogna iniziare la ritirata: tu la coprirai col tuo reggimento!" "Va bene generale" rispose il colonnello del 6o reggimento e si separarono per non vedersi mai più!
Dabormida si diresse all'imbocco dell'angusta valletta per dove dovevano sfilare le truppe in ritirata, e dava gli ordini opportuni; poi preoccupato della sua sinistra, insieme al capitano Bellavita suo aiutante di campo volle ascendere l'aspra altura ove ancora combattevano i battaglioni De Amicis e Rayneri.
Era di lassù che solo potevasi coprire la ritirata delle truppe combattenti nella valle. Rifiutandosi il cavallo di salire per l'erta dovette scendere; incaricò il capitano Bellavita di portare[416] i suoi ordini al De Amicis e al Rayneri di tener fermo ad ogni costo, e ridiscese per dirigere l'incolonnamento della brigata.
Quando il Bellavita ritornò dopo avere impartiti gli ordini, il generale Dabormida, questo fulgido eroe leggendario, era scomparso!
Finito il periodo epico dei gloriosi combattimenti, si dava principio a quello tragico di una disastrosa ritirata! E, come era da immaginarsi, ne seguì una carneficina orrenda.
I battaglioni De Amicis e Rayneri che avevano strenuamente sostenuto l'urto di un nemico più che quintuplo e che ancora stavano sulle alture a proteggere la ritirata, quando videro che il 6o ed ultimo reggimento si ritraeva per lo sbocco della valletta ad imbuto, anch'essi abbandonarono le trincee fin allora difese per ridursi al colle e ritirarsi; nella stretta insenatura di questa si svolse l'esodo triste di una grande brigata!—Soprafatta dal numero, sfinita dalla sete, dalla fame, lacera, semiscalza, dopo una intera giornata di combattimento, senza tregua, abbandonava il campo col cuore stretto dall'ambascia, ma fiera per il dovere compiuto! Fu una scena d'orrore illuminata dagli ultimi raggi del[417] sole, che esso pure andava morendo. La brigata aveva strenuamente, eroicamente combattuto dal sorgere al tramontare del sole. Tutto era perduto anche per la brigata Dabormida—non era certo perduto l'onore.
Ah! se le nostre quattro brigate avessero mantenuto il contatto! quale scempio delle orde scioane avrebbero fatto! E fu fatalmente strano che a questo non si sia rigorosamente provveduto! e non si sia pensato che è un principio incontestabile di guerra che un esercito di fronte al nemico deve sempre tenere le sue colonne riunite, in guisa che il nemico stesso non possa mai introdursi fra le medesime. Anche quando si sia dovuto dividere un esercito affine d'avviarlo per linee concentriche contro il nemico, è necessario all'approssimarsi ad esso per dare battaglia, che gl'intervalli fra le diverse colonne siano raccorciati tanto che queste possano a vicenda agevolmente soccorrersi e sostenersi. E a questo principio elementare di guerra nella fatale giornata di Adua non si è pensato!
Che ne era avvenuto del generale Dabormida, del colonnello Airaghi, del maggiore De Amicis e di tanti e tanti altri eroi? Nessuno sapeva dirlo![418]
Il valoroso colonnello Ragni comprese che era a lui ormai serbato un altro grave dovere, quello di dirigere la ritirata. Verso le 19 la colonna sboccò su di un ripiano sul quale si elevava una specie di controforte; il colonnello decise di far quivi l'ultima resistenza per riordinare al riparo di questo ed alla meglio la confusa massa dei superstiti. Il capitano Pavesi coi suoi ufficiali Benito (ferito), Camelli, Caloria, con la loro bella compagnia del 5o indigeni, formarono il nucleo principale della più che ardita difesa; là si trovarono e si riunirono i maggiori Prato, Raqueni e De Fonseca; i capitani Paperotti, Guastalla, Liquori, Sciarra, Cicerchia, Voet, Bellavita; i tenenti Matteucci (ferito), Massazza, Angelini, Zonchello, Benetti, Carossini, Donedu (ferito), Bairi, Neri (ferito) ed altri ed altri.
Il nemico vista la tenacia temeraria dei nostri non volle avventurarsi nell'oscurità della notte e cessò dall'inseguimento, per cui la ritirata potè compiersi, ma seminando nei giorni appresso altre ossa lungo tutta la via ben dolorosa, perchè i superstiti furono continuamente assaliti dagli insorti nei paesi che attraversavano.
Nel combattimento d'Adua cadde da eroe, fra[419] tanti e tanti altri, il capitano Leopoldo Elia di Ancona, il prode garibaldino ferito a Mentana, il valoroso soldato dell'esercito alla breccia di Porta Pia. Egli era già stato in Africa colla spedizione di San Marzano quale capitano dei bersaglieri; vi era rimasto per due anni e fu costretto a rimpatriare per grave malattia. Ricuperata la salute lo si tolse dall'arma dei bersaglieri, nella quale aveva fatta tutta la sua carriera, grado a grado, fino a quella di capitano—arma che egli idolatrava!
Fu un colpo assai doloroso per lui—e per mostrare che avevano avuto torto di toglierlo dal corpo suo prediletto, appena si ebbe notizia dell'eroica giornata di Amba-Alagi, non chiamato, offriva volontario i suoi servigi alla patria e ripartiva colla brigata Ellena.
Nella fatale, ma pur gloriosa giornata d'Adua, schierata la sua compagnia sotto un fuoco infernale nemico, nella posizione che doveva tenere e difendere, incuorando i suoi bravi soldati che l'adoravano, dando loro l'esempio, eroicamente combattendo, per più ore sostenne urti tremendi che sempre respingeva; ma infine circondato da migliaia di nemici, senza ritrarsi d'un passo,[420] vendendo cara la vita egli e i suoi bravi che sempre assottigliandosi si stringevano intorno a lui, cadeva ferito per non più rialzarsi. Così finivano quasi tutti della compagnia comandata da Leopoldo Elia, preferendo morire piuttosto che darsi prigionieri.
E un altro valorosissimo lasciava la vita in quella fatale giornata, un carissimo amico dell'Elia che merita di essere ricordato, il capitano Ciro Cesarini di Corinaldo.
Uscito dalla scuola di Modena entrava come sottotenente nel 4o reggimento bersaglieri. Nel 1894 domandò ed ottenne di essere mandato in Africa e venne destinato col grado di tenente alla 2a compagnia cacciatori di guarnigione a Keren.
Dopo pochi mesi venne chiamato alla 3a compagnia del 2o battaglione indigeni comandato dal maggiore Hidalgo—combattè da valoroso per l'espugnazione di Cassala e vi guadagnò la menzione onorevole e per merito fu promosso capitano nella 1a compagnia del 1o battaglione indigeni sotto il comando del maggiore Turitto.
Col suo battaglione prese parte alla battaglia di Debra-Ailà ed all'inseguimento di Ras Mangascià.[421]
Quando si formò il corpo di operazione contro gli Scioani, col suo 1o battaglione indigeni entrò a far parte della brigata Albertone—che come si è visto—fu la prima ad impegnarsi nel combattimento del 1o marzo—ed a sostenere tutto il grave peso dell'immensa oste nemica per essersi distanziata dalle altre nostre brigate.
Dopo la triste notizia del disastro toccato alle armi nostre nella battaglia d'Adua, alla famiglia, ai concittadini, agli amici, trepidanti per la sua sorte, venne notizia che il capitano Cesarini si trovava ad Adigrat; però la novella fu presto smentita. Solo poté essere accertata la sorte del valoroso capitano, quando fu liberato dalla prigionia l'ultimo scaglione dei prigionieri di Menelik del quale faceva parte il tenente Fuso, unico ufficiale superstite della compagnia comandata dal Ciro Cesarini, del quale raccontava così l'eroica fine.
"Il capitano Cesarini con la sua compagnia fu il primo ad attaccare il nemico e ne sostenne il fuoco per due ore di seguito.
"Quando il generale Albertone—dopo accanito combattimento contro masse nemiche[422] dieci volte superiori alle sue forze—minacciato di avvolgimento—si trovò costretto ad ordinare la ritirata—il capitano Cesarini col resto della sua compagnia e con quanti altri potè raccogliere, venne incaricato di proteggere la ritirata—Ed egli—dando esempio ai suoi che in pochi rimasti si serravano intorno a lui—non abbandonava un palmo di terreno e battendosi come un leone compiva fin all'ultimo eroicamente il suo dovere. Ferito ad un braccio continuò a combattere—ma una palla gli fracassò un ginocchio—la ferita era orribile—il sangue ne usciva a fiotti—gli spasimi dovevano essere atroci.
"Io ed il furiere della compagnia volevamo prestargli soccorso—ma egli—visto che per lui era finita—ci pregò di non occuparci di lui—ordinava a me di prendere il comando della compagnia e di resistere fino all'ultimo.
"Allora lo trasportammo in una specie di grotta che vi era lì appresso—durante il tragitto perdette i sensi—lo adagiammo alla meglio e più non lo rivedemmo".
Ecco quanto il generale Albertone dice di questo bravo e della sua eroica compagnia.
"La compagnia rimasta col tenente Fuso,[423] che ne aveva assunto il comando, col furiere ed una trentina di soldati Ascari rimasti, respinse quattro volte il nemico con altrettanti attacchi alla baionetta.
"Durante la mia prigionia intesi più volte dai capi Abissini la narrazione dei prodigi di valore del capitano Cesarini, il quale aveva meravigliato gli stessi nemici".
E combattendo da valorosi lasciavano in quella giornata la vita pure, il prode tenente Monina Attilio, ed i forti giovani Adolfo Muzzi, Alfredo Pettinelli, Adolfo Santarelli, Cesare Salustri, Cesare Stramazzoni.
O forti e valorosi soldati—la vostra fine non doveva essere diversa! Solo agli eroi è dato la gloria di morire ravvolti nella propria bandiera!
Ancona e i luoghi della sua provincia che vi dettero i natali conserveranno sacra la vostra memoria!
Al generale Baldissera toccò di compiere le operazioni militari nel secondo periodo della campagna d'Africa 1895-96.
Con rapide mosse, con ardite dimostrazioni[424] su Coatit, su Debra-Damo e su Adua, affine di coprire il vero obiettivo del corpo di operazione, riusciva in breve a liberare il presidio d'Adigrat; a riordinare gli avanzi del primo corpo di operazione che aveva combattuto ad Adua; a coprire la colonna minacciata nel punto più vitale; ad iniziare trattative di pace col precipuo scopo di guadagnar tempo, per ottenere la liberazione dei nostri prigionieri, il seppellimento dei nostri morti;—e portare soccorso a Cassala.
Operazioni tutte condotte a compimento con militare energia e con sommo accorgimento da meritare il plauso del paese.
Nel 1897—un grido di entusiasmo echeggiava da un capo all'altro d'Italia per la causa ellenica—il filellenismo fu sempre fra noi una delle corde che più vibrarono nel cuore di quanti sentivano amore di patria e di libertà—e tutte le volte che la Grecia tentò di sottrarre dall'onta del governo turco le belle terre che le appartengono, l'Italia non vi rimase insensibile e mandò[425] i migliori suoi figli a combattere per la sua redenzione.
Sarebbe troppo lungo il ricordare i patriotti che le diedero la vita in tempi ormai lontani ma pur non dimenticati; basterebbe ricordare il Santorre Santarosa—nel 1821—il Basetti—il Tarella—il Mamiot—il Tirelli—il Briffori—il Tarsio—il Viviani—il Torricelli—il Prenario—il Miovitowich—il Dania—il Rattelani—che diedero la vita per la Grecia nel 1822—e l'Andrea Broglio marchigiano che lasciava la vita ad Anatolica nel 1828—come molti greci lasciarono la loro vita per la causa italiana; accenneremo ai più recenti, e diremo che insorta l'isola di Creta dopo la campagna del 1866, ben duemila e più volontari e non meno di ottanta ufficiali corsero a dare agli insorti il loro aiuto. I primi, sbarcati a Sira furono posti sotto gli ordini di Zambra-Kakis, Bisanzios, e Coracas, gli altri sotto il comando del maggiore Mereu, e tutti diretti all'isola di Creta ove si combatteva per la propria indipendenza.
Al Mereu prima della sua partenza il generale Garibaldi consegnava la lettera seguente:[426]
Caprera, 9 ottobre 1866.
"Il maggiore Mereu, uno dei miei prodi compagni d'armi, va in Grecia per combattere la santa causa di quel paese.
"Io lo raccomando caldamente ai miei amici.
G. Garibaldi".
In tutti i combattimenti per l'indipendenza della Grecia il sangue italiano fu sparso gloriosamente.
Nel 1867 la Grecia minacciava di sorgere in armi per la questione non solo di Creta ma anche per la causa macedone: una nuova spedizione di Toscani guidata da Sgarellino partiva da Livorno; toccata Caprera prendeva il comando della spedizione il bravo giovane Ricciotti Garibaldi.
Egli partiva diretto non a Candia ma al Pireo, con istruzioni del padre di vedere di portare la rivoluzione nell'Epiro e nell'Albania e di far sapere che se l'insurrezione avesse luogo, anche egli sarebbe accorso sul campo dell'azione.
Ma mentre un comitato ellenico era dietro ad organizzare un movimento sulla frontiera Epirota;[427] l'intervento delle potenze intimava alla Grecia di spegnere il movimento nel suo nascere, e i volontari italiani dovettero rimpatriare.
Nel 1875, Mico Liubibratic, un eroe Erzegovese, che col Vucalovich si era mantenuto in campagna contro i Turchi per l'indipendenza della sua patria fino al settembre 1862 riportando segnalate vittorie il 13, 14, 18 ottobre—tali da destare l'universale ammirazione e da obbligare il governo ottomano a segnare in Ragusa un trattato favorevole all'Erzegovina (trattato i cui patti non furono poi rispettati)—aveva ripreso le armi e indirizzava un fiero proclama alla gioventù di tutte le nazioni, perchè rispondessero al suo appello. Garibaldi alzava anche esso la sua voce in favore dell'Erzegovina col seguente proclama:
A Liubibratic ed ai suoi gloriosi compagni!
"Miei cari amici,
"Voi vi siete assunti una difficile missione, ma bella, superba, santa; quella dell'emancipazione degli Slavi dalla più atroce delle tirannidi.
"Io vi invidio e giammai tanto mi pesarono gli anni come oggi, che non posso dividere con voi glorie e perigli.[428]
"Già m'indirizzai a tutte le popolazioni che languono sotto il giogo ottomano e non dispero di vedere raggiungere la vostra bandiera dai prodi che contano nella loro storia i Leonidas, gli Spartachi e gli Scanderberg.
"Il vostro divisamento di sostenere la guerra di partigiani durante l'inverno, lo credo il migliore; l'avvenire è vostro. Qualunque uomo che non sia un perverso farà sua la causa vostra e come noi palpiterà di gioia al vostro glorioso trionfo".
Roma, 29 ottobre 1875.
Vostro
G. Garibaldi.
Al patriota esule triestino, presidente del Comitato per gl'insorti erzegovini, scriveva così:
"Mio caro Popovich,
"Ove rimanesse un insorto solo nell'Erzegovina, bisogna aiutarlo.
"Io spero che Liubibratic e compagni si sosteranno sino alla primavera. Intanto bisogna lavorare per loro a tutta forza.
"Dite ai valorosi del Montenegro che il mondo[429] ammira il loro eroismo, e salutateli caramente per me".
Roma, 31 ottobre 1875.
Sempre vostro
G. Garibaldi
E quando ebbe per telegramma i particolari della battaglia di Piva nella quale i Turchi toccarono una solenne sconfitta, così gli scriveva:
"Caro Popovich,
"I liberi d'ogni paese europeo esultano per la splendida vittoria degli eroici figli dell'Erzegovina orientale".
Roma, 5 novembre 1875.
G. Garibaldi.
Non è quindi da meravigliarsi se all'annunzio dell'insurrezione di Creta nel 1897 e dell'attitudine del governo Ellenico di sostenerla anche a mano armata contro il Turco, in Italia vecchi patrioti e giovani di cuore ardente, sentirono il sacrosanto dovere di continuare la gloriosa tradizione della camicia rossa, quale simbolo di libertà per gli oppressi.
Per opera dell'insigne patriota Ettore Ferrari, coadiuvato dal colonnello Gattorno, si formò un[430] corpo di garibaldini. Ma in parte per le difficoltà frapposte dal Governo Italiano, che per riguardo ai trattati internazionali doveva ostacolare l'imbarco dei volontari, ma ancor più per le incertezze dello stesso governo di Grecia, il numero degli accorsi fu assai limitato. E per provare che tali incertezze riuscirono dannose alla causa ellenica, basti il dire, che avendo il generale Menotti Garibaldi (col quale sarebbero andati i colonnelli Pais, Cariolato, Elia, Bedischini e tanti e tanti che lo avrebbero seguito da formarne una divisione) telegrafato al fratello Ricciotti se doveva partire, riceveva risposta, che gli diceva inutile la partenza, giacchè riteneva, dal modo come si mettevano le cose, che forse egli stesso sarebbe stato costretto a fare ritorno in Italia.
Per tutte queste contrarietà si potè solo formare intanto un 1o battaglione di duecento cinquanta uomini, che comandati dal Mereu, furono i primi a partire per la Grecia. Del grosso del corpo di ottocento uomini, formatosi poi, il generale Ricciotti Garibaldi comandante di tutta la Legione, ne formava altri due battaglioni il 2o e il 3o.
E ci volle tempo non breve, dopo giunti al[431] Pireo e ad Atene, perchè questi bravi potessero avere le armi e il più stretto necessario per un corpo destinato a combattere. Finalmente il 7 di maggio il Ministro della guerra partecipava al comandante del corpo garibaldino generale Ricciotti Garibaldi, l'ordine di marcia.
Il giorno 9 la Legione approdava ad Hagia-Marina; ivi giunta il generale avvisava telegraficamente il principe Costantino a Domokos del suo arrivo; questi lo invitava a raggiungerlo senza ritardo. A Domokos la Legione garibaldina fu posta sotto gli ordini del generale di divisione Mauromichaelis.
La mattina del 17 maggio l'esercito turco, forte di settantamila uomini, diviso in cinque divisioni, con movimento aggirante attaccava l'esercito greco, di appena 28 mila combattenti.
L'attacco più accanito si svolse nel centro, contro le trincee intorno a Domokos, tenute validamente dalle truppe greche comandate dal generale Mauromichaelis, che da prode vi lasciava la vita.
A questo combattimento prese parte il 1o battaglione garibaldino comandato dal Mereu, che vi perdette ben 50 circa dei suoi valorosi[432] fra morti e gravemente feriti. Per la morte del generale Mauromichaelis che le comandava, e per il numero preponderante del nemico, le truppe greche dovettero abbandonare le trincee di Domokos. Da quel momento la battaglia poteva dirsi finita, perché il principe ereditario, a notte fatta metteva tutto il suo esercito in ritirata per Furca.
Mentre questo avveniva al centro, all'estrema sinistra la divisione Hairi Pachà spingeva distaccamenti con l'obiettivo di impossessarsi della strada Koto-Agoriani-Dereli-Moccoluno onde tagliare ai Greci la ritirata; mentre col grosso delle sue forze si presentava ad attaccare la piccola divisione Tertipis che occupava Balimbeni-Kasimir-Amaslar.
Contro la divisione Hairi Pachà combattevano eroicamente il 2o e 3o battaglione dei garibaldini, fiancheggiati dalla brava legione Filellenica.
Ecco come il generale Ricciotti Garibaldi descrive il combattimento.
"Indovinato il piano di attacco del generale Hairi Pachà, decisi di prendere contatto con le truppe nemiche in una specie di semicerchio[433] rientrante che faceva la pianura a piè delle colline, il cui corno destro era tenuto solamente dalla Filellenica ed il sinistro da alcuni Euzoni della divisione Jertipis.
"In mezzo a questo semicerchio vi era una collinetta isolata; e questa era la posizione che io ordinai d'occupare per tener testa alle masse nemiche; già i tiragliatori turchi più avanzati, ne avevano raggiunte le falde a destra e sinistra accogliendo la comparsa della nostra colonna con un ben nutrito fuoco. Fermate per un momento le prime compagnie dissi ai miei bravi così:
"Compagni! ricordatevi che oggi è affidato a voi l'onore e la dignità d'Italia".
"Queste poche parole furono accolte con fremito d'entusiasmo e non ebbi dubbio che questa terza generazione di Camicie Rosse sarebbe stata degna delle precedenti.
"Ordinai a Martinotti, comandante del 2o battaglione, di stendere la 1a compagnia in ordine aperto e prendere possesso a passo di corsa della collinetta—obbiettivo del nostro campo d'azione.
"Per fortuna la nostra brava 1a compagnia[434] giunse sul culmine della collina, che era attraversata da una scogliera di muro a secco, pochi minuti prima dei turchi. Arrivati alla scogliera i nostri aprirono un fuoco accelerato sul nemico—ma questi a sua volta li fulminava con fuoco incrociato.
"Fu in questo momento che accadde un fatto il quale sarà sempre un dolore per l'Italia.
"Fra i primi che giunsero sulla cresta della collina vi erano alcuni ufficiali del mio stato maggiore, tutti provvisti di fucile. Con essi si trovava il nostro Antonio Fratti. Raggiunta che ebbi in pochi minuti la sommità, mi sentii dire: Generale, Fratti è ferito! Mi rivolsi al piccolo gruppo che si allontanava col ferito, e chiesi: "Come sta Fratti?" Mi fu risposto "è morto".
"Ne sentii dolore vivissimo!
"Povero Fratti! fu destino che dovesse trovare l'estremo giaciglio là sotto un salice sulla sponda del Pentamili!
"All'apparire dei nostri il movimento in avanti del nemico si era arrestato; ma tutto il fuoco lo aveva concentrato sulla collina e le Camicie Rosse presentavano uno splendido bersaglio[435] tanto che in un momento ne caddero parecchie.
"Il capitano Capelli comandante della 1a compagnia, mio figlio Beppino ed altri sette o otto si erano già slanciati giù del pendio contro il nemico strapotente; immediatamente diedi ordine a Martinotti di abbandonare la collina e di avanzare, a passo di carica, contro il nemico.
La 2a, 3a, 4a compagnia furono spinte avanti in sostegno del movimento sulla sinistra, e quattro compagnie greche (3o battaglione comandante Martini), sulla destra.
"La sezione francese—sotto de Barre—seguì il battaglione italiano; e la sezione inglese—sotto Erio Short—si unì al battaglione greco.
"Ramos, greco, mio compagno indivisibile si mise alla testa dei suoi connazionali, e Mereu di quella della nostra destra.
"Alle 5 pomeridiane attaccati rabbiosamente, i Turchi interrompono la loro marcia in avanti, si fermano, balenano, si disordinano e infine volgono in precipitosa ritirata. Un grido si leva altissimo dalla Legione Filellenica: "Viva i garibaldini! Viva l'Italia!" Ben altro ci rimaneva da fare.[436]
"Bisognava sloggiare i Turchi che si erano trincerati in un altura detta della Madonna. Montai a cavallo; pregai il valoroso capitano Varatassis, comandante la Legione Filellenica, rimasta in poco più di cento, e il capitano greco Stifiliades che era venuto a mettere a mia disposizione una compagnia di truppe regolari, di appoggiare la mia destra, e sostenuti alla sinistra dal 3o battaglione greco comandato da bravi ufficiali e diretto dal valoroso compagno Ramos, ordinai un attacco generale alla baionetta. Tutti con slancio ammirevole si avventarono ansanti sull'erta posizione nemica, ma i Turchi non aspettarono l'ardito e furioso assalto, abbandonarono la posizione e si diedero alla fuga.
Il sole era tramontato—le fucilate erano cessate—ed anche l'artiglieria taceva—ormai non vi era da fare altro che ritornare ai villaggi per pernottarvi.
"Le trombe suonarono a raccolta e da tutte le parti venivano gruppi di camicie rosse gridando evviva—ebbri tutti di un immenso entusiasmo.
"La prova era superata e splendidamente superata.[437]
"La camicia rossa aveva scritto un'altra pagina non indegna di figurare accanto alle altre gloriose; e l'Italia nostra poteva andare superba di questa nuova generazione dei suoi figli. Avevano combattuto uno contro sette e non erano stati vinti!
"Verso l'una del mattino mi venne l'ordine di ritirarmi per la via di Dranitz a Lamia—e mi si diede notizia che tutto l'esercito greco si ritirava".
Ma il generale Ricciotti Garibaldi non volle abbandonare il campo prima di avere raccolti i feriti e fatto un convoglio di trasporti. E prima di tutto volle rendere l'estremo tributo al valoroso compagno Antonio Fratti dandogli onorata sepoltura. Fu preparata dai compagni la fossa e con mestizia di tutti venne sepolto sotto ad un salice vicino al ruscello Pentamili!
Fra i morti caduti nel combattimento di Domokos—va ricordato un giovane valorosissimo—Oreste Tomassi—degno figlio del maggiore Adolfo Galanti Tomassi che nel combattimento di Milazzo e del Volturno si meritava decorazioni al valore e promozioni.[438]
L'Oreste Tomassi laureato a Camerino e nell'università di Bologna aveva 25 anni.—Si trovava a Vienna per affari—quando saputo che la Grecia aveva impugnato le armi contro la Turchia abbandonava ogni cosa e correva a Trieste per imbarcarsi il 22 aprile pel Pireo. Ecco come il valente giovane dava al padre notizia della sua decisione
Atene 19 aprile (1 maggio) 1897.
Caro Papà.
"Non so se avrai già ricevuto da Mario la notizia della mia partenza per la Grecia. Partii da Vienna il giorno 20 aprile e m'imbarcai a Trieste domenica passata; presentemente mi trovo qui in Atene dove sono arrivato oggi stesso insieme ad una numerosa legione d'italiani accorsi da tutte le parti del regno. Ci fermeremo qui probabilmente fino dopo domani per aspettare l'arrivo di Menotti Garibaldi; onde partire unitamente a un'altra legione di volontari per l'Epiro. Potremo essere in tutti circa tremila. Ricciotti Garibaldi ci ha fatta formale promessa di mandarci in prima linea, volendo il governo greco procurarci questo onore.[439]
"Figlio di un garibaldino—figlio di un soldato della libertà e dell'indipendenza d'Italia—ho creduto di fare semplicemente il mio dovere di accorrere ad arruolarmi per una nazione che combatte per gli stessi ideali per cui ha combattuto mio padre. Non dirmi che ho fatto male, perchè tu pure studente e figlio prediletto—abbandonasti studi e famiglia per una causa consimile.
"Se io morrò credo fermamente che tu saprai sopportare dignitosamente il dolore che ti potrò arrecare. A mamma dille che non è poi certo che io debba morire—e che se anche ciò fosse, si consoli pensando che sarò morto bene. Papà—sono Garibaldino!—Mentre ti scrivo vesto la leggendaria camicia rossa—se io morrò con questa camicia ne dovrete essere orgogliosi!—Se ritornerò che orgoglio per voi e per me! Saluta tutti i fratelli e sorelle—che in questa lettera voglio nominarli tutti—pensando che forse sarà l'ultima".
E fu l'ultima davvero! Ma quale soddisfazione—quale orgoglio per il padre suo—per la sua famiglia! E quale gaudio per noi vecchi nel vedere come i nostri figli sanno far loro i nostri ideali.[440]
O giovani d'Italia che portate in cuore sentimenti così elevati, siate benedetti!
Il generale Ricciotti Garibaldi così scriveva per dare notizia al padre dell'eroica morte del suo Oreste:
"Egregio Sig. Adolfo Tomassi,
"Compio il doloroso dovere di spedirle il congedo del suo caro estinto.
"E mentre la prego di accettare le mie più sincere condoglianze, Le sia di conforto il pensiero che il suo Oreste—morendo da valoroso sul campo, ove si combatteva per l'umanità—ha insieme ai suoi compagni provato che nella razza italiana non sono estinte quelle qualità che resero così gloriosa la generazione passata.
"Il nome di suo figlio prenderà posto nella storia—tra i più gloriosi—come uno—che con il suo valore e il suo sacrifizio—iniziò un'era nuova di gloria—per la nostra gioventù—e questo è l'unico conforto che accompagnerà noi vecchi nel mondo al di là".
Sempre dev.mo Suo
Ricciotti Garibaldi.
"Corpo volontari italiani in Grecia.
"Si certifica che Tomassi Oreste ha preso parte alla campagna di Grecia dell'anno 1897 nella qualità di caporale..... e fu presente ai fatti d'armi di Domokos. Morto da valoroso sul campo di battaglia".
Atene, 27 maggio 1897.
Il comandante del corpo
Ricciotti Garibaldi.
Il colonnello: Luciano Mereu.
"Legation royale de Grece.
"Il R. Incaricato d'affari della Grecia esprime il suo più vivo rincrescimento d'essere impedito, per causa di malattia, di assistere alla commemorazione che si terrà questa sera in memoria del compianto filelleno Oreste Tomassi, valorosamente caduto nella battaglia di Domokos".
Vienna, 31 maggio—12 giugno 1897.
[442]
Ai Preg.mi Signori
Signori Costiglioni
Cofler e De Hoeberth
Vienna.
Portato l'ultimo tributo alla sepoltura del valoroso amico, e mandato l'estremo saluto ai valorosi che erano caduti combattendo per una santa causa, la colonna, che fra morti, feriti e scorte era ridotta a circa 450 uomini, prese la strada di Panaghia. Così finì la breve campagna di Grecia del 1897.
Dopo altre peripezie, che non torna conto di ridire—la brava Legione che aveva onorato anche una volta il nome italiano, e tenuto alto il prestigio della camicia rossa, ritornava in patria.
Questi sono i caduti morti nella battaglia di Domokos, gloriosa per i garibaldini: Antonio Fratti, Antonio Pini, Giovanni Capra, Ugo Silvestrini, Alfredo Antinori, Filippo Bellini, Ettore Panseri, Pio Simoni, Michele Frappampina, Guido Cappelli, Alarico Silvestri, Enrico Mancini, Oreste Tomassi, Francesco Fraternali, Romolo Garroni, Massimiliano Tombelli.
Onore ad Essi![443]
La piaga dolorosa lasciata sul cuore della nazione dalla disfatta d'Adua andavasi cicatrizzando, allorquando da un gravissimo lutto doveva essere colpita l'Italia tutta;
Il 29 luglio del 1900—giorno nefasto—il mondo esterefatto udiva l'orribile notizia—A Monza, moriva assassinato da belva umana Umberto Io Re d'Italia—il Re che amava il popolo suo come padre il più amoroso! il più benefico!
Chi può ricordare senza fremere la data della sera infame nella quale Umberto di Savoia—forma ideale di bontà—in mezzo ad una festa di popolo alla quale fidente aveva voluto prendere parte—a tradimento—fra le ombre notturne—veniva ucciso dall'arma parricida d'un italiano? Fu il più grande misfatto che tigre sitibonda di sangue potesse perpetrare!
Umberto Io nel morire deve avere pensato—che meglio sarebbe stato cadere fra il fragore delle armi e lo squillar delle trombe nel 1866—quando fra i suoi compagni combatteva da[444] eroe nella disgraziata ma pur gloriosa giornata di Custozza, col pensiero rivolto alle terre italiane irredente—aspettanti di essere unite alla madre patria—sempre fidenti!
Incancellabile durerà in noi il ricordo dell'esecrando delitto—e il popolo italiano che vivo l'amò tanto—sente che il ricordo di Lui forma ormai la parte più cara della sua coscienza.
"Date lacrime ed onori alla sua sacra memoria".
Questo fu il Vostro voto Sire! quando saliste sul trono del Padre della Patria e di Umberto I il Re Buono—e il popolo come una eco alle parole del Vostro cuore addolorato—spinto da sentimento unanime—glorificando la memoria del Re estinto, faceva nel tempo stesso solenne affermazione plebiscitaria di affetto per Voi Emanuele III nostro Re e per la Vostra Casa.
E le dimostrazioni di vivo rimpianto di tutto un popolo, sia per Voi—Regina Margherita—tanto amata dal lacrimato Re—di conforto al Vostro cuore d'italiana e di madre.
L'Italia vi ha consacrata alla sua venerazione![445]
Ecco il primo ordine del giorno esprimente alti sentimenti patriottici e civili che il Re Vittorio Emanuele III emanava in occasione della sua assunzione al trono.
Ufficiali, sott'ufficiali e soldati dell'Esercito e dell'Armata!
"L'intiero mondo civile ha udito con indignazione la tragica fine del compianto mio genitore.
"Il dolore della Nazione si è certamente ripercosso nei vostri cuori di buoni e fedeli soldati. In questo momento il mio pensiero si rivolge fidente a voi tutti, certo che riporterete su di me l'affetto col quale circondavate il Re Umberto, affetto che, seguendo l'esempio paterno, con cuore di soldato, io vi ricambio.
"E con voi il mio pensiero si rivolge ai vostri compagni, che in Creta, nell'Eritrea ed in Cina mostrando le tradizionali qualità di soldati italiani, tengono alta la gloriosa bandiera[446] nazionale simbolo della grandezza e dell'unità della nostra patria".
Da Monza 1o agosto 1900.
Vittorio Emanuele III.
Ecco come si commemorava alla Camera la morte di S. M. Umberto I Re d'Italia.
Il giorno 6 agosto il presidente onorevole Villa—dava partecipazione alla Camera dell'esecrando delitto colle seguenti parole che tutti i deputati profondamente commossi ascoltavano in piedi:
"Onorevoli colleghi! Umberto I, l'amato nostro Re, non è più! La mano sacrilega di un assassino si è levata su lui e là in Monza, in mezzo al popolo che lo salutava plaudente con le più schiette manifestazioni della gratitudine e dell'affetto, ne spezzava freddamente il cuore.
"Non la mia povera parola varrebbe oggi a dirvi della immane sventura che ci ha colpiti; non io saprei degnamente evocare dinanzi agli occhi del cuore, impietrito dal dolore, l'immagine del Re barbaramente assassinato; non io potrei[447] dirvi di questo gran martire della carità, che l'odio settario ha, nel suo insaziabile istinto di rovine e di sangue vigliaccamente sacrificato. (Benissimo!)
"No!... Ma io sento che parla per me la voce di tutto un popolo che lo amava (Benissimo!) e lo benediva; di un popolo intero che dagli alti palazzi, come dai più umili casolari, dai più remoti angoli del paese, dalle officine e dai campi, si leva esterrefatto fra le lagrime e le preghiere e nell'impeto delle sante ire maledice ai sicarî. (Vivissime approvazioni).
"No!... Ma io sento che echeggia qui nel cuore di tutti noi la voce immensa di tutto il mondo civile che, piangendo desolato o concorde la caduta di un Eroe vilmente fulminato da un assassino, solleva un grido di esecrazione e di allarme contro quel cosmopolitismo feroce e sanguinario che, calpestando ogni alta idealità della vita umana e ponendosi in aperta rivolta contro ogni santa manifestazione della carità e dell'amore, non si arresta neppure dinnanzi al parricidio. (Vivissime approvazioni).
"No, io sento raccolta qui negli animi nostri la parola dolcissima di quella grande Addolorata[448] che, dopo di aver portato nella Reggia il fascino della grazia e della bontà, dà oggi nelle veglie del dolore l'esempio di una forza e di una virtù, ammirande; (Vivissime approvazioni—prolungati applausi) non dimentica mai, fra le angoscie dell'anima, nè dei doveri di madre, nè di quelli che la stringono alla nazione che essa ama, e dalla quale è riamata, e non invocando da Dio che la grazia suprema della rassegnazione. (Benissimo!)
"Era buono... non fece mai male a nessuno. È il più gran delitto del secolo! E in queste parole che proruppero dal cuore della donna e della Regina, è la sintesi dolorosa e solenne di quella terribile tragedia, che ebbe il suo epilogo nella notte fatale del 29 luglio. (Bravo!)
"Era buono. Sì, buono di quella bontà che è il compendio di tutte le virtù; di quella bontà che riunisce e rispecchia le più eminenti doti dell'intelletto e del cuore in tutti i rapporti della vita morale e civile. (Benissimo!)
"Era buono; e lo provò prima ancora di assumere le alte responsabilità della Corona, conformando tutta la sua vita alle austere discipline del dovere, assecondando con sentimento di devozione

la volontà del padre, seguendone fedele gli esempi e avventurando la vita con lui e col fratello sui campi di Lombardia per la causa italiana. (Benissimo! Bravo!)
"Io non ambisco—così Egli diceva ai rappresentanti della Nazione, nell'atto di cingere la Corona: Io non ambisco che meritare questa lode: Egli fu degno del padre". E nella omerica semplicità di queste parole Egli scolpiva tutto l'animo suo. (Approvazioni).
"Era buono; e lo provò durante i ventidue anni di regno, non ismentendo mai quella che fu la costante preoccupazione di tutta la sua vita; di mantenere, cioè, fede rigorosa alle istituzioni. Re costituzionale, egli non si lasciò mai sedurre dal pensiero di potersi in qualche modo porre in contrasto con quell'indirizzo di Governo che gli poteva essere segnato dalla volontà della nazione. Religioso osservatore della legge, egli sentiva tutti i doveri che si impongono al Sovrano nell'alto ufficio che gli è affidato, di essere moderatore imparziale fra l'urto dei partiti che intendono a fecondare con nuovi elementi l'attività politica ed economica dello Stato. Passarono sopra di noi turbini e procelle spaventose[450] gravi sventure colpirono il cuore della nazione, egli non disperò mai della patria; nè dubitò mai della virtù italiana; ma richiamando serenamente il paese alla coscienza della sua forza e al culto della libertà, proclamò sempre la sua fede costante nelle Istituzioni "essere esse la salvaguardia contro ogni pericolo; in esse la prosperità e la grandezza della patria". (Vivissime approvazioni—Vivi e prolungati applausi.)
"Non fece mai del male a nessuno. E come lo avrebbe potuto? Egli passò beneficando. Non fu pubblica sventura nella quale egli non abbia saputo manifestare tutto l'inesauribile tesoro di bontà che aveva nel cuore. Lo vedete impavido in mezzo ai pericoli, affrontare la terribile malattia quando è più fitta l'ecatombe delle vite e più fiero l'imperversare del flagello; impaziente sempre di giungere fra i primi a portare una parola di conforto e un soccorso ai derelitti colpiti dalla sciagura. Non vi è miseria alla quale egli non sappia apprestare un riparo. Negli asili come negli ospedali egli accorre colla coscienza di dover adempiere ad un dovere di umanità e con la stessa fede con cui vi accorre una suora di carità.[451]
"Io porrò negli umili la gloria del mio regno. Con queste parole egli riassumeva tutto il suo cuore, tutto lo scopo al quale avrebbe desiderato fossero rivolte le cure del Governo; l'intento sommo che egli sperava di poter raggiungere. E lo provava accordando largo concorso di sovvenzioni ad Istituti di previdenza, Casse di lavoro, Associazione cooperative, ogni opera diretta ad allievare le necessità dei più umili. Lo provava mostrandosi sempre devoto alla causa degli operai, mescolandosi con questi con confidente famigliarità; mostrando la più viva sollecitudine per i loro interessi e per quelli delle loro famiglie; avendo per tutti una stretta di mano, una parola amica, un sorriso che infondeva in ogni cuore un sentimento di fiducia e di ossequio.
"Era buono e non di meno vi fu chi ha potuto concepire il truce pensiero di farne scempio!
"E vi è stato chi ha potuto freddamente, roteare sopra quel petto, sul quale brillavano le insigne del valore, i tre colpi mortali!
"E vi fu chi pensò di scegliere con ributtante audacia a teatro dell'opera scellerata ed infame quello stesso luogo e quell'ora stessa, in cui il[452] plauso popolare salutava il Re buono, leale e generoso; conculcando l'autorità sovrana ed insultando ad un tempo l'affetto popolare, (vivi e prolungati applausi).
"È il più gran delitto del Secolo. Sì: è la brutale malvagità che, mentre sfoga il suo istinto di sangue distruggendo la più nobile delle esistenze conculca nel tempo stesso la più alta personificazione dell'autorità della legge, della maestà della nazione, del diritto sociale, della giustizia, e insulta ad un tempo il sentimento popolare nella più elevata sua manifestazione. (Vivi e prolungati applausi).
"È la brutale malvagità alimentata ed ordinata a sistema contro ogni ordine sociale: distruggere per distruggere. Lusingansi forse i dissennati, di poter con le loro opere di sangue attentare a quella grande espressione di forza che è la Monarchia italiana; ed offendere quel prezioso coacervo di volontà, di aspirazioni, di energie che è rappresentato dalla Dinastia di Savoia? (Vive approvazioni).
"No; il Re non muore (Prolungati applausi e grida ripetute di: Viva il Re!) e il sangue dei martiri fortifica la fede dei superstiti. (Prolungati applausi).[453]
"Il Re non muore; Umberto rivive nel figlio suo. Vittorio Emanuele III raccoglie la Corona insanguinata per continuare imperterrito e con la stessa fede quella missione di pace e giustizia, che l'Augusto suo Genitore si era prefisso. (Vive approvazioni). Contro questa legge indefettibile, della continuità giuridica e morale della Monarchia, che la coscienza del popolo ha con mirabile concordia riconosciuta, non vi è opera di sette, non vi è opera di violenti che possa prevalere. (Vivi e prolungati applausi—grida ripetute di: Viva il Re!)
"Grandi doveri però c'incombono, ai quali la nostra coscienza non può mancare. Noi sentiamo che la vita morale della Nazione è turbata da dissesti morbosi; noi sentiamo che vi è nell'organismo sociale qualche cosa che fallisce alla regolarità e sincerità delle sue funzioni. Al più grande dei delitti del secolo, perpetrato su di una pubblica piazza assiepata di popolo e contro la più nobile delle vite, si collegano responsabilità morali più o meno dirette, più o meno prossime che possono dipendere dagli imperfetti organismi della nostra vita giuridica ed amministrativa. (Vive approvazioni).[454]
"Bisogna richiamare il paese all'osservanza rigorosa della legge. (Vive approvazioni—applausi). Bisogna modificare, correggere i nostri istituti educativi, far penetrare nelle masse il sentimento del dovere; richiamarle agli alti ideali della patria e della famiglia; dare a tutti e in tutto quella giustizia che è il supremo bisogno dei popoli. (Applausi unanimi e prolungati).
"Con questi intendimenti raccogliamoci attorno al giovine Re sul quale l'occhio del padre e della madre posavansi con tanto affetto e che sollevando la bandiera abbrunata della patria, intende con animo sicuro verso la meta segnatagli dal padre e dalle tradizioni della sua Casa. Raccogliamoci attorno ad esso al grido di: Viva il Re (Vivi e prolungati applausi,—grida di: Viva il Re!) Questo grido che mi prorompe dall'animo è l'espressione più pura dell'unità della patria, la manifestazione più alta della sua forza morale e della maestà e della grandezza del nome italiano, purificati da ogni contrasto regionale. Da qui l'avvenire della patria, da qui l'espiazione, che darà la pace alle nostre coscienze e al paese la sua unità morale e la coscienza della sua missione. (Applausi generali e prolungati.—Grida ripetute di: Viva il Re!)[455]
Così parlava l'onorevole Saracco, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.
Signori deputati! Mi onoro di annunciare alla Camera, che S. M. il Re, con decreto del 2 agosto, ha confermato me nell'ufficio di presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i miei colleghi nelle loro rispettive funzioni. Spetta perciò a me di compiere il mestissimo ufficio di associarmi, in nome del Governo, ai sentimenti d'indignazione e di dolore, espressi con rara eloquenza dal vostro degno presidente.
"Mi associo a questi sentimenti coll'animo più che con le parole; le quali non bastano a significare la commozione profonda o il cordoglio che mi strazia.
"Io, che vidi le origini del nuovo Regno, e presi parte a tutte le vicende fortunate, per cui il piccolo Piemonte si trasformò nella Grande Patria Italiana, non avrei mai creduto di viver tanto per assistere alla strage del mio Re. (Bravo! Bene!)
"Ciò che più mi cruccia è il pensiero che la sua vita preziosissima fu troncata dalla mano d'italiano. (Bravo!—Approvazioni)
"Se la maledizione del popolo non avesse raggiunto[456] il parricida, se non gli pendesse inesorabile sul capo la maledizione di Dio e di tutto il mondo civile, vorrei anch'io, con le lagrime negli occhi e con lo sdegno nel cuore, esecrare e maledire questa belva in figura d'uomo. (Benissimo!—Vive approvazioni).
"Ma debbo far forza a me stesso e, come capo del Governo, imporre freno all'indignazione che mi trabocca dall'animo, imitando l'esempio di forte serenità che ci viene dall'Augusto Successore.
"Raccolti nel dolore, prostriamoci innanzi al feretro del Re leale, buono e generoso, soldato per la patria per l'umanità, del Re che riassumeva le virtù civili e militari della sua eroica stirpe; del Re che fu sempre fortunato interprete dei sentimenti e delle aspirazioni del suo popolo, cui lascia tanta e così larga eredità di affetti.
"L'universale compianto che lo accompagna nel sepolcro è il giusto premio di una vita tutta spesa nello adempimento del dovere e dedicata al benessere ed alla felicità del suo popolo.
"La fine crudele toccata al più giusto al più umano dei Sovrani deve ispirarci, gravi riflessioni e suscitare virili propositi.[457]
"Di fronte alla frequenza di così mostruosi e brutali delitti che, senza odio e senza motivo, prendono di mira le più innocenti e le più elevate esistenze; di fronte alle minaccie incalzanti e feroci di una classe di degenerati senza patria, senza umanità e senza Dio; (Benissimo!—Vivissime approvazioni) che sognano di rinnovare la società seppelendola sotto le sue rovine; in mezzo a tanto agitarsi di malsane passioni e di appetiti sfrenati, che avvelenano l'ambiente e turbano la pubblica coscienza, non è lecito al Governo rimanere impassibile; (Benissimo!—Bravo!) non potete restare impassibili voi, onorevoli deputati, cui sono connesse le sorti di una così nobile e civile nazione, grande nei suoi slanci patriottici, generosa e cavalleresca nei suoi sentimenti. (Bene!)
"Non è possibile che nel seno di questo bel paese continui a fecondarsi il reo seme che ha dato frutti così funesti e ne prepara di peggiori per l'avvenire. (Benissimo!)
"Tutti coloro che, come noi, son convinti essere la Monarchia la sola forza con la quale il nostro paese può tenersi unito e prosperare, (Benissimo!) hanno l'obbligo di stringersi insieme[458] per studiare e per preparare i mezzi acconci a prevenire le funeste esplosioni di un fanatismo cieco, che minacciano il ritorno di una barbaria nuova e senza nome (Approvazioni).
"È questo il compito che i nuovi pericoli impongono al Governo ed al Parlamento, consci della loro missione e solleciti dell'onore, della sicurezza e dell'avvenire del paese. (Benissimo!)
"Dopo mezzo secolo di vita politica, attraverso tante vicende, non ho mai perduta la fede nei benefizi della libertà, che fu la leva del nostro risorgimento e la pietra angolare del nostro Regno; (Benissimo!) ma, per assicurarla e garantirla, occorre impedire con mano ferma ed energica che nell'ombra e sotto il pretesto della libertà si sovvertano gli ordini dello Stato. (Benissimo—Vivi applausi!) e si mettano in serio pericolo le conquiste della civiltà e del progresso. (Benissimo!)
"L'immensa sventura che ci strappa così amare lacrime, sia per noi un salutare lavacro che purifichi gli spiriti e unisca gli animi alla comune difesa.
"Sarà questo l'omaggio più degno che possiamo[459] rendere alla venerata memoria del compianto Sovrano ed il saluto augurale dell'Augusto Successore che, giovane ed animoso, seguita sul trono le orme luminose del Padre e dei suoi Grandi Avi.
"I vecchi hanno data una Patria e un glorioso retaggio da custodire; spetta a voi giovani di conservarlo ed accrescerlo con la fede robusta, collo spirito di sacrifizio e col sentimento di solidarietà, che levarono l'Italia alla presente fortuna. (Benissimo!—Vive approvazioni—Vivi e prolungati applausi). Il presidente della Camera dà comunicazione dei seguenti telegrammi.
Monsieur le Président,
Profondément ému par le crime exécrable qui met en deuil l'Italie et le monde civilisé, je prie Votre Excellence d'agréer l'expression de mes plus vives sympathies. Je suis assurè d'être l'interprète des sentiments de mes collègues en vous adressant le temoignage de notre tristesse. Les deux nations se sentent unies une fois de plus par les mêmes douleurs.—Paul Deschanel."—(Vivissimi e prolungati applausi).
"L'Union Interparlementaire pour l'arbitrage international et la paix réunie en conference à[460] Paris, s'associant au deuil de la nation Italienne et protestant avec indignation contre l'odieux attentat dont Roi Humbert a été victime, a l'honneur d'offerir a Monsieur le Président de la Cambre des Députés l'hommage respectueux de ses sincéres condoleances.—Le Président de la Conference, Faillieres, Président du Senat."—(Applausi).
"Profondément émus du deuil qui frappe l'Italie, nous vous envoyons nos compliments de condoléance et bien douloureuse sympathie au nom de l'Union des Commissaires étrangers.—Robert Raffalovich Asbeck Spearman."—(Bene!)
"Le crime abominable qui plonge en deuil l'umanité entière m'a causé une grande douleur. Sûr d'être le fidèle interprète de ces mêmes sentiments de tous mes collègues, j'esprime à Votre Excellence nos sympathies et l'assurance de la part immense que nous prenons dans la douleur de tout la nation italienne.—Ietcho Bakaloff, Président de la Chambre des Députés de Bulgarie."—(Bene!)
"Dopo aver ascoltate le seguenti parole pronunciate nella seduta d'oggi, la Camera che ho[461] l'onore di presiedere ha deliberato che esse siano trasmesse a V. S. come fedele espressione dei suoi sentimenti, nonchè di quelli della nazione Argentina:
"Signori deputati, il telegrafo annuncia che Sua Maestà Umberto I, il virtuoso e magnanimo Re d'Italia cadde vilmente assassinato. Credo rendermi fedele interprete dei sentimenti della Camera dei deputati della Nazione Argentina esecrando il barbaro attentato che deve essere energicamente riprovato da tutti i popoli civili del mondo in omaggio alla memoria dell'illustre Re, che fu sicuro e costante amico della nostra patria (Applausi).
"In considerazione del dolore che grava sul nostro spirito per la perdita che ha sofferto la nobile nazione italiana e quella parte dei suoi sudditi che abitano il nostro paese e che in fraterna unione con noi lavora alla sua prosperità e al suo ingrandimento propongo si levi la seduta."
"Saluto Lei, signor presidente, con la più distinta considerazione.—Marco Avellaneda, presidente; Alessandro Sorondo, segretario". (Vivissimi applausi).[462]
"La Camera dei deputati del Brasile, profondamente commossa per il luttuoso avvenimento di cui fu vittima il Re Umberto, associandosi al dolore che ha ferito il cuore del popolo italiano, votò una mozione di compianto sospendendo le sue sedute, e presenta le sue condoglianze.—Carlos Vaz Mello, presidente della Camera".—(Approvazioni).
"La Camera dei deputati del Perù si associa al dolore del Parlamento italiano per l'assassinio del Re Umberto.—Carlos de Pierola, deputato-presidente". (Bene!).
"La Camera dei deputati del Chili ha deliberato esprimere a codesta Camera, per mezzo di Vostra Eccellenza, il suo dolore per la disgrazia che affligge la nazione italiana.—Carlos Palecios, presidente; Rafael Brako, segretario".—(Bene!).
"In nome partito Indipendenza, costituente due terzi della Opposizione Parlamentare Ungherese, esprimo profondo dolore perdita impareggiabile Re e nobilissimo uomo, augurando felicità nazione italiana.—Francesco Kossuth, presidente".—(Vivissimi applausi).
Da ogni parte del mondo pervennero telegrammi d'esecrazione per l'orrendo misfatto.[463]
L'11 agosto 1900 dopo aver dato il giuramento prescritto dall'art. 22 dello Statuto del Regno S. M. il Re Vittorio Emanuele III pronunziava alle Camere riunite in Senato il seguente discorso:
Signori Senatori, Signori Deputati!
"Il Mio primo pensiero è pel Mio popolo, ed è pensiero di amore e di gratitudine.
"Il popolo che ha pianto sul feretro del suo Re; che affettuoso e fidente si è stretto intorno alla Mia Persona, ha dimostrato quali salde radici abbia nel Paese la Monarchia liberale (Applausi fragorosi—grida di Viva il Re!)
"Da questo plebiscito di dolore traggo i migliori auspici del Mio Regno.
"La nota nobile e pietosa, che sgorgò spontanea dall'anima della Nazione all'annunzio del tragico evento Mi dice, che vibra ancora nel cuore degli Italiani la voce del patriottismo, che inspirò in ogni tempo miracoli di valore (Applausi). Sono orgoglioso di poterla raccogliere.
"Quando un popolo ha scritto nel libro della Storia una pagina come quella del nostro Risorgimento, ha diritto di tenere alta la fronte e di mirare alle più grandi idealità (Applausi). Ed è[464] a fronte alta, e mirando alle più grandi idealità, che Mi consacro al Mio Paese con tutta l'effusione ed il vigore di cui Mi sento capace (Applausi), con tutta la forza che Mi danno gli esempi e le tradizioni della Mia Casa (Applausi vivissimi).
"Sacra fu la parola del Magnanimo Carlo Alberto, che largì la libertà: sacra quella del Mio Grande Avo, che compì l'unità d'Italia. Sacra altresì la parola del Mio Augusto Genitore, che in tutti gli atti della sua vita, si mostrò degno erede delle virtù del Padre della Patria (Vivissimi e prolungati applausi—grida di Viva il Re! Viva Casa Savoja!)
"All'opera del Mio Genitore diede ausilio, ed aggiunse grazia e splendore quella della Mia Augusta e Venerata Genitrice, (Lunga ovazione e grida di Viva la Regina Margherita) che Mi istillò nel cuore e Mi impresse nella mente il sentimento del dovere di Principe e di Italiano (Applausi vivissimi). Così all'opera Mia si aggiungerà, quella della Mia Augusta Consorte, che nata anch'Essa da forte prosapia, si dedicherà intieramente alla Sua Patria di elezione. (Applausi ripetuti e grida di Viva la Regina).
"Dell'amicizia di tutte le Potenze abbiamo[465] eloquente prova nella partecipazione al Nostro lutto coll'intervento di Augusti Principi e di Illustri Rappresentanti; (Applausi) ed Io mi dichiaro a tutte profondamente grato.
"L'Italia fu sempre efficace strumento di concordia, e tale sarà altresì durante il Mio Regno, nel fine comune della conservazione della pace. (Approvazioni).
"Ma non basta la pace esteriore. A noi bisogna la pace interna, (Vivi e prolungati applausi—grida di Viva il Re), e la concordia di tutti gli uomini di buon volere, per isvolgere le nostre forze intellettuali e le nostre energie economiche. (Approvazioni).
"Educhiamo le nostre generazioni al culto della Patria (Approvazioni), all'onesta operosità, al sentimento dell'onore (Benissimo!); a quel sentimento a cui s'inspirano con tanto slancio il Nostro Esercito e la nostra Armata (Applausi prolungati—grida di Viva l'Esercito, Viva l'Armata), che vengono dal popolo e sono pegno di fratellanza, che congiunge nell'unità e nell'amore della Patria tutta intiera la Famiglia Italiana. (Lunghe e prolungate ovazioni).
"Raccogliamoci e difendiamoci con la sapienza[466] delle leggi e colla rigorosa loro applicazione (Applausi vivissimi). Monarchia e Parlamento procedano solidali in quest'opera salutare. (Benissimo!)
Signori Senatori. Signori Deputati!
"Impavido e securo ascendo al Trono (Ovazione lunghissima; grida ripetute di Viva il Re) con la coscienza de' Miei diritti e doveri di Re (Triplice salva di applausi).
"È necessario vigilare e spiegare tutte le forze vive, per conservare intatte le grandi conquiste dell'unità e della libertà (Applausi). Non mancherà mai in Me la più serena fiducia nei nostri liberali ordinamenti (Applausi), e non Mi mancherà la forte iniziativa e la energia dell'azione (Grande ovazione e grida ripetute di Viva il Re), per difendere vigorosamente le gloriose Istituzioni del Paese, retaggio prezioso de Nostri maggiori (Approvazioni).
"Cresciuto nell'amore della Religione e della Patria, invoco Dio in testimonio della mia promessa, (Triplice salva di applausi e grida di Viva il Re!) che da oggi in poi il Mio cuore, la Mia mente, la Mia vita offro alla grandezza ed alla prosperità della Patria. (Lunga ovazione che dura[467] per parecchi minuti e grida ripetute di Viva il Re Viva la Regina, Viva Casa Savoia).
Parole esprimenti alti sentimenti patriottici degne del discendente dell'Avo immortale—Il Padre della Patria—e del Re Buono suo magnanimo genitore Umberto I.
Giunto alla fine di questi ricordi che sono una eco di storia ripercuotentesi intorno a me—e che riassumono pagine di vita vissuta nelle grandi ore per la libertà della patria—si affollano alla mente mia le sembianze care e gloriose di tutti i compagni dei giorni eroici e lontani—le immagini dei pochi superstiti—dei molteplici morti—dei saliti in alto sulle cime della rinomanza—degli umili rimasti oscuri, non ostante il sagrifizio del sangue e l'altezza divina del sogno!
Amici, compagni, sacre legioni di combattenti, come appaiono lontani i tempi nei quali vibrava così piena, così fulgente, così feconda la giovinezza dei nostri cuori e la visione bella dell'Italia sorgente! Quanto appaiono lontani! e come sono diversi da quelli d'ora.
Eppure anche oggi non mancano alti e nobili[468] ideali che s'impongono alla mente ed al cuore delle nuove generazioni!
Per noi, vecchi—nessuna cosa quaggiù, fu ed è più cara della patria! neppur la famiglia che è pur tanta parte di noi stessi.
L'Italia—una—indipendente—forte—fu il nostro ideale—e nessun sagrifizio ci parve abbastanza grande perchè questo ideale fosse raggiunto.
E Voi giovani non sarete da meno dei vecchi padri vostri—come noi—voi pure sentite nell'anima agitarsi prepotente l'amore della patria—voi pure sentite che la terra sacra a cui natura pose i confini che Dante scolpì nel verso immortale, aspetta anche qualche cosa da Voi—Voi sentite che dal monte e dal mare sospirano cuori fraterni, invocanti libertà di lingua, di costumi e di coscienza e comprendete che non è piccolo ideale il completare la grand'opera che fu cementata col sangue dei padri vostri!
Col progredire dei tempi è giusto che nuovi problemi si agitino; che nuove correnti siano determinate dalla forza e dalla fede dei giovani—ma ciò deve raggiungersi senza rinnegare quello che è fondamento alla vita delle Nazioni; la custodia[469] gelosa delle conquiste fatte; l'autorità sempre ferma contro coloro che in un campo o nell'altro cercano minare la sicurezza della patria e diminuirne il sentimento o la dignità.
O giovani, credetelo! I grandi problemi sociali non si risolvono con l'appello all'odio, alle ire, alle malvagità; chi questo consiglia è nemico di ogni civile progresso—è nemico del popolo, di cui si vanta di propugnare la causa.
O giovani, i vostri padri vi hanno dato una patria che dalle brutture dell'oppressione e della tirannia, in breve volgere d'anni è giunta a tale altezza da meritare le maggiori considerazioni fra i popoli civili.
Ispirandovi all'esempio del passato, attingendo sempre maggior fiducia nella giovinezza del paese, personificata nella giovinezza del Re, a cui l'età ha concesso la provvida vigoria degli impulsi rinnovatori, e il carattere e l'intelletto hanno dato la saggezza e la maturità che affida, non avete che a serrarvi intorno a lui, sicuri che Egli condurrà la patria verso i suoi gloriosi destini.
Stringetevi, o giovani intorno al Re Vittorio Emanuele III che, raccolta la Corona nel sangue paterno, seppe anche far scaturire dal cuore e[470] dalla volontà Sua tanta luce di nobili propositi, tanta fiamma di affetti generosi, tanta coscienza della tradizione storica e dell'ufficio che i nuovi tempi domandano!
A noi generazione morente colla pace dell'al di là—non sorride che la speranza nei figli—che debbono—far più prospera—più concorde—la patria che adorammo e sogneremo in perpetua vittoria fin negli estremi riposi....
E ora, a Voi vecchi compagni d'arme, dei quali ho fugacemente e troppo modestamente riassunti i ricordi e gli ideali, il saluto mio pieno d'amore e di ricordi.
Fine del secondo ed ultimo volume.
| Capitolo | XIX. | — 1860—Spedizione dei mille—Marsala—Salemi Calatafimi—Palermo—Milazzo—Reggio Calabria—Napoli—Volturno | Pag. | 3 | ||
| " | XX. | — Liberazione dell'Umbria e delle Marche—Castelfidardo—Ancona | " | 101 | ||
| " | XXI. | — Ritiro di Garibaldi a Caprera. | " | 146 | ||
| " | XXII. | — Presa di Capua e di Gaeta. | " | 147 | ||
| " | XXIII. | — Aspromonte—Sollevazione in Polonia | " | 156 | ||
| " | XXIV. | — Guerra del 1866—Liberazione del Veneto | " | 182 | ||
| " | XXV. | — Campagna dell'Agro Romano—Montelibretti—Roma—Monterotondo—Mentana. | " | 253[472] | ||
| " | XXVI. | — Il 1870—Digione—Entrata in Roma | " | 303 | ||
| " | XXVII. | — Morte di Mazzini | " | 339 | ||
| " | XXVIII. | — Morte di Vittorio Emanuele II | " | 343 | ||
| " | XXIX. | — Ultimi giorni e morte del generale Garibaldi | " | 352 | ||
| " | XXX. | — Sbarco a Massaua—Guerra Abissina | " | 361 | ||
| " | XXXI. | — Volontari Italiani in Grecia | " | 424 | ||
| " | XXXII. | — Orrendo misfatto—Morte di Umberto I | " | 443 |
Ritenuta la non dubbia importanza di alcuni documenti che sono lettere del Dott. Pietro Ripari, che all'ultima ora ci pervengono, non esitiamo a pubblicarle; riferendosi essi alla memoranda giornata di Calatafimi.
Elia.
Lettera del Dott. Pietro Ripari, Capo medico dell'ambulanza dei Mille, con la quale si trasmette un'ordine del generale Garibaldi al Dottore Ignazio Lampiasi, ora deputato al Parlamento.
"Sti.mo sig. Dott. e Prof. in chirurgia
"Don Ignazio Lampiasi,
"Un ordine del generale Garibaldi mi impone di seguirlo col corpo medico dell'ambulanza.
"Dei feriti che trovansi qui in Vita, i più leggermente offesi, saranno entro oggi trasportati in Calatafimi, in quello Ospedale.[474]
"La cura dei gravi, che resteranno nel convento di S. Francesco, dovendo essere affidata a uomini esperti nell'arte, io la invito, dietro comando del Generale a volere compiacersi di assumerla Ella; la quale eventualità, le aprirà la via a far risaltare maggiormente il di Lei valore come chirurgo.
"Ella entra quindi in carica officiale fin da questo giorno e veste l'autorità mia in Vita, che non ha limiti per tutto ciò che riguarda i bisogni, i vantaggi, i comodi dei feriti, ed anche il loro vivere lauto, se avviati a convalescenza, o recati a guarigione.
"Ho l'onore di rassegnarmele con distinta stima
"Collega Dott. Pietro Ripàri
"Capo medico dell'ambulanza generale pei Cacciatori
delle Alpi in Sicilia.
"Di Lei stimatissimo sig. Dottore e Professore in chirurgia.
"Vita, 17 maggio 1860".
16 settembre 1860—Visto per la firma del Dott. Ripàri—Il Direttore dell'Ospedale Garibaldi—Gr. Ugdulena—Palermo.[475]
"Sig. Dottore stimatissimo,
"Nella di Lei lettera del 24, ricevuta oggi, da due Signori di squisiti modi e di piacevole conversare, sento da questa, che i pochi feriti rimasti alla di Lei cura, versano in condizioni di buona, e tra breve di perfetta salute, e ne godo insieme con Lei.
"Mi conforta pure il sentire che buon'aria, pulitezza ed altri conforti presta loro Salemi, ai quali vantaggi aggiungendo il di Lei noto valore dell'arte, mi rende certo della salvezza di tutti.
"Non ho potuto oggi fare parola al Generale della necessità in cui si trovano i feriti di altro denaro, ma ne terrò parola domani e credo potrò ottenere un altro ordine di pagamento di denaro per essi.
"Qui pure abbiamo a deplorare perdite dolorose di prodi che hanno suggellato col sangue il patto antico della giurata libera nazionalità d'Italia: sia lieve la terra ai generosi, e dormano l'eterno sonno avviluppati nel loro mantello di gloria.
"Mi abbia con distinta stima
"Dott. PIETRO RIPÀRI
"Capo medico".
Seguono altre lettere dello stesso Ripári e di altri che gettano molta luce sui memorabili avvenimenti di quella ambulanza.
E noi esortiamo l'on. Lampiasi di pubblicare tutti i documenti e le notizie di quel periodo memorabile nel quale egli ebbe tanta parte.
Elia.